Per amore della pace e del benessere di ognuno di noi, suggerisco un'attenta lettura del libro "Per il bene della pace. Sette sentieri verso l'armonia globale. Una prospettiva buddista" (titolo originale: "For the Sake of Peace. Seven Paths to Global Harmony. A Buddhist Perspective", edito da Middleway Press SGI-USA, Santa Monica CA, 2001), che raccoglie discorsi tenuti presso università e proposte di pace presentate all’ONU da Daisaku Ikeda dal 1976 al 2001.
I capitoli, tradotti in italiano, sono stati pubblicati a puntate sulla rivista "Buddismo e Società" tanti anni fa (da BS 88 del 2001 a BS 102 del 2004), ma i contenuti sono ancora tremendamente attuali e in grado di illuminare il nostro presente e le nostre vite. Riporto in questa pagina i link originali agli articoli di Buddismo e Società (liberamente consultabili senza bisogno di login) e, di seguito, la loro trascrizione completa. L'autorizzazione alla ripubblicazione nel presente blog è concessa dall'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.
Poiché il testo è lungo, per agevolare sia coloro che preferiscono "ascoltarlo" magari durante una passeggiata o altri momenti non impegnativi, sia coloro che sono ipovedenti o che hanno altre difficoltà di lettura, accanto ad ogni capitolo riporto un MP3 generato con un buon sintetizzatore vocale, che, pur con i suoi limiti e i suoi errori, nel complesso permette un ascolto agevole. Seguono link agli articoli originali, lista degli MP3 e la trascrizione completa del libro.
Capitoli pubblicati su Buddismo e Società:
- Prefazione (Buddismo e Società n.88 - settembre ottobre 2001)
- 1° Una prospettiva di pace (Buddismo e Società n.90 - gennaio febbraio 2002)
- 2° La via del dominio di sé (Buddismo e Società n.91 - marzo aprile 2002)
- 3° La strada del dialogo e della tolleranza (Buddismo e Società n.92 - maggio giugno 2002)
- 4° La via della comunità (Buddismo e Società n.95 - novembre dicembre 2002)
- 5.1° La via della cultura (Buddismo e Società n.96 - gennaio febbraio 2003)
- 5.2° Il sentiero delle nazioni (Buddismo e Società n.99 - luglio agosto 2003)
- 6° Il sentiero della consapevolezza (Buddismo e Società n.100 - settembre ottobre 2003)
- 7° Il sentiero del disarmo (Buddismo e Società n.102 - gennaio febbraio 2004)
Lista deli MP3 (generati con un sintetizzatore vocale):
- Sette sentieri - 0. Prefazione.mp3
- Sette sentieri - 1. Una prospettiva di pace.mp3
- Sette sentieri - 2. La via del dominio di sé.mp3
- Sette sentieri - 3. La strada del dialogo e della tolleranza.mp3
- Sette sentieri - 4. La via della comunità.mp3
- Sette sentieri - 5.1. La via della cultura.mp3
- Sette sentieri - 5.2. Il sentiero delle nazioni.mp3
- Sette sentieri - 6. Il sentiero della consapevolezza.mp3
- Sette sentieri - 7. Il sentiero del disarmo.mp3
Trascrizione completa del libro "Per il bene della pace. Sette sentieri verso l'armonia globale. Una prospettiva buddista"
Indice per saltare velocemente ad uno specifico capitolo:
- Prefazione
- 1° Una prospettiva di pace
- 2° La via del dominio di sé
- 3° La strada del dialogo e della tolleranza
- 4° La via della comunità
- 5.1° La via della cultura
- 5.2° Il sentiero delle nazioni
- 6° Il sentiero della consapevolezza
- 7° Il sentiero del disarmo
Per il bene della pace. Sette sentieri verso l'armonia globale. Una prospettiva buddista - di Daisaku Ikeda
Prefazione - AUDIO generato con un sintetizzatore vocale
 Questo articolo è la traduzione della prefazione al volume For the Sake of Peace. Seven Paths to Global Harmony. A Buddhist Perspective (Middleway Press SGI-USA, Santa Monica (CA), 2001) che raccoglie discorsi tenuti presso università e Proposte di pace presentate all’ONU da Daisaku Ikeda negli ultimi venticinque anni.
Questo articolo è la traduzione della prefazione al volume For the Sake of Peace. Seven Paths to Global Harmony. A Buddhist Perspective (Middleway Press SGI-USA, Santa Monica (CA), 2001) che raccoglie discorsi tenuti presso università e Proposte di pace presentate all’ONU da Daisaku Ikeda negli ultimi venticinque anni.Nei prossimi numeri pubblicheremo a puntate tutti i capitoli del libro
Nel 1937 avevo nove anni. Sembrava che mio padre stesse finalmente cominciando a riprendersi dopo una lunga malattia. Fu allora che mio fratello maggiore Kiichi fu chiamato alle armi. Aveva ventun’anni, era un ragazzo onesto e sincero e io avevo un grande rispetto per lui.
Durante la malattia di nostro padre, Kiichi aveva lavorato sodo per mantenerci, diventando così il pilastro della famiglia. Dopo di lui anche gli altri miei tre fratelli maggiori, tutti nel fiore degli anni, ci furono strappati dall’esercito. Così la responsabilità dei nostri anziani genitori, con mio padre sempre malato, ricadde su di me, debole e affetto da tubercolosi. Quali crudeli tributi il nazionalismo impone alla vita delle persone comuni!
All’inizio della primavera del 1939, due anni dopo essere stato arruolato, Kiichi fu mandato a combattere all’estero. L’esercito ci notificò che avremmo potuto incontrarlo prima che si imbarcasse e così mia madre e io ci affrettammo a raggiungere la stazione di Tokyo. Allora frequentavo la quinta elementare. Mia madre preparò del cibo, delle polpette di riso, che nel Giappone in tempo di guerra costituivano una vera leccornia, e le avvolse con molti strati di alghe perché diceva che non avremmo rivisto mio fratello per tanto tempo.
Quando giungemmo alla stazione c’erano circa trecento soldati diretti al fronte, assieme alle loro famiglie nel piazzale davanti all’ingresso. Poteva essere l’ultimo addio, gli occhi di tante madri e giovani mogli erano pieni di lacrime.
La partenza per la guerra era stata così improvvisa che le famiglie dei soldati che abitavano in zone molto distanti da Tokyo, come Yamagata e Akita, non erano riuscite ad arrivare in tempo per salutarli. Ho ancora un vivido ricordo di quei soldati silenziosi, a capo chino, nelle loro uniformi, seduti sui marciapiedi fuori della stazione senza nessuno con cui parlare. Mia madre ne chiamò diversi, chiedendo loro di unirsi a noi, e mi mandò a distribuire polpette di riso a quelli che sembravano troppo timidi per accettare il suo invito. I loro volti sconsolati si illuminavano, sorridevano e chiacchieravano durante quel pasto modesto ma sincero e caloroso che mia madre aveva preparato.
Infine, anche se ci si spezzava il cuore, giunse il momento della partenza. Mio fratello si riallacciò gli stivali, controllò la spada che portava appesa al cinturone e tornò al suo reparto.
Mia madre e io ci recammo in treno alla stazione di Shinagawa, da dove saremmo ritornati a casa. Aspettavamo sulla pensilina, nella speranza che passasse il treno di mio fratello, quando giunse un convoglio carico di soldati.
Mia madre correva da un finestrino all’altro cercando mio fratello, ma non riusciva a trovarlo. Un anziano ferroviere, impietosito, afferrò un microfono e cominciò a chiamare a gran voce: «Kiichi Ikeda. C’è Kiichi Ikeda? Tua madre è qui per vederti», camminando avanti e indietro lungo il binario in vece nostra. Il treno stava preparandosi a uscire dalla stazione quando uno dei camerati di mio fratello udì l’appello del funzionario. Penso che si trattasse di uno dei ragazzi che erano stati con noi in precedenza. Si precipitò da mio fratello, che sedeva dall’altro lato del treno, dicendogli: «Kiichi, c’è tua madre».
Il treno aveva cominciato lentamente a muoversi. Mio fratello corse al finestrino e si sporse per vederla. «Kiichi, Kiichi, abbi cura di te!» disse mia madre inseguendo il treno che cominciava a prendere velocità. Mio fratello annuì in silenzio e agitò energicamente il braccio per salutare. Mia madre e io continuammo a salutarlo fino a quando il treno scomparve completamente dalla nostra vista.
Nel 1941 Kiichi ebbe un congedo temporaneo e tornò a casa dalla Cina. Fu allora che mi disse, con voce tremante di rabbia: «Non ci sono parole per descrivere la crudeltà dell’esercito giapponese».
Quattro anni dopo fu vittima della sfortunata campagna di Imphal. Morì a Burma (ora Myanmar) nel gennaio 1945. Aveva ventinove anni.
Io sono contro la guerra! Sono assolutamente contrario alla guerra!
Il governo militare incitava molti giovani della mia generazione a recarsi fieramente al fronte per dare la propria vita. Le famiglie rimaste a casa venivano lodate per il loro sacrificio, come “madri di militari”, e “famiglie di soldati al fronte”, espressioni considerate sinonimo di grande onore.
Ma in realtà i loro cuori erano tormentati dall’agonia e dal dolore! E quelle false lodi e la simpatia degli altri, inconsapevoli di quel tormento interiore, infliggevano ferite ancor più profonde ai cuori già dolenti delle madri e dei figli rimasti a casa.
L’amore di una madre, la saggezza di una madre è troppo grande per essere ingannata da frasi artificiose come «per il bene della nazione».
Nel maggio 1945, quando avevo diciassette anni, un giovane pilota americanosi lanciò con il paracadute nei pressi del luogo in cui era stata sfollata la mia famiglia. Si trovava su un bombardiere B-29 che era stato abbattuto durante un’aspra battaglia notturna. Quando toccò il suolo fu ripetutamente percosso e preso a calci dai presenti e alla fine fu bendato e condotto alla prigione militare. Quando le riferii l’accaduto, mia madre disse: «Che tristezza! Sono certa che sua madre sarà tremendamente in pensiero per lui!». Quella frase è ancora profondamente incisa nella mia memoria.
Durante la guerra ogni stagione dell’anno è simile all’inverno. Quando alla fine la guerra termina un nuovo sole di pace comincia a sorgere all’orizzonte, silenzioso eppure luminoso e forte.
Il 15 agosto 1945 udii alla radio l’annuncio imperiale della fine della guerra. Il coacervo di intricati sentimenti che provai allora è ancora indelebilmente impresso dentro di me.
Sono assolutamente contrario alla guerra. È una della ragioni per cui rispetto così profondamente Tsunesaburo Makiguchi e Josei Toda, che incarcerati dal governo militare si batterono da grandi eroi per la verità e la giustizia.
Sono deciso a battermi contro chiunque sia a favore della guerra o ne sostenga la necessità. Combatterò le oscure e demoniache forze della distruzione! E insieme a me c’è un immenso esercito di quasi dodici milioni di persone che, armate di una luminosa forza interiore, si dedicano con energia alla causa di una pace duratura.
Dal 1983, anno in cui la Soka Gakkai Internazionale, di cui sono presidente, è entrata a far parte della Nazioni Unite come Organizzazione non governativa (ONG), ho presentato ogni anno una Proposta di pace ai capi dei vari governi, alle altre ONG, alle istituzioni accademiche, alle biblioteche e ai funzionari dell’ONU. Ogni proposta contiene osservazioni sulle condizioni mondiali, analizza i presupposti filosofici da affrontare e trasformare per raggiungere la pace e contiene suggerimenti su varie azioni concrete da intraprendere.
Questo libro, For the Sake of Peace (Per la pace), è una preziosa occasione per condividere le mie idee con un pubblico più ampio, specialmente con i giovani di tutto il mondo, che sono il nostro futuro, con la speranza e la convinzione che come cittadini del mondo riusciremo a riconoscere la nostra comune umanità. È questa ovviamente la base per qualsiasi sforzo in direzione della pace.
[…] Soprattutto non possiamo permettere che la tragedia che abbiamo vissuto venga ripetuta dalle generazioni future. Dobbiamo creare un sentiero di pace e di amicizia per i giovani e per il ventunesimo secolo.
Per il bene della pace. Sette sentieri verso l'armonia globale. Una prospettiva buddista - di Daisaku Ikeda
Capitolo 1° - Una prospettiva di pace - AUDIO generato con un sintetizzatore vocale

Una nuova serie, tratta dal libro For the Sake of Peace di cui pubblicheremo i diversi capitoli nel corso di quest’anno, per continuare a parlare di dialogo, di coesistenza, di pace con mezzi pacifici. Un’analisi attenta e acuta delle difficili condizioni attuali, della follia della guerra e degli embrioni di cultura di pace che già esistono e che vanno coltivati. A partire dal cuore degli esseri umani. La prefazione al libro è stata pubblicata su Buddismo e Società n. 88 nella rubrica "Strategie di Pace"
All’inizio del ventesimo secolo molti ritenevano che il progresso umano non avesse limiti. Tuttavia gli ideali sublimi e gli scopi elevati prospettati ai primi del Novecento furono spazzati via dalle ideologie estremiste che funestarono il mondo portando con sé una serie di carneficine. Forse nessun altro secolo è stato testimone di una tragedia dell’umana follia di tali dimensioni: l’ambiente è stato profondamente danneggiato e il divario tra ricchi e poveri non ha fatto che aumentare.
Gli ultimi anni del secolo hanno visto una serie di drammatiche trasformazioni. Dapprima sembrava che la fine della guerra fredda, nel 1989, potesse portare prospettive luminose per il futuro dell’umanità, ma quelle speranze vennero ben presto disattese dai devastanti conflitti che sorgevano in ogni parte del mondo, su scala regionale e nazionale. Era come se la Cortina di ferro fosse stata finalmente abbattuta soltanto per dare libero sfogo alle forze demoniache, prima represse, della guerra e della violenza. Da allora più di cinquanta nazioni sono state devastate da conflitti violenti, divisioni interne o lotte per l’indipendenza, al prezzo di milioni di vite umane.
Oggi l’umanità si trova davanti a problemi a cui non può sfuggire, in ogni direzione: la minaccia delle armi nucleari e di altri mezzi di distruzione di massa, l’intensificarsi dei conflitti etnici, il danno all’ambiente causato dagli effetti del riscaldamento globale e dalla distruzione dello strato di ozono e la diffusione di una criminalità brutale e psicopatica.
Siamo all’inizio del terzo millennio. In questo momento storico dovremmo decidere fermamente di eliminare ogni inutile sofferenza da questo pianeta, che è la nostra casa. Cercando di realizzare questo scopo troveremo la forza per far sì che il nuovo secolo non sia una copia di quello che lo ha preceduto ma l’inizio di un nuovo periodo di pace e di speranza. È tempo di costruire una nuova epoca dove splendano umanità e cultura, e dove la sacralità della vita venga in ogni caso al primo posto.
Dobbiamo realizzare non solo una pace passiva, cioè l’assenza di guerre, ma trasformare le strutture sociali che minacciano la dignità umana per rendere concreti i valori attivi e positivi della pace. Naturalmente, per sviluppare una cultura di pace, c’è bisogno di migliorare la cooperazione internazionale e di elaborare una legislazione internazionale, ma ancora di più occorrono gli sforzi creativi dei singoli individui, perché solo su questa base si potrà costruire una nuova società globale.
Qual è la strada?
Cosa serve per far avanzare la storia umana, per passare dall’oscurità alla luce, dalla disperazione alla speranza, dall’uccisione alla coesistenza? Quale luce può dissolvere le tenebre e illuminare i prossimi mille anni? Sono domande che dobbiamo porci con grande serietà.
Josei Toda, mio maestro e secondo presidente della Soka Gakkai, desiderava ardentemente eliminare la miseria dalla faccia della Terra, e questo suo desiderio sta alla base del mio pensiero e delle mie azioni. Alla metà del ventesimo secolo, periodo di importanza cruciale, Toda intraprese in nome dell’umanesimo buddista iniziative che miravano a sradicare l’infelicità umana. Egli insisteva sul fatto che qualsiasi nostra idea di progresso non può prescindere da una previsione delle condizioni future da qui a duecento anni. Allo stesso tempo ci esortava a utilizzare il dialogo come mezzo per creare una solidarietà duratura che abbracciasse tutta l’umanità.
La mia risposta all’appello di Toda è stata di promuovere la discussione su argomenti di vitale importanza con persone attente e informate. Sono convinto che nel prospettare il corso degli eventi del ventunesimo secolo dobbiamo non solo imparare dal presente ma andare a riscoprire le ricchezze spirituali sepolte nelle correnti sotterranee della storia. Per fare ciò ho avviato dialoghi con i rappresentanti di tutti i popoli sulla base della nostra comune umanità.
Gli ostacoli alla pace
La prima domanda che emerge quando si intraprende un compito così palesamente e totalmente positivo è la seguente: che cosa impedisce di realizzare la pace mondiale? È importante individuare le resistenze che si frappongono al conseguimento di tale scopo.
ISOLAZIONISMO
Il primo ostacolo è connaturato alla portata dell’impresa, che può apparire eccessiva per chi manchi di una base spirituale solida e omnicomprensiva. Quando c’incontrammo nel luglio 1998, l’ex-segretario dell’ONU Boutros Boutros Ghali mi fece un breve resoconto del panorama spirituale alla fine del secolo: le questioni finanziarie, ambientali e sanitarie hanno assunto una valenza globale per cui non è più possibile risolvere i problemi interni senza affrontare quelli internazionali. Le persone sono quindi costrette a fare i conti con la globalizzazione e spesso provano disagio, ritirandosi nel proprio piccolo “villaggio” (regione o Stato che sia), nelle proprie tradizioni, tendendo a evitare i contatti con gli stranieri. Boutros Ghali definì questo fenomeno “nuovo isolazionismo”.
L’ILLUSIONE DELL’“EFFICIENZA”
La seconda barriera da infrangere è costituita da un’altra forma di autolimitazione, che questa volta deriva dalla supremazia della tecnologia. È innegabile che i numerosi progressi tecnico-scientifici del ventesimo secolo abbiano portato molti vantaggi, ma in alcuni casi il progresso, avendo trascurato l’importanza dell’umanità, ha proceduto lungo un sentiero arbitrario con conseguenze spesso tragiche.
Il motivo fondamentale è che il pensiero occidentale moderno è sempre più dominato dal principio di efficienza. I sostenitori dell’efficienza mettono sempre l’accento sulla funzionalità e sulla convenienza. Questa ricerca dell’efficienza a tutti i costi, se da un lato ha stimolato i progressi in campo scientifico e materiale, dall’altro nasconde l’insidiosa tendenza a ridurre gli esseri umani a semplici cose. Per esempio, al culmine del dibattito sulla deterrenza nucleare si fece un gran parlare di distruzione garantita, di limitazione dei danni, di rapporto costo-prestazioni e altre questioni simili. Un linguaggio così spietato e grottesco deriva dal culto dell’efficienza, che relega gli esseri umani allo status di oggetti e persegue la convenienza a spese di innumerevoli vite umane.
I politici e gli scienziati, che costituiscono l’élite della cultura e della classe dirigente nell’era nucleare, cadono molto facilmente preda di questo modo di pensare; il sacrificio al dio dell’efficienza ha condizionato anche ogni possibile dialogo sulla riduzione degli armamenti.
Dobbiamo impegnare gran parte dei nostri sforzi per tracciare finalmente un cammino di speranza per il ventunesimo secolo, analizzando seriamente quanto il cosiddetto progresso abbia effettivamente contribuito alla felicità umana. Le mie azioni si basano sulla convinzione che questa sia la grande responsabilità dell’umanità.
AVIDITÀ
Il terzo ostacolo alla pace affonda le radici nella sete di potere. L’inizio del ventesimo secolo fu caratterizzato da duri scontri fra le grandi potenze per il predominio e l’espansione coloniale. Il primo presidente della Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi, nell’opera Geografia della vita umana descriveva queste potenze che si guardavano in cagnesco, disposte ad approfittare di qualsiasi occasione per impadronirsi, senza alcuno scrupolo e con la massima crudeltà, della terra di un altro popolo. La loro lotta per il predominio generò non soltanto due guerre mondiali ma anche la guerra fredda, che diffuse in tutto il globo la minaccia del conflitto nucleare.
Grazie alla frenetica corsa agli armamenti da parte dei due blocchi, orientale e occidentale, la potenza militare raggiunse livelli umanamente incontrollabili. Armi progettate per distruggere totalmente il nemico minacciavano la sopravvivenza dei loro stessi detentori, portando l’umanità sull’orlo della distruzione. Il destino umano dipendeva da un precario e rischioso equilibrio.
Ora la guerra fredda è finita ma la lotta per la supremazia infuria ancora, anche se con modalità differenti. La tendenza all’unificazione globale attraverso la forza militare ha ceduto spazio a un nuovo scontro per il dominio economico, all’insegna dei mercati aperti e della libera concorrenza, in cui prevale la legge della giungla. In quello che è stato definito il “capitalismo da casinò” dei mercati globali, ingenti somme di denaro che travalicano la portata reale dell’economia cambiano di mano ogni giorno. E tutto questo si verifica sotto l’egida regolatrice dei governi nazionali e sotto lo slogan delle leggi di mercato.
POVERTÀ
Se un simile ingranaggio sembra difficile da sgretolare c’è un quarto ostacolo, ancor più fondamentale: il bisogno. Spesso, le cause di conflitti devastanti che si verificano in diverse parti del mondo risiedono nella deprivazione economica. Il problema centrale dell’epoca attuale è la povertà estrema. Non ci può essere pace là dove regna la fame.
Dobbiamo eliminare fame e povertà e dedicarci alla realizzazione di un sistema di assistenza economica per i quasi cinquecento milioni di persone che attualmente soffrono di malnutrizione e a favore dei due terzi delle nazioni del mondo che sono sempre più povere.
Invece di farci una concorrenza spietata dovremmo sforzarci di creare valore. In termini economici ciò equivale a una transizione da un’economia del consumo – folle corsa verso il consumismo e il possesso di beni – a un’economia costruttiva dove tutti gli esseri umani possano partecipare alla creazione di un valore duraturo.
IRRESPONSABILITÀ VERSO L’AMBIENTE
Un quinto ostacolo che influenza non solo la civiltà umana ma tutta la vita del pianeta è l’incuria nei confronti dell’ambiente. La crescita economica e la prosperità generate dai progressi tecnologici hanno catturato a tal punto l’immaginario delle persone da non porre alcun limite alla diffusione della civiltà scientifico-tecnologica.
Ma un simile trionfo è compromesso dai danni provocati all’ecosistema terrestre dagli effetti collaterali di questa civiltà, indicatori del fatto che il progresso può di fatto rivelarsi la nostra rovina. Inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, disboscamento indiscriminato, desertificazione, danno allo strato protettivo di ozono e conseguenti effetti di riscaldamento globale: nessuno di questi problemi si risolverà da solo. Attualmente gli ecologisti avvertono che se non verranno intrapresi cambiamenti radicali, la vita così come la conosciamo oggi potrebbe non sopravvivere a un altro secolo.
È ormai evidente che la soluzione di problemi globali come la distruzione ambientale richiederà nuovi approcci che trascendano i confini dei singoli Stati. Finché si continuerà a pensare entro i ristretti confini della sovranità nazionale non sarà possibile intraprendere azioni che tutelino la sopravvivenza dell’umanità. Ciò di cui ai nostri giorni abbiamo più bisogno è di una filosofia che si basi su un punto di vista veramente globale.
LA NEGATIVITÀ DEL NUCLEARE
L’ostacolo ultimo che l’umanità deve affrontare è l’incarnazione estrema della negatività: le armi nucleari.
Sicurezza ed equilibrio nucleare sono obiettivi intrinsecamente impossibili da raggiungere insieme. Il Buddismo insegna l’unicità della vita e del suo ambiente: ciò significa che la sfera soggettiva è inseparabilmente legata al mondo oggettivo. Per via di questo legame, finché nell’ambiente in cui viviamo persisteràla minaccia delle armi nucleari, l’umanità non avrà pace.
Un terreno fertile
Queste barriere possono apparire, a seconda dei punti di vista, gigantesche se non addirittura eternamente inamovibili. Ma un esame più attento della realtà attuale potrebbe dischiudere diversi motivi d’ottimismo rispetto alla capacità di cambiamento dell’umanità: l’ascesa del “potere morbido” della conoscenza e della competenza al posto del “potere duro” della forza militare, dell’autorità politica e della ricchezza; un crescente impegno verso le modalità nonviolente di trasferimento di potere, come si è visto nella costituzione della “nazione arcobaleno” dell’ex-presidente del Sud Africa Nelson Mandela; la fioritura del “potere della gente” che si riflette nel sorgere di quasi diecimila organizzazioni non governative che si occupano di diritti umani e di sicurezza e la miracolosa dissoluzione incruenta del bolscevismo, caratterizzato fin dalle sue origini da violenza e terrorismo.
Quale lezione possiamo trarre da questi risultati positivi, applicabili anche in altre parti del globo per sedare i conflitti in corso ed evitare nuove violenze future? Si può parlare quanto si vuole del terzo millennio, ma un cambiamento di data nel calendario non farà cambiare un’epoca. Solo la volontà e le azioni umane possono creare la storia e aprire nuovi orizzonti.
Qualche tempo fa ho incontrato a Tokyo il cancelliere austriaco Franz Vranitzky, che mi ha detto: «L’antico proverbio latino “se desideri la pace, preparati alla guerra” bisognerebbe trasformarlo in “se desideri la pace, preparati alla pace”. È su questo principio che baso il mio lavoro».
Ma come ci si prepara alla pace? Qual è il sentiero che ci guiderà fuori dalla nostra desolata landa interiore per poter vivere felicemente insieme come l’umanità ha sempre sognato?
Sentieri per la pace
Il primo sentiero è quasi ovvio: se vogliamo diventare buoni cittadini del mondo dobbiamo acquisire un certo grado di autocontrollo. La capacità di vedere profondamente dentro noi stessi ci permetterà di trascendere i confini nazionali e le barriere etniche.
Il dominio di sé è un prerequisito della seconda tappa di questo viaggio: il sentiero del dialogo. Non ne metterò mai sufficientemente in rilievo l’importanza, poiché ritengo che la propensione alla logica e alla discussione sia una delle prove della nostra umanità. In altre parole, solo quando siamo immersi in un oceano di linguaggio diventiamo veramente umani. Nel Fedone Platone associa acutamente l’odio per il linguaggio (mislogos) con l’odio per le persone (misanthropos). Abbandonare il dialogo significa abbandonare l’essere umano: se abbandoniamo la nostra umanità cessiamo di essere gli agenti della storia, rimettendo questo compito autorevole a qualcosa che appartiene a un ordine inferiore, una sorta di “bestialità”. Sappiamo troppo bene che la storia è piena di tragedie dove la “bestialità”, in nome dell’ideologia o del dogma, ha calpestato l’umanità con violenza e forza bruta.
Il dialogo – una relazione tra individui caratterizzata dall’apertura e dal rispetto reciproco – avrà la sua massima utilità se le persone condivideranno una comune visione libera dalle illusioni; altrimenti avrà fondamenta instabili. Dietro la fanfara che annuncia la nuova era c’è un rombo assordante e spaventoso prodotto dal crollo definitivo del vecchio sistema che manteneva l’ordine mondiale.
Per superare la crisi d’identità che mina lo spirito dell’umanità moderna occorre riscoprire un rinnovato senso della comunità basato su una nuova visione del mondo, che non rimanga soltanto nel regno del pensiero astratto ma si inserisca nel tessuto della vita: per gettare le fondamenta di una pace duratura dobbiamo deistituzionalizzare la guerra. Dobbiamo operare la transizione fra una cultura di guerra e una cultura di pace. Sono sicuro che se tutti popoli della Terra si impegneranno in un dialogo sincero per ottenere una base comune d’opinione e d’azione, unendosi con pari dignità per creare una cultura di pace, assisteremo all’alba di un’epoca in cui tutti potranno godere della felicità.
La cultura definisce le comunità, ma ormai esistono entità più vaste che esercitano una possente influenza a livello mondiale. Anche il ruolo delle nazioni va trasformato. I passi fatti fino a oggi verso una minore focalizzazione sugli Stati-nazione sono stati pochi ed esitanti: deve essere chiaro che un mondo in cui gli Stati contano meno è un mondo in cui gli individui contano di più.
Con la crescita del ruolo e della responsabilità degli individui diventa sempre più necessario che ognuno di noi impari a vivere da cittadino globale attivo e creativo, riconoscendo le proprie responsabilità nel nuovo millennio e adoperandosi per adempierle.
Infine, alla convergenza dei sentieri c’è un processo che non sarà difficile realizzare dopo i rigori affrontati durante il viaggio: il disarmo totale.
La guerra avalla la pazzia
Come buddista che segue la filosofia del maestro giapponese del tredicesimo secolo Nichiren Daishonin e l’esempio lasciato da Josei Toda, sono profondamente convinto che nessun individuo possa provare vera felicità e tranquillità fino a quando l’umanità continuerà a essere ossessionata dalla guerra. Nel corso della storia, la guerra ha stretto l’umanità in una morsa fatale; essa è la fonte di tutti i mali. La guerra rende normale la follia – quel tipo di follia che non esita a distruggere gli esseri umani come fossero tanti insetti, riducendo a brandelli gli individui e tutto ciò che è umano, producendo un interminabile flusso di rifugiati e causando danni irreparabili anche al nostro ambiente naturale.
Abbiamo già pagato un prezzo estremamente alto per imparare che niente è più tragico e crudele della guerra. Credo che adesso la nostra assoluta priorità sia l’obbligo morale di aprire ai nostri figli una strada di pace sicura e percorribile per il ventunesimo secolo.
Per il bene della pace. Sette sentieri verso l'armonia globale. Una prospettiva buddista - di Daisaku Ikeda
Capitolo 2° - La via del dominio di sé - AUDIO generato con un sintetizzatore vocale
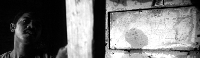
La pace non può essere mera immobilità, un interludio di quiete fra le guerre. Deve essere un’energica gara di attività vitale, in cui si vince grazie a uno sforzo di volontà esercitato in prima persona. La pace dev’essere un dramma vivente, nelle parole di Spinoza, «una virtù che scaturisce dalla forza di carattere». La pace eterna è una condizione che viene mantenuta in maniera consapevole grazie all’interazione fra l’autocontrollo individuale e quello della società nel suo complesso.
Nessuno avrà da ridire su questa descrizione dell’armonia. Il suo opposto si verifica quando lottiamo spietatamente per ottenere scopi apparentemente contrastanti, spesso animati da un’etica per la quale «non c’è pace se non c’è giustizia», etica che è stata la molla propulsiva dei rivoluzionari di ogni credo durante il ventesimo secolo. In un simile contesto la padronanza di sé non viene considerata. Ma, come vedremo, è proprio in tali conflitti che sarebbe essenziale l’autocontrollo che deriva dall’introspezione.
La capacità di percepire gli aspetti negativi di noi stessi ci permette di percepire i lati positivi degli altri. Le relazioni tra le nazioni, come quelle fra individui, non possono essere gestite con maturità se una parte insiste sul proprio punto di vista senza considerare la posizione dell’altra. Non intendo sostenere una concezione manichea del dualismo bene-male ma solo sottolineare la necessità di riconoscere il bene e il male all’interno di ognuno di noi. Anche se ci scontriamo con un rivale, dovremmo cercare di manifestare il bene e annullare il male. La capacità di autocontrollo ci può aiutare a evitare il conflitto e l’ostilità e permetterci di assumere il giusto atteggiamento di accettazione reciproca e di rispetto.
L’errore di fare affidamento sulle riforme esterne
L’approccio esterno al cambiamento sociale fu dichiarato sospetto qualcosa come sessant’anni fa dal poeta inglese Thomas S. Eliot che, allarmato dall’avanzata del fascismo che minacciava i valori umani e democratici, pronunciò un vibrante appello alla radio nel quale fra l’altro, affermava: «Una delle ragioni per cui ritengo che la posizione del riformatore secolare o del rivoluzionario sia la più comoda è la seguente: nella maggior parte dei casi egli ritiene che i mali del mondo siano qualcosa di esterno a lui. O li considera in maniera assolutamente impersonale, e allora non occorre altro che alterare un meccanismo o, se esiste il male incarnato, è sempre incarnato in altra gente, in una classe, una razza, nei politici, nei banchieri, nei fabbricanti di armi e così via, mai in lui stesso».
Eliot individua un punto fondamentale che si ritrova esemplificato nella sequela di trasformazioni a catena nei paesi dell’Est. I regimi comunisti sono crollati perché hanno cercato per troppo tempo i nemici all’esterno, invece di cercare di vedere i mali che albergavano al loro interno. Così la visione della storia come storia della lotta di classe – vale a dire che sarebbe bastato abolire le distinzioni di classe per abolire tutti i mali sociali – è fallita. Sostituendo “classe” con “razza” abbiamo l’infernale mito nazista secondo il quale solo la razza ariana era abbastanza pura da poter governare. È un mito duro a morire. Ancora oggi, a più di cinquant’anni dalla fine della seconda guerra mondiale, la resistenza degli attuali schieramenti di estrema destra all’ingresso della manodopera straniera nei paesi dell’Europa occidentale continua a tingersi di toni razzisti.
I pericoli dello “spirito astratto”
Anche quelle rivoluzioni del diciannovesimo secolo che nacquero da motivi “puri”, cioè dalla richiesta di libertà, eguaglianza e fraternità, caddero preda di quello che il grande pensatore francese Gabriel Marcel chiama «spirito astratto». Nel romanzo di Anatole France Les Dieux Ont Soif (Gli dei hanno sete) possiamo vederne efficacemente descritti gli effetti. Il protagonista Gamelin, come molti rivoluzionari, non era nato col cuore di pietra. Anzi, era un giovane gentile e pieno di compassione che, nonostante fosse affamato, condivideva tranquillamente il suo pane raffermo con una madre e il figlioletto in procinto di morire di fame. Era puro e generoso, pronto a sacrificarsi senza il minimo rimpianto. La cosa spaventosa è che più pura e idealista è una persona, più facilmente cade preda del sortilegio dello “spirito astratto”. Ben presto, nominato giudice del tribunale rivoluzionario, il protagonista, pieno di ardente zelo, cominciò a emettere severe condanne accantonando ogni tipo di sentimento personale e mandando alla ghigliottina molti dei suoi nemici. Ma alla fine giunse anche il suo turno e fu decapitato insieme al suo maestro Robespierre.
Da un certo punto di vista è facile revisionare le leggi e ricostruire un sistema politico che dica addio per sempre all’ancien régime. Ben altra faccenda è cercare di ricostruire l’essere umano. In parole povere, nelle vicende umane non si può cercare di cambiare troppo in poco tempo. Affrettare le cose significa imporle alla gente con la violenza e le minacce. Possiamo vederlo nel caso del radicalismo politico, che è sempre potenzialmente venato di violenza.
Nel caso dei bolscevichi è stato lo stesso. Certo sembra impossibile dubitare della loro sincerità. La moglie di Lenin, Krupskaya, e altri personaggi di primo piano in ambito educativo nelle prime fasi del bolscevismo, erano degli ottimisti fin troppo pieni di buone intenzioni che sposavano la causa dell’educazione naturale esposta da Rousseau nell’Emile.
Ma, a meno che le persone non abbiano il coraggio di guardare in faccia fino in fondo il proprio egoismo, è difficile dire quando le buone intenzioni si trasformeranno in desiderio di potere, un desiderio che cerca approvazione ammantandosi della bella maschera dell’ideologia. È sempre il male occulto dello “spirito astratto” che mandava in collera il dottor Zivago nel grande romanzo di Pasternak: «Rifare la vita! Così può pensare solo gente che ne avrà anche viste di tutti i colori, ma che non ha mai conosciuto la vita, non ha mai sentito il suo spirito, la sua anima. Per costoro l’esistenza è un grumo di materiale grezzo, che il proprio contatto non ha ancora nobilitato e che perciò ha bisogno della loro rielaborazione. Ma la vita non è mai un materiale, una sostanza. La vita, se volete saperlo, è un elemento che continuamente si rinnova e rielabora da sé, che da sé si rifà e si ricrea incessantemente, sempre tanto più alta di tutte le nostre ottuse teorie». (Boris Pasternak, Il dottor Zivago, trad. di Pietro Zvteremich, Feltrinelli, Milano 1963, pag. 267).
La causa primaria del male nascosto risiede nella tendenza dello “spirito astratto” a cercare di imporre ordine all’animo umano dal di fuori, spesso attraverso la pressione esterna. Un vero progresso o riforma della condizione umana non può verificarsi a meno che non si sviluppi spontaneamente attraverso un impulso interiore e grazie alla forza interiore. Le forze esterne possono al massimo fungere da fattori secondari che servono a destare il progresso interno. E tuttavia i posseduti dallo “spirito astratto” hanno negato nella maniera più assoluta i fattori interni, liquidandoli come idealistici. In maniera estremizzata hanno cercato di includere tutto nello schema precostituito dell’idelogia esterna. Lo sgretolamento e il crollo della società socialista ai quali abbiamo assistito alla fine del ventesimo secolo sono la testimonianza del fallimento di questo irragionevole tentativo. E la desolazione spirituale che si è rivelata una volta strappata la maschera dell’ideologia ha dimostrato con agghiacciante chiarezza quali crudeli distruzioni può operare lo spirito astratto sul cuore umano.
Radicalismo e violenza
Perché così spesso la violenza intrinseca nel radicalismo distrugge le basi umanistiche delle rivoluzioni? Il Mahatma Gandhi e il suo successore Jawaharlal Nehru avevano una chiara consapevolezza di quanto fosse negativo il radicalismo politico generato dallo “spirito astratto”. Sono famose le parole di Gandhi: «Questo socialismo è puro come il cristallo. Perciò per realizzarlo occorrono mezzi altrettanto cristallini. […] E quindi soltanto socialisti sinceri, nonviolenti e dal cuore puro saranno capaci di istituire una società socialista in India e nel mondo».
Gandhi punta direttamente alla vera natura del socialismo. Le teorie socialiste espongono belle idee dotate anche di una coerenza logica di tipo astratto. Proprio per questo le persone insistono tanto per realizzare concretamente questi ideali. Naturalmente, se si sa che qualcosa è buono, prima si mette in pratica meglio è. Di conseguenza si ha sempre troppa fretta di riformare il sistema e si tende a dimenticare gli esseri umani che sono la parte più importante del processo di riforma. Il difetto fatale del socialismo perciò risiede non tanto nel fallimento dei tentativi di far crescere «socialisti sinceri, nonviolenti e dal cuore puro» ma piuttosto nella totale assenza di qualsiasi sforzo per coltivare persone simili.
Riforma interiore
A parte il sistema politico, cosa può far crescere persone sincere, nonviolente e dal cuore puro? La costruzione di una pace durevole dipende da quante persone dotate di autocontrollo si possono far crescere attraverso la pratica religiosa. Una religione degna del suo nome e in grado di rispondere ai bisogni dei tempi attuali dovrebbe offrire ai suoi seguaci la base spirituale per diventare buoni cittadini del mondo.
Nel Buddismo mahayana si parla di dieci condizioni potenziali della vita, inerenti all’essere umano, i cosiddetti dieci mondi. Secondo questo principio, chi dà inizio alle guerre vive nei quattro stati più bassi di Inferno, Avidità, Animalità e Collera, collettivamente definiti come “i quattro cattivi sentieri”. I pensieri e le azioni di questi individui, controllati dall’istinto e dal desiderio, sono inevitabilmente stupidi e barbarici. Perciò, dal punto di vista buddista, la questione di come erigere, in accordo con la Costituzione dell’UNESCO, “baluardi di pace” nel cuore di questi individui, ha la precedenza su qualsiasi fattore sistemico esterno e rappresenta sia il punto di partenza che il nucleo fondamentale di qualsiasi tentativo di costruire la pace nel mondo.
Il Buddismo sottolinea l’importanza della qualità della nostra motivazione dando valore a ciò che sgorga spontaneamente dall’interno, come esprime la semplice frase «la cosa importante è il cuore».
Ci insegna che l’obiettivo fondamentale della vita del Budda è stato rivelato dall’umanità che ha manifestato nel comportamento e nelle azioni. Nella tradizione buddista i veri scopi della pratica religiosa sono coltivare e perfezionare il carattere individuale. Le norme che non vengono generate dall’interno e non incoraggiano lo sviluppo della personalità si rivelano in ultima analisi deboli e inefficaci. Solo quando le norme esterne e i valori interiori operano in maniera da sostenersi a vicenda potranno permettere alle persone di resistere al male e vivere come sincere promotrici dei diritti umani.
La repubblica interna
Nell’esaminare le norme interne e quelle esterne può essere illuminante riconsiderare l’idea platonica di democrazia. Nell’ottavo libro della Repubblica, Platone descrive cinque tipi di governo: aristocrazia, timocrazia, oligarchia, democrazia e tirannia. Egli analizza i vari sistemi, ordinandoli gerarchicamente in termini di pro e contro, e prosegue descrivendo i tipi di natura umana a cui ogni sistema meglio si adatta. Nell’ordinamento platonico la democrazia sta al quarto posto, mentre il sistema al quale egli attribuisce maggiore considerazione è un’aristocrazia benevola che si dedica all’amore per il sapere.
La scarsa stima che Platone ha della democrazia deriva dal fatto che egli trascorse la gioventù nei giorni caotici del declino della democrazia ateniese. La guerra del Peloponneso tra Atene e Sparta era iniziata poco prima della sua nascita e quando terminò, quasi trent’anni più tardi, con la sconfitta di Atene, Platone aveva venticinque o ventisei anni. Così egli trascorse gran parte della gioventù in mezzo alle tribolazioni arrecate da quell’interminabile conflitto. Poco dopo l’inizio della guerra, Atene aveva perso il suo grande statista Pericle a causa di una malattia, e la democrazia ateniese si era rapidamente deteriorata. Platone, giovane estremamente sensibile e acuto, vide l’umanità toccare il fondo dell’abiezione. Le sue opinioni sulle altre persone e sul governo furono inevitabilmente influenzate da ciò che osservava e lo condussero a una severa denuncia dell’egoismo umano e a una visione critica della realtà.
Il colpo finale per Platone dev’essere stata la condanna a morte dell’amato maestro Socrate da parte di demagoghi capaci solo di soddisfare le esigenze di una popolazione ottusa e facile alle sollevazioni. Per Platone, Socrate era stato assassinato dalla democrazia ateniese. Era stata messa a morte la persona più retta e virtuosa. Non c’è da meravigliarsi che egli fosse scettico riguardo alla democrazia.
Le esperienze giovanili s’incisero profondamente nel cuore di Platone donandogli una rara capacità di penetrazione della natura umana e della società. Il suo dettagliato e a tratti comico ritratto della democrazia che ha l’innata tendenza a trasformarsi nel suo esatto opposto, la tirannia, è un capolavoro di razionalità dotato di grande capacità persuasiva.
Questo ci porta al paradosso della libertà. I sostenitori della democrazia, dice Platone, affermano che la libertà è la più grande virtù della democrazia e che perciò quest’ultima è l’unica condizione adatta agli esseri umani, la cui natura è essenzialmente libera. Ma la democrazia, autorizzando l’insaziabile ricerca della libertà, alimenta un gran numero di desideri che gradualmente e insidiosamente «s’impadroniscono della fortezza dell’anima del giovane» e lo conducono lungo la china dell’arroganza. La modestia viene liquidata come stupidità, si ha vergogna della temperanza perché non è virile, la moderazione e la parsimonia nelle spese e nei consumi vengono considerate noiose e meschine.
Infine si perde il controllo della situazione e si ricerca un forte capo in grado di restaurare l’ordine. Fra tanti “inutili fuchi” si cerca quell’unica creatura dotata di pungiglione che dapprima emerge come leader delle masse ma ben presto cede al diabolico fascino del potere e si trasforma inevitabilmente in un tiranno. Come osserva acutamente Platone, «sembra che l’eccesso di libertà, negli Stati come negli individui, sia destinato soltanto a tramutarsi in eccessiva schiavitù» per mano di un dittatore.
È un riassunto un po’ semplicistico delle idee di Platone eppure basta a illustrare vivacemente la patologia e il paradosso della libertà che esercita un’irresistibile attrazione ma è molto difficile da gestire e continua a essere un pesante fardello da portare. Seguendo oggi le eloquenti argomentazioni della Repubblica ci si stupisce della loro veridicità e della capacità persuasiva con cui Platone sostiene la sua posizione. E della fedeltà con cui i vari capitoli descrivono i modelli che hanno generato anche i regimi totalitari contemporanei.
La violenta critica di Platone alla democrazia è stata attaccata e refutata da molti ideologi moderni che non sono teneri riguardo per esempio all’idea che donne e bambini dovrebbero essere allevati in comunità, che lo Stato dovrebbe essere dominato da un piccolo numero di filosofi o che i poeti dovrebbero essere espulsi, e denunciano gli ideali platonici come una forma estrema di comunismo.
Il filosofo francese Alain è probabilmente l’interprete più fedele delle argomentazioni platoniche quando si chiede se mai qualcuno ha cercato di interpretare la Repubblica come una guida individuale all’autocontrollo interiore. Alain vede l’opera di Platone più come un discorso sulla natura umana che sul governo, specialmente per il modo in cui ruota intorno al concetto di anima. E aggiunge che le parti che riguardano il governo sono bizzarre e inserite volutamente per confondere il lettore frettoloso. Platone preferiva non essere capito piuttosto che frainteso, afferma Alain.
La salute dell’anima
La penna di Platone passa velocemente dall’analisi delle istituzioni all’argomento della personalità umana. Subito dopo aver descritto, nell’ottavo libro della Repubblica, i cinque tipi di governo e i caratteri degli individui adatti a essi, Platone dedica il libro nono alle questioni della salute e dell’armonia dell’anima. È una naturale conseguenza del suo principale intento nella stesura dell’opera. Secondo Platone l’anima è costituita da tre parti, razionale, irascibile e concupiscente e la salute e l’armonia dell’anima si realizzano quando la parte razionale comanda e quella irascibile obbedisce. Verso la fine del nono libro appare chiaramente che Platone sta volgendo la nostra attenzione verso la “politica” interna a noi stessi. Dopo tutto non si possono analizzare le questioni di politica estera senza aver prima sistemato quelle di politica interna.
Da questo tema si passa con naturalezza a quello successivo, che costituisce l’interesse primario di Platone: l’immortalità dell’anima. La Repubblica si conclude con la storia di un eroe di nome Er, risorto dalla morte dopo dodici giorni, che parla per esperienza diretta del destino dell’anima dopo la morte. Il racconto riconferma il punto di vista di Platone secondo il quale la fede nell’immortalità dell’anima è essenziale per l’armonia e la salute di questa. E in questo punto egli si avvicina molto, pur senza entrarci realmente, al regno della religione.
Ho voluto esaminare nei dettagli la posizione di Platone perché ritengo che la sua idea di ordinamento dell’anima, in cui è la parte razionale che governa, sia fondamentale per gettare solide basi di un’epoca di democrazia basata sulla volontà popolare. Non esiste autorità, per quanto potente, che può andare per troppo tempo contro la volontà del popolo.
Ora il compito difficile che abbiamo di fronte è la trasformazione dell’energia liberatoria in energia costruttiva. Dobbiamo partire guardando dentro di noi analizzando, come sostiene Platone, lo “stato interno’” ancor più rigorosamente dello “stato esterno”.
Da tale processo di introspezione a mio avviso scaturiranno intuizioni importanti per la definizione del significato universale dei diritti umani. L’articolazione di una simile definizione servirà sia come simbolo del movimento per la libertà e la democrazia che come risposta a uno dei bisogni più pressanti del ventunesimo secolo.
L’arte della padronanza di sé
Gli effetti del padroneggiare lo “stato interiore” possono essere stupefacenti. Per esempio Leonardo da Vinci era sotto molti aspetti il prodotto di tale padronanza di sé. Totalmente libero e indipendente, non solo non era soggetto ad alcuna costrizione religiosa o morale ma non si sentiva vincolato nemmeno dalla nazione, dalla famiglia, dagli amici o conoscenti. Era un cittadino del mondo, intoccabile e insuperato.
Leonardo era figlio illegittimo e nel corso della sua vita non si sposò mai. Si sa poco della famiglia e anche i legami con la repubblica di Firenze, in cui era nato, erano deboli. Completato l’apprendistato a Firenze si recò immediatamente a Milano, dove trascorse circa diciassette anni sotto il patronato del duca Ludovico Sforza. In seguito alla caduta in disgrazia degli Sforza, Leonardo trascorse un breve periodo al servizio del duca di Romagna. Poi si trasferì a Firenze, a Roma, e di nuovo a Milano, dove lo portarono i suoi interessi o progetti.
In qualsasi circostanza o situazione Leonardo dimostrava scarso interesse a prender parte ai giudizi dei suoi contemporanei sul patriottismo o i vantaggi della fedeltà a un solo signore. Invece perseguiva uno stile di vita ideale che gli permettesse di considerare tutte le cose con distacco.
Non prestava attenzione alcuna alle seduzioni della fama e della ricchezza e tuttavia non si ribellava contro l’autorità costituita. Nella sua singolare dedizione ai propri interessi personali era impermeabile a qualsiasi convenzione mondana.
Leonardo non era una persona priva di emozioni e nemmeno mancava di virtù, ma la sua vita fu caratterizzata dalla trascendenza delle questioni mondane e dal perseguire in modo coerente e determinato la propria vocazione.
Leonardo era un genio multiforme di sorprendente versatilità e ampiezza d’interessi. Oltre che pittore era un abile scultore, ingegnere civile e inventore di una miriade di dispositivi, dalle macchine volanti agli armamenti da guerra. La stessa persona che studiava idrodinamica e fisiologia delle piante e che analizzava il volo degli uccelli possedeva anche un vivido interesse per l’anatomia umana.
Qualsiasi cosa si possa dire di Leonardo, la portata della sua mente era troppo grande per essere misurata dalle norme della società. La libertà con la quale si sollevò oltre le cure mondane ci dà un assaggio di come potrebbe essere un vero libero cittadino del mondo. La vita di Leonardo cattura lalibertà e il vigore peculiari del Rinascimento italiano.
Ciò che permise a Leonardo di raggiungere una libertà simile fu senza dubbio la sua padronanza di sé. Egli scriveva: «Non si può aver dominio più grande o più piccolo che quello su se stessi».
Era il suo principio primo, dal quale derivavano tutti gli altri. La padronanza di sé gli permise di rispondere in maniera elastica a ogni realtà. Riteneva di secondaria importanza le virtù tradizionali del suo tempo, come la lealtà o la bontà. Per esempio non ebbe scrupoli nell’accettare l’invito di Francesco I a recarsi in Francia anche se quel re era stato responsabile della caduta del suo precedente mecenate, Ludovico Sforza. Si trattò di tradimento, di mancanza di integrità? Io vedo piuttosto nell’atto di Leonardo la tolleranza che deriva dall’apertura mentale e dalla magnanimità.
La capacità di Leonardo di svincolarsi dalle convenzioni ci ricorda il concetto buddista di “trascendere il mondo”. Per “mondo” si intende il regno delle differenze tra bene e male, amore e odio, bellezza e bruttezza, vantaggio e svantaggio. “Trascendere il mondo” significa liberarsi dall’attaccamento a tutte queste distinzioni.
Il Sutra del Loto, supremo insegnamento del Buddismo, parla della necessità di guidare gli esseri viventi per «far sì che essi rinuncino ai propri attaccamenti». Nichiren, ai cui insegnamenti si ispirano le attività della Soka Gakkai, commentando il sutra afferma: «La parola rinunciare in realtà significa discernere». Non è sufficiente liberarsi semplicemente dagli attaccamenti, dobbiamo analizzarli chiaramente e attentamente per vederli per quello che sono. Dunque, “trascendere il mondo” significa costruire un forte io interiore che permetta di fare un uso corretto di ogni attaccamento.
Le ultime parole del Budda Shakyamuni furono: «Tutti i fenomeni sono transitori. Perfezionate la vostra pratica e non diventate mai negligenti». Anche Nichiren esorta a «rafforzare la tua fede giorno dopo giorno e mese dopo mese. Se ti rilassi anche solo un po’ i demoni prenderanno il sopravvento».
E in un altro brano esprime la più profonda delle verità sulla vita: «Anche uno specchio appannato brillerà come un gioiello se viene lucidato. Una mente annebbiata dalle illusioni derivate dall’oscurità innata della vita è come uno specchio appannato che però, una volta lucidato, diverrà chiaro e rifletterà l’illuminazione della verità immutabile» (Gli scritti di Nichiren Daishonin, vol. 4, p. 5).
Il distacco da ciò che è transitorio e illusorio è un segno di carattere, un altro nome per descrivere un essere umano completo. I principi che ho menzionato non sono mere astrazioni ma qualcosa che chi vuole migliorare il proprio carattere deve ricercare dentro di sé.
Josei Toda uscì dal carcere, in cui l’avevano rinchiuso per due anni le autorità militariste giapponesi, per dare avvio a un nuovo movimento umanista in Giappone. Egli era sempre concentrato sul far crescere persone di carattere, una alla volta, in mezzo alla popolazione. Ho molti cari ricordi di quell’uomo pieno di compassione, il cui amore per la gioventù non conosceva confini e che ci incoraggiava a essere grandi attori sul palcoscenico della vita.
In effetti il potere del carattere è come l’energia concentrata di un attore che si cala completamente nell’interpretazione del proprio ruolo. Una persona di notevole carattere, anche nelle circostanze più difficili mantiene sempre un aspetto composto e a proprio agio e non perde nemmeno il senso dell’umorismo. Questo non è altro che l’aver raggiunto la padronanza o il controllo di sé.
Una volta chiesero a Goethe, che in aggiunta ai suoi molteplici talenti era anche un eccellente regista teatrale, che cosa cercasse in un attore ed egli rispose: «Soprattutto controllo di sé. Un attore che non è padrone di se stesso, che non è capace di mostrarsi a uno sconosciuto nella sua luce migliore, in genere ha ben poco talento. È la sua professione stessa che richiede una continua negazione di sé».
L’idea di autocontrollo di Goethe corrisponde al concetto di moderazione nella filosofia platonica. L’autocontrollo non è soltanto una qualità essenziale per un attore ma si può dire che sia il requisito principale per lo sviluppo del carattere.
Il carattere e la “rivoluzione umana"
Il punto dunque è: «Che cosa può produrre una cambiamento nel carattere?». Nella pratica buddista coltivare la consapevolezza della propria “condizione vitale” e fare sforzi assidui e tenaci per elevarla costituisce la padronanza di se stessi, la pratica della “rivoluzione umana”.
C’è un insegnamento centrale della filosofia buddista che ha una diretta rilevanza per la questione della formazione del carattere. Il Buddismo classifica gli stati o condizioni vitali che costituiscono l’esperienza umana nei cosiddetti dieci mondi. Dal più basso al più desiderabile essi sono: il mondo d’Inferno, una condizione immersa nella sofferenza; il mondo di Avidità, in cui corpo e mente sono avvolti dalle furiose fiamme del desiderio; il mondo di Animalità, in cui si teme chi è più forte e ci si approfitta di chi è più debole; il mondo di Collera, caratterizzato dal desiderio compulsivo e costante di superare e dominare gli altri; il mondo di Umanità, una condizione tranquilla caratterizzata dalla capacità di formulare giudizi razionali; il mondo d’Estasi, uno stato colmo di gioia; il mondo di Studio, la condizione in cui si aspira all’illuminazione; il mondo di Realizzazione in cui, senza alcun aiuto esterno, percepiamo la vera natura dei fenomeni; il mondo di Bodhisattva, una condizione compassionevole in cui si cerca di salvare tutte le persone dalla sofferenza e infine il mondo di Buddità, una condizione di completezza umana e perfetta libertà.
All’interno di ognuno di questi stati si ritrova a sua volta l’intero spettro dei dieci mondi. In altre parole, lo stato d’Inferno contiene al suo interno ogni stato da Inferno a Buddità. Nella visione buddista, la vita non è mai statica bensì è un flusso costante di trasformazioni dinamiche, di momento in momento, da uno stato all’altro. Il punto fondamentale è dunque quale di questi dieci stati, che esistono in un vibrante flusso vitale, costituisce la base delle nostre vite individuali. Il Buddismo ci offre, come esistenza umana ideale, un modo di vivere basato sugli stati più alti, quelli di Bodhisattva e Buddità.
Naturalmente le emozioni – gioia, dolore, piacere e collera – sono l’ordito sul quale si dipana il tessuto della vita e noi continuiamo a sperimentare l’intera gamma dei dieci mondi. Queste esperienze però possono essere modellate e indirizzate dagli indistruttibili stati di Bodhisattva e Buddità.
La filosofia della rivoluzione umana, su cui si basa la SGI, ricorda il concetto leonardesco di dominio di sé. Traducendo in azione le nostre convinzioni noi sosteniamo le Nazioni Unite, svolgiamo molte altre attività a beneficio della pace e della cultura e, grazie a queste iniziative, contribuiamo alla società nel suo complesso. Allo stesso tempo sottolineiamo l’importanza della riforma interiore del singolo. «Il tuo maestro sei tu» affermano le scritture buddiste. «Chi altro potrebbe esserlo? Quando si acquisisce il controllo su se stessi, si è acquisito un maestro di raro valore».
E un altro brano recita: «Sii la tua stessa lampada. Conta su te stesso. Tieniti stretta la Legge come una lampada, non contare su nient’altro».
Il grande io e il piccolo io
Entrambi questi brani esortano a vivere in maniera indipendente, fedeli a se stessi e senza farsi sviare dagli altri. Ma l’“io” a cui si fa riferimento qui non è il “piccolo io” buddista, prigioniero dell’egoismo. È il “grande io” che è fuso con la vita dell’universo, attraverso la quale causa ed effetto si intrecciano fino ai confini illimitati dello spazio e del tempo.
Il grande io cosmico è simile al “sé” unificante e integrante che Carl G. Jung percepiva nelle profondità dell’io. È simile anche alla «bellezza universale con la quale ogni parte e particella è ugualmente in relazione: l’Uno eterno» di cui parlava lo scrittore Ralph Waldo Emerson.
Sono fermamente convinto che un risveglio al “grande io” su larga scala condurrà il mondo a una coesistenza creativa nel prossimo secolo. [...]
Il grande io del Buddismo mahayana è un altro modo di esprimere l’apertura e l’espansione del carattere che abbraccia le sofferenze di tutte le persone come se fossero le proprie. Questo io cerca sempre modi per alleviare il dolore e aumentare la felicità degli altri, qui, nella realtà della vita di tutti i giorni.
Solo la solidarietà che può generare una così naturale nobiltà umana spezzerà l’isolamento dell’io moderno e farà sorgere una nuova speranza per la civiltà. Inoltre il risveglio dinamico e vitale del grande io permetterà a ognuno di noi di sperimentare con pari piacere sia la vita che la morte. Come afferma Nichiren: «Adorniamo la torre preziosa del nostro essere con i quattro aspetti di nascita, invecchiamento, malattia e morte».
Se siamo sufficientemente padroni di noi stessi non ci sentiremo costretti a imporre i nostri valori agli altri e nemmeno a calpestare i costumi e i valori a loro cari. Il controllo di sé ci impedisce anche di cercare di razionalizzare tutto in termini economici, incuranti delle condizioni, delle percezioni e delle diversità degli altri paesi, impedendoci così di autorelegarci all’ignobile stregua di animali economici.
Rispetto per tutta l’umanità
Nel Sutra del Loto c’è un bodhisattva chiamato Mai Sprezzante. Egli crede che, poiché tutti gli esseri umani posseggono la natura di Budda, nessuno possa essere disprezzato, che a tutta la vita e a tutta l’umanità vada accordato il massimo rispetto. Anche quando persone tronfie e arroganti lo denunciano e lo colpiscono con bastoni e pietre, egli continua a rifiutarsi di disprezzarli, convinto che ciò equivarrebbe a disprezzare il Budda. E continua a predicare questa dottrina fino alla fine, manifestando un supremo rispetto per l’umanità in ogni sua parola o azione.
L’incrollabile convinzione del Bodhisattva Mai Sprezzante è un esempio del tipo di autocontrollo che dobbiamo sviluppare in noi stessi. Nel Sutra del Loto, la storia del Bodhisattva Mai Sprezzante è una parabola sull’essenza della disciplina buddista.
È simile anche alla tesi platonica per cui dovremmo imparare a porre le nostre anime sotto il controllo della “parte razionale” e illustra l’importanza dell’autocontrollo come virtù universale di tutta l’umanità e requisito primario di un mondo senza guerre.
Per il bene della pace. Sette sentieri verso l'armonia globale. Una prospettiva buddista - di Daisaku Ikeda
Capitolo 3° - La strada del dialogo e della tolleranza - AUDIO generato con un sintetizzatore vocale

L’apertura creativa nei confronti degli altri, che conduce alla comprensione e alla solidarietà, è la chiave di volta per ottenere la pace, mentre l’assenza di pensiero critico porta solo a fanatismo e intolleranza. In questo scritto, che corrisponde al terzo capitolo del volume For the Sake of Peace, Daisaku Ikeda rintraccia tale modo di vedere, centrale nella tradizione buddista, in pensatori diversi della cultura occidentale, nel corso dei secoli.
Il radicalismo, per sua stessa natura, è destinato a fare ricorso alla violenza e al terrore, mentre l’arma più potente del gradualismo, il suo opposto, è il dialogo. Secondo Socrate il dialogo è una lotta verbale in cui non è ammissibile la ritirata; ne era così fortemente coinvolto da non temere neppure la morte. Per portare avanti un dialogo di questo tipo occorrono risorse di energia e forza spirituale ben maggiori e ben più profonde di quelle possedute da coloro che ricorrono facilmente alla violenza.
I veri semi della pace non sono fatti di nobili ideali ma di comprensione e solidarietà umana. Solo nello spazio aperto del dialogo con i propri vicini, con la storia, la natura o l’universo l’essere umano può svilupparsi completamente. Un individuo disimpegnato, chiuso nel suo silenzio, può arrivare solo al suicidio spirituale. Non si nasce umani, se non in senso biologico; noi “impariamo” a conoscere noi stessi e gli altri, apprendendo così le modalità di comportamento da esseri umani. E possiamo farlo soltanto immergendoci nell’oceano del linguaggio e del dialogo, alimentato dalle sorgenti della tradizione culturale.
Mi sovviene nuovamente quel brano splendido e toccante del Fedone in cui Platone descrive Socrate che insegna ai suoi giovani discepoli come l’avversione per il linguaggio e le idee conduca all’antipatia per l’umanità. La sfiducia nel linguaggio o una fede eccessiva nel suo potere dipendono entrambe dalla fragilità spirituale, che rende incapaci di reggere la tensione della vicinanza umana indotta dal dialogo. Questa sorta di debolezza spirituale fa oscillare tra fiducia gratuita e sospetto degli altri, rendendo così l’individuo preda di forze disgregatrici.
I nostri sforzi di dialogare, perché siano degni di essere chiamati dialogo, devono essere portati fino in fondo. Rifiutare lo scambio pacifico e scegliere di usare la forza significa venire a compromessi con la debolezza umana, cedere a essa. Significa ammettere la sconfitta dello spirito. Socrate incoraggia i suoi giovani discepoli ad allenarsi e rafforzarsi spiritualmente, a conservare la speranza e il dominio di sé, ad avanzare coraggiosamente, a preferire la virtù alla ricchezza materiale e la verità alla fama.
Non è possibile analizzare la moderna società di massa secondo i valori degli antichi greci, ma non è neanche il caso di enfatizzarne eccessivamente le differenze. Walter Lippmann, uno dei più grandi giornalisti del XX secolo, nel suo famoso saggio L’opinione pubblica indica ripetutamente il dialogo socratico e gli individui “socratici” come strumenti chiave per una più sana formazione di una pubblica opinione. Un’educazione basata sul dialogo aperto è ben più di un mero passaggio di informazioni e conoscenze. Ci permette di sollevarci oltre i confini delle nostre anguste prospettive e passioni di parte. Le istituzioni preposte a un’educazione più elevata hanno il compito di favorire la crescita di cittadini del mondo di tipo socratico e di ricercare nuovi princìpi per una pacifica integrazione dell’umanità.
Il Buddismo e il potere del dialogo
Il Budda Shakyamuni, che viene spesso menzionato insieme a Socrate come uno dei più grandi insegnanti del mondo, trascorse i suoi ultimi momenti di vita esortando i discepoli addolorati a dialogare con lui. Fino all’ultimo istante li esortò a interrogarlo su questo o quell’argomento, come se stessero parlando con un amico.
Sin dagli albori la filosofia buddista è sempre stata associata alla pace e al pacifismo. Tale caratteristica deriva principalmente da un coerente rifiuto della violenza e dal considerare il dialogo e la discussione come i migliori mezzi per risolvere i conflitti. La vita di Shakyamuni, totalmente libera dalle pastoie del dogmatismo, e i rapporti con i suoi compagni evidenziano quanto egli ritenesse importante il dialogo. Il sutra che narra i viaggi in cui culminò la sua pratica buddista inizia con un episodio nel quale l’anziano Shakyamuni usa il potere del linguaggio per impedire un’invasione. Il Budda, allora ottantenne, invece di ammonire in maniera diretta il ministro del Magadha, intenzionato a conquistare lo Stato confinante di Vaji, gli parlò invece in maniera convincente dei princìpi che governano la prosperità e il declino di una nazione. Il suo discorso dissuase il ministro dallo sferrare l’attacco previsto. L’ultimo capitolo dello stesso sutra si conclude con una toccante descrizione di Shakyamuni sul letto di morte. Mentre giaceva morente, esortava ripetutamente i discepoli a esporre qualsiasi incertezza potessero avere riguardo alla Legge buddista (Dharma) o alla sua pratica, in modo che dopo la sua morte non dovessero rammaricarsi per qualche domanda inespressa.
Fino all’ultimo, Shakyamuni ricercò attivamente il dialogo e il dramma del suo viaggio finale è illuminato dall’inizio alla fine dalla luce del linguaggio, usato con perizia da questo vero “maestro della parola”1.
Attaccamento alle differenze
Come mai Shakyamuni riusciva a usare il linguaggio con tanta disinvoltura ed efficacia? Cosa faceva di lui un maestro di dialogo senza eguali? Penso che la sua eloquenza fosse dovuta alla vastità della sua condizione illuminata, assolutamente libera da dogmi, pregiudizi e attaccamenti. Un esempio è la sua frase: «Percepii un’unica invisibile freccia che trafigge il cuore delle persone».2 La freccia simboleggia uno stato d’animo incline al pregiudizio, che enfatizza senza motivo le differenze individuali. L’India di allora attraversava una fase di trasformazione e di agitazioni sociali e gli orrori del conflitto e della guerra erano all’ordine del giorno. Lo sguardo penetrante di Shakyamuni percepì con chiarezza che la causa profonda del conflitto era l’attaccamento alle distinzioni, alle differenze etniche, nazionali o d’altro tipo.
Agli inizi del XX secolo, il filosofo Josiah Royce affermò: «In simili questioni, se riforma ci dev’essere, deve venire dal di dentro... La sfera pubblica viene determinata dai processi che, nel bene o nel male, accadono nelle singole menti».3
Come evidenzia Royce, la “freccia invisibile” del male non consiste nell’esistenza di razze o classi, ma si trova nei nostri cuori. Vincere sui pregiudizi e sull’attaccamento alle differenze è la precondizione indispensabile per un dialogo aperto. Quest’ultimo a sua volta è fondamento essenziale della pace e del rispetto universale per i diritti umani. La totale assenza di pregiudizi di Shakyamuni gli permise di esporre la Legge con la massima libertà, adattando il modo d’insegnare al carattere e alle capacità della persona a cui stava parlando.
Sia che stesse facendo da mediatore in una disputa sui diritti di approvvigionamento idrico, che stesse convertendo un violento criminale o ammonendo qualcuno che si rifiutava di praticare la questua, Shakyamuni cercava sempre anzitutto di rendere l’altro consapevole della freccia del proprio male interiore. Il potere della sua straordinaria personalità fece dire a un sovrano suo contemporaneo: «Coloro che non riusciamo a indurre alla resa con la forza delle armi, voi sapete sottomettere disarmato».4
Il potere della parola è lo strumento primario di un “campione dello spirito”. Il linguaggio, che per lungo tempo è stato considerato l’unico tratto che distingue nettamente gli esseri umani dagli altri animali, spesso è stato il fattore decisivo per la vittoria. La storia è piena di sanguinose battaglie fra popoli asserviti al potere della brutalità, dell’autorità e del denaro. Ma anche nel panorama spoglio e desolato del conflitto e dell’uccisione emergono alcuni esempi nei quali il potere della parola ha portato alla vittoria. Uno dei più evidenti è la rivoluzione americana, senza la quale la democrazia negli Stati Uniti sarebbe stata impossibile. In quel caso le capacità di autocontrollo, equilibrio e autodeterminazione, che io ritengo indispensabili per uno spirito che vuole manifestare il bene, produssero tendenze diverse da quelle riscontrabili nella rivoluzione francese e in quella russa.
La parola e la rivoluzione
Alla vigilia e nelle fasi iniziali di tutte le principali rivoluzioni moderne _ americana, francese e russa _ la parola fu utilizzata per divulgare la causa. Ne I dieci giorni che sconvolsero il mondo, lo stupefacente reportage della rivoluzione russa, il giornalista americano John Reed descrive vividamente questo fenomeno: «Tutta la Russia stava imparando a leggere e leggeva di politica, economia, storia, perché la gente voleva sapere… In ogni città e nella maggior parte dei paesi lungo il fronte ogni fazione politica aveva il suo giornale, a volte anche più d’uno. Centinaia di migliaia di opuscoli venivano distribuiti da migliaia di organizzazioni e si diffondevano negli eserciti, nei villaggi, nelle fabbriche e per le strade. La sete di istruzione, così a lungo frustrata, fremeva per essere espressa nella rivoluzione. Soltanto dall’Istituto Smolny nei primi sei mesi uscirono ogni giorno tonnellate di materiale da leggere che saturarono il paese. La Russia assorbiva carta stampata in maniera insaziabile, come la sabbia rovente beve l’acqua. E non si trattava di fiabe, di falsi resoconti storici, di religione annacquata o di quella narrativa a buon mercato che involgarisce lo spirito, ma di teorie economiche e sociali, filosofia, opere di Tolstoj, Gogol, Gorky…»5.
Questo brano è una brillante descrizione di come l’energia in un popolo aumenti una volta riacquisita l’arma della parola. Qualcosa di simile accadde nelle prime fasi della rivoluzione francese. Ma purtroppo, in entrambi i casi, la violenza degli eventi successivi travolse senza pietà quell’energia, e alla libertà di parola si sostituirono la tirannia e il terrore. Le persone furono costrette al silenzio e lo spirito fu sconfitto.
In America invece, come spiega lo storico francese Alexis de Tocqueville nella sua classica analisi, le assemblee cittadine che caratterizzarono gli inizi del New England furono la culla della democrazia di base. Al tempo della rivoluzione americana le energie della cittadinanza erano dirette sia verso il presente, sotto forma di lotta per l’indipendenza, sia verso il futuro, alla ricerca di un ordine politico indipendente. L’energia della liberazione era allo stesso tempo energia costruttiva. Ne è prova il fatto che, durante la lotta per affrancarsi dall’Inghilterra, tutte le tredici colonie originali compilarono la propria costituzione. O che, nello stesso periodo, lo Stato della Virginia stava redigendo il Decreto sui diritti della Virginia, che è rimasto un modello nel suo genere.
Le parole e lo “spirito astratto”
Ma le parole possono essere scisse dalla loro funzione comunicativa, il dialogo, e la loro forza può essere utilizzata in maniera distorta per giustificare una causa inumana. Questo accade quando si fa l’errore di collocare l’ideologia al di sopra della realtà di ogni singola persona, sacrificando vite umane allo “spirito astratto”. Osserva ancora acutamente Gabriel Marcel: «Quando qualcuno – lo Stato, un partito, una fazione o una setta religiosa – pretende di convincermi che quello che sto commettendo è un atto di guerra nei confronti di altre persone che devo esser pronto ad annientare, è assolutamente necessario che io non sia più consapevole dell’esistenza individuale dell’essere che sto cercando di sottomettere. Per trasformarlo in capro espiatorio è indispensabile che lo converta in un’astrazione: il comunista, il fascista, l’antifascista e così via…»6.
È un’argomentazione plausibile. In guerra o in altre circostanze non è così facile indurre a usare la violenza nei confronti di altri esseri di cui si percepiscono l’esistenza concreta e personale. Ciò vale in maniera particolare tra persone che si conoscono bene o che vivono vicine.
Pregiudizi e stereotipi
Per motivare le persone alla guerra bisogna mascherare l’astrazione _ il Nemico _ con un costume ben riconoscibile: lo stereotipo. Walter Lippmann fa un’analisi incisiva di come la credenza conduca facilmente, attraverso lo stereotipo, a una percezione distorta del mondo intorno a noi. Lippmann si guadagnava da vivere facendo il giornalista, una professione che Marcel disprezzava per il suo «effetto… quasi invariabilmente corruttore». L’opinione pubblica di Lippmann è un’opera coscienziosa, uno sforzo autocritico di evidenziare le ragioni più profonde del malessere che ha afflitto la civiltà del XX secolo.
«Se non stiamo estremamente attenti, rischiamo di visualizzare sempre le cose che ci sembrano familiari secondo l’immagine che già abbiamo in mente» osserva Lippmann e prosegue affermando: «Eccetto quando facciamo uno sforzo cosciente per sospendere i pregiudizi, noi non studiamo una persona e la giudichiamo cattiva. Noi vediamo una persona cattiva. Vediamo un rugiadoso mattino, una fanciulla che arrossisce, un prete santo, un inglese privo di senso dell’umorismo, un pericoloso Rosso, uno spensierato bohemienne, un pigro indù, un orientale furbo, uno slavo sognatore, un irlandese volubile, un ebreo avaro e un americano “cento per cento”».7
Per Lippmann questi stereotipi corrompono l’opinione pubblica sin dal principio. Come il nazionalismo, anche l’opinione pubblica può essere considerata un riflesso della volontà popolare; tuttavia in molti casi le persone vengono suggestionate da slogan basati su stereotipi e indotte a commettere atti di violenza incontrollata, impensabili in circostanze normali. Secondo Lippmann, l’opinione pubblica nella società di massa è caratterizzata dal fatto che gli stereotipi rendono l’individuo «dogmatico, perché quello in cui crede diventa un mito assoluto».
Ideologie come il comunismo hanno prodotto una stupefacente quantità di individui dogmatici, superficiali, intolleranti e fanatici. È impossibile dialogare veramente con persone intolleranti o di mentalità ristretta. Fin quando rimangono chiuse nei propri miti, per quanto possano chiacchierare _ anzi più prolisse e pompose sono peggio è _ non riusciranno a condurre un dialogo ma faranno solo monologhi.
La ribellione delle masse
Quando si parla di teoria della società di massa nel XX secolo non si può dimenticare José Ortega y Gasset, al posto d’onore per la sua pionieristica analisi filosofica. Alcuni sono convinti che la sua opera principale, La ribellione delle masse, abbia rivestito per il XX secolo lo stesso significato che Il contratto sociale di Jean-Jacques Rousseau ebbe per il XVIII o Il capitale di Karl Marx per il XIX. Dall’alto del suo nobile spirito, Ortega y Gasset concentra le sue straordinarie capacità critiche sull’analisi di quel fenomeno peculiare del XX secolo che è l’ascesa delle masse. E a più di mezzo secolo di distanza la sua opera è ancora colma di preziosi spunti di riflessione per l’età contemporanea.
Anche Ortega y Gasset attribuiva grande importanza al dialogo come fattore centrale nella creazione di cultura. Tuttavia non è possibile avviare un dialogo senza regole fisse che ci guidino. Sono proprio queste regole condivise che costituiscono il principio su cui si basa la cultura.
«Allorché mancano tutte queste cose non c’è cultura; c’è, nel senso più rigoroso della parola, barbarie. E questo – non facciamoci illusioni – è proprio quello che comincia ad accadere in Europa, sotto la progressiva ribellione delle masse».8
La parola “masse”, come viene usata qui, non si riferisce a un particolare strato sociale. L’“uomo-massa” di Ortega y Gasset è un nuovo genere di essere umano che egli chiama “nuovo Adamo” o “bambino viziato”. La struttura del suo spirito è costituita da due caratteristiche fondamentali: l’“ermetismo”, che deriva dall’ebbrezza di soddisfazione di sé e da un superficiale senso di vittoria, e l’“indocilità”, che gli consente di fare ciò che vuole, incurante di regole o norme. Nel seguente brano viene analizzata la mentalità dell’uomo-massa: «Questo appagamento di sé lo porta a chiudersi a ogni istanza esterna, a non ascoltare, a non mettere sulla bilancia del giudizio le proprie opinioni e a non far conto degli altri. La sua sensazione intima di dominio lo stimola costantemente a esercitare un’azione di predominio. Agirà, quindi, come se soltanto lui e i suoi consimili esistessero al mondo…».9
È veramente il ritratto di una persona schiava di una mentalità chiusa, una condizione che genera a sua volta i mali della civiltà che abbiamo appena discusso: l’assenza di pensiero critico che conduce al fanatismo e all’intolleranza.
Gabriel Marcel, Walter Lippmann e José Ortega y Gasset erano contemporanei e i loro scritti esprimono la stessa profonda preoccupazione per il fatto che la chiusura mentale priva le persone della capacità di dialogare con gli altri, capacità che è la prova stessa della nostra umanità; e considerano questa come la causa dei gravi mali che osservavano intorno a loro.
Quest’impulso esclusivista ha afflitto la società umana sin dall’alba della storia. Il filosofo Henri Bergson lo definiva criticamente come la tendenza verso una “società chiusa” e in tempi più recenti il saggista americano Norman Cousins lo chiama “coscienza tribale”. In una società chiusa va tutto bene finché si rimane all’interno del gruppo, ma appena si entra in contatto con altre culture e società i membri si autorecludono e rifiutano di partecipare proprio a quel dibattito che sarebbe la dimostrazione della loro umanità. E alla fine ricorrono alla violenza. Quando due culture s’incontrano e una di loro o entrambe non sono capaci di tollerare la cultura o il modo di vivere dell’altra, basta solo che gli attriti crescano oltre una certa soglia per provocare uno scontro frontale.
Superare l’attaccamento negativo alle differenze, o discriminazione, e determinare una vera fioritura della diversità umana sono le chiavi per generare una cultura di pace duratura. E il dialogo è il mezzo per acquisire questa tolleranza attiva.
Montaigne e la tolleranza
Parlando di tolleranza non si può evitare di menzionare Montaigne. Il grande filosofo, fermo assertore dell’importanza del dialogo, ripeteva spesso che la discussione è il miglior mezzo per abbattere le differenze fra individui, per stimolare la crescita personale e il senso di disciplina di ognuno.
Montaigne visse nel XVI secolo in Francia, dove le dispute religiose causarono tragedie a ripetizione, come il massacro di San Bartolomeo nel 1572 durante le guerre degli Ugonotti. Nei suoi Saggi fa notare che lo zelo abbonda quando si tratta di mettere in pratica le nostre disposizioni all’odio, alla crudeltà, all’ambizione, all’avarizia, alla critica o alla ribellione, mentre scarseggia facilmente quando cerchiamo di essere buoni, gentili ed equilibrati. E deplora anche il fatto che la religione, che dovrebbe sradicare il vizio, in realtà spesso provoca, incoraggia o aggrava il male. Vivendo in mezzo ai tumulti religiosi e avendo spesso assistito a omicidi indotti da una fede fanatica o dalla ricerca di vantaggi personali, Montaigne esortava alla tolleranza per far cessare le dispute. Dopo la sua morte, la sua dottrina fu inclusa nell’Editto di Nantes (1598), che riconosceva agli eretici il diritto di praticare liberamente le proprie convinzioni religiose. Inoltre il suo resoconto delle attività dei cristiani che avevano fondato colonie oltremare, della loro brutalità e delle azioni da loro commesse, ben più immorali degli indigeni idolatri che avevano incontrato, contribuì a promuovere quello che adesso si chiamerebbe relativismo religioso. Viene spesso sottolineato che le osservazioni di Montaigne sconvolsero i cristiani di buona volontà del suo tempo, inducendo molti di loro a riflettere su se stessi. Lo scrittore austriaco Stefan Zweig ha espresso con vigore il suo assenso al pensiero di Montaigne, affermando che era l’amico di tutte le persone libere.
Montaigne, in quei tempi difficili e turbolenti, attribuiva la massima importanza al dialogo. Riteneva che «la conversazione fosse l’esercizio più fruttuoso e naturale per le nostre menti, e la sua pratica la cosa più piacevole di qualsiasi altra al mondo». Come condizione assoluta per la conversazione egli indicava una mente aperta e dichiarava: «Nessuna asserzione mi sorprende, nessuna credenza mi offende per quanto possano essere opposte alle mie. Non c’è fantasia, per frivola o stravagante che sia, che non mi paia un naturale prodotto della mente umana». E affermava inoltre: «Perciò le opinioni che mi contraddicono non mi offendono né mi allontanano, sono solo uno stimolo a esercitare la mia mente. Noi rifuggiamo dal venire corretti e invece dovremmo ricercare la correzione ed esporci a essa, specialmente quando accade nel corso di una discussione e non di una lezione scolastica».10
Montaigne prendeva alla lettera l’asserzione di Cicerone secondo cui senza confutazione non vi può essere dibattito, e andava oltre affermando che lo scopo del dialogo è la ricerca della verità. «Do il benvenuto alla verità e l’abbraccio, indipendentemente dalle mani in cui la trovo. Mi arrendo volentieri a essa e appena la scorgo in lontananza rassegno a essa le mie armi sconfitte».11 Sono i sentimenti di un vero re dello spirito, un brillante esempio di grande integrità applicata alla libera discussione.
Vorrei aggiungere inoltre che per dialogare è indispensabile anche un vivace spirito critico. All’epoca di Montaigne, la disputa tra Protestantesimo e Cattolicesimo lacerò la società francese. Ci furono reiterati massacri da entrambe le parti, ma in mezzo a quella follia Montaigne riuscì a vivere secondo le proprie convinzioni. Il suo spirito indomito viene descritto nella biografia critica di Zweig: «Pochi uomini sulla terra hanno combattuto con più sincerità e veemenza affinché il loro sé più profondo, la loro essenza, non fosse contaminata dalle insulsaggini velenose e oscure dei loro tempi e ben pochi uomini sono riusciti a salvare il proprio sé più profondo dai tempi».12
Lo stesso Montaigne disse che era inutile mettersi a dialogare con persone le cui opinioni non erano sostenute dalla razionalità e dal senso critico. Egli non vedeva il senso di discutere con persone indisciplinate o instabili nelle proprie convinzioni. E affermò anche che pensare in termini critici comprende anche la capacità di fare un severo esame di coscienza.
L’approccio buddista al dialogo
Il vero dialogo è possibile solo quando entrambe le parti si impegnano a mantenere l’autocontrollo. Ma c’è un altro elemento essenziale senza il quale il dialogo diventa retorica manipolatoria: una rispettosa compassione dell’altro, per quanto possa essere culturalmente diverso da noi o sostenga interessi apparentemente opposti ai nostri. L’approccio buddista può, a mio avviso, spezzare i vincoli dei concetti astratti e del linguaggio che possono essere tanto distruttivi. Così liberati possiamo usare il linguaggio con la massima efficacia e intraprendere quel tipo di dialogo che crea il valore più grande e durevole. Il dialogo dev’essere il perno delle nostre attività, deve raggiungere tutte le persone, ovunque esse si trovino, per forgiare una nuova civiltà globale.
Nichiren aveva una fiducia assoluta nel potere del linguaggio. Se più persone ricercassero il dialogo con la stessa incrollabile tenacia, gli inevitabili conflitti inerenti alla vita umana troverebbero di certo una più facile soluzione. Il pregiudizio cederebbe il passo alla solidarietà e la guerra lascerebbe il campo alla pace. Il dialogo autentico produce la trasformazione dei punti di vista contrastanti da cunei che allontanano le persone a ponti che le uniscono.
Le qualità umane necessarie a mettere in pratica questo principio travalicano l’ambito della mera diplomazia; è un compito che richiede un’elevata condizione vitale. Il Bodhisattva della Terra descritto dal Sutra del Loto è una persona che si dedica a ristabilire un senso di armonia cosmica nella società contemporanea. In pratica ciò significa essere un maestro nell’arte del dialogo e un portabandiera del potere morbido. Il Sutra del Loto riassume le caratteristiche che questi bodhisattva devono possedere:
Con salda forza di volontà
e concentrazione,
ricercano la saggezza
con costanza e diligenza,
espongono
varie dottrine meravigliose
e le loro menti sono libere
dalla paura.13
Abili nel rispondere a difficili domande,
le loro menti non conoscono
la paura.
Hanno coltivato con assiduità
la perseveranza,
sono fieri di dignità e di virtù.14
La paura erige barriere di avversione e discriminazione sotto forma di confini nazionali o di esclusione e discriminazione in base alla razza, alla religione, al genere, alla classe sociale, alle condizioni economiche o semplicemente alle preferenze personali. Come fece notare Lippmann, per sostenere e dissimulare i propri pregiudizi le persone dalla mente chiusa spesso riducono gli altri a stereotipi. È un atteggiamento che riflette un’indolenza mentale che impedisce di coltivare la comprensione e la fiducia reciproca e di sviluppare la perseveranza e la determinazione necessaria a poter dialogare. Come la storia ci insegna, dalla pigrizia mentale alla violenza il passo è breve. Perciò, nel lodare i Bodhisattva della Terra per la loro totale assenza di paura, il sutra sta elogiandone gli sforzi per trascendere ogni barriera discriminatoria e la prontezza a lanciarsi nel dialogo senza esitare. Il tono di questo dialogo sarà adeguato, di volta in volta, ai bisogni e agli umori del momento. A volte le loro parole saranno simili a una brezza risanatrice, a volte a colpi sonori, a volte saranno come un suono di campane che risveglia e a volte come una spada che spezza le illusioni. I loro sforzi nel dialogo sono sostenuti dalla ferma convinzione nell’eguaglianza ditutte le persone, cioè nel fatto che ognuna possiede il potenziale per l’Illuminazione.
È una profonda fede nell’umanità che ispira i Bodhisattva della Terra a dedicarsi costantemente al dialogo, nel tentativo di trovare un terreno comune e di armonizzare prospettive differenti.
Tre sono gli aspetti che riassumono la personalità e la mentalità dei Bodhisattva della Terra:
– la loro inflessibile severità con se stessi, come il freddo secco dell’inverno;
– il calore e la capacità di abbracciare gli altri come una dolce brezza primaverile;
– la capacità di affrontare il male senza compromessi, come un re leone.
Solo chi possiede queste caratteristiche può essere un vero maestro del dialogo. Il bodhisattva promette di salvare gli altri e basa ogni sua azione su questa promessa, che è un’espressione spontanea di altruismo. Non è un semplice desiderio o una decisione espressa, ma un impegno definitivo al quale il bodhisattva dedica tutto se stesso. Il bodhisattva rifiuta di farsi dissuadere o scoraggiare dalle difficoltà intrinseche in questa sfida. Il Sutra del Loto parla del puro fiore di loto che sorge dalle acque dello stagno fangoso. Questa analogia illustra l’ottenimento di uno stato vitale puro e possente in mezzo alle realtà a volte degradanti della società umana. Il bodhisattva non cerca mai di evadere dalla realtà, né rinuncia a salvare coloro che soffrono; si butta a capofitto nelle acque tempestose della vita per aiutare ogni persona che sta affogando nella sofferenza a raggiungere il grande vascello della felicità.
La natura del dialogo
Il dialogo non si limita a una discussione formale o a un placido scambio, lieve come una brezza primaverile. Ci sono tempi in cui, per spezzare la morsa dell’arroganza, il discorso deve essere come un alito di fuoco. Così, anche se tendiamo ad associare il Budda Shakyamuni alla mitezza, egli, quando ce n’era motivo, sapeva anche parlare in maniera spietata.
Allo stesso modo Nichiren, che dimostrava affetto paterno e tenera preoccupazione per le persone comuni, era inflessibile quando si confrontava con le autorità corrotte e degenerate. Sempre disarmato in un Giappone in cui la violenza era la regola, egli faceva affidamento esclusivamente e risolutamente sulla forza della persuasione e della nonviolenza. Gli avevano promesso potere se avesse rinunciato alla sua fede e avevano minacciato di decapitare i suoi genitori se avesse continuato ad aderire alle proprie credenze. Ma, nonostante questo, egli mantenne il coraggio delle proprie convinzioni. Il seguente brano, scritto dall’esilio su un’isola lontana dalla quale nessuno si aspettava che potesse ritornare è un esempio del suo spirito da leone: «Qualunque disgrazia possa capitarmi, a meno che uomini saggi non provino che i miei insegnamenti sono falsi, io non accetterò mai le pratiche delle altre sette!»15.
Nichiren scelse di agire come potrebbe fare solo qualcuno che ha deciso di dedicare la vita alla salvezza di tutta la specie umana. Si adoperò per chiarire fino in fondo quali fossero le teorie giuste e quelle sbagliate e per eliminare il male che tormentava la gente. La sua arma preferita fu la discussione, l’unica arma dell’illuminato.
Quando si dialoga con l’intenzione di influenzare gli altri, è impossibile procedere senza affrontare questioni di giustezza e di errore, di bene e di male. Perché, come dice Montaigne, lo scopo finale del dialogo è la ricerca della verità, e la critica reciproca che esercitano i partecipanti rappresenta la massima manifestazione dello spirito umano.
Quando ero giovane, Josei Toda ci diceva che «i giovani sono l’anima del Giappone perché dispongono di acute capacità critiche».
Egli desiderava ardentemente cancellare la miseria dalla faccia della terra ed esortava i giovani a combattere i numerosi mali che affliggevano la gente con un rigoroso allenamento alla riflessione critica.
Tolleranza non significa compromesso senza scrupoli. Per quanto vasto sia il dialogo, non si potrà realizzare niente di creativo e costruttivo concentrandosi solo sulle possibilità di compromesso senza cercare di distinguere il bene dal male, perdendo così la capacità di pensare criticamente. Al contrario, un simile approccio va contro il desiderio fondamentale dell’essere umano: la ricerca della verità.
La natura del dialogo
Il dialogo non si limita a una discussione formale o a un placido scambio, lieve come una brezza primaverile. Ci sono tempi in cui, per spezzare la morsa dell’arroganza, il discorso deve essere come un alito di fuoco. Così, anche se tendiamo ad associare il Budda Shakyamuni alla mitezza, egli, quando ce n’era motivo, sapeva anche parlare in maniera spietata.
Allo stesso modo Nichiren, che dimostrava affetto paterno e tenera preoccupazione per le persone comuni, era inflessibile quando si confrontava con le autorità corrotte e degenerate. Sempre disarmato in un Giappone in cui la violenza era la regola, egli faceva affidamento esclusivamente e risolutamente sulla forza della persuasione e della nonviolenza. Gli avevano promesso potere se avesse rinunciato alla sua fede e avevano minacciato di decapitare i suoi genitori se avesse continuato ad aderire alle proprie credenze. Ma, nonostante questo, egli mantenne il coraggio delle proprie convinzioni. Il seguente brano, scritto dall’esilio su un’isola lontana dalla quale nessuno si aspettava che potesse ritornare è un esempio del suo spirito da leone: «Qualunque disgrazia possa capitarmi, a meno che uomini saggi non provino che i miei insegnamenti sono falsi, io non accetterò mai le pratiche delle altre sette!»15.
Nichiren scelse di agire come potrebbe fare solo qualcuno che ha deciso di dedicare la vita alla salvezza di tutta la specie umana. Si adoperò per chiarire fino in fondo quali fossero le teorie giuste e quelle sbagliate e per eliminare il male che tormentava la gente. La sua arma preferita fu la discussione, l’unica arma dell’illuminato.
Quando si dialoga con l’intenzione di influenzare gli altri, è impossibile procedere senza affrontare questioni di giustezza e di errore, di bene e di male. Perché, come dice Montaigne, lo scopo finale del dialogo è la ricerca della verità, e la critica reciproca che esercitano i partecipanti rappresenta la massima manifestazione dello spirito umano.
Quando ero giovane, Josei Toda ci diceva che «i giovani sono l’anima del Giappone perché dispongono di acute capacità critiche».
Egli desiderava ardentemente cancellare la miseria dalla faccia della terra ed esortava i giovani a combattere i numerosi mali che affliggevano la gente con un rigoroso allenamento alla riflessione critica.
Tolleranza non significa compromesso senza scrupoli. Per quanto vasto sia il dialogo, non si potrà realizzare niente di creativo e costruttivo concentrandosi solo sulle possibilità di compromesso senza cercare di distinguere il bene dal male, perdendo così la capacità di pensare criticamente. Al contrario, un simile approccio va contro il desiderio fondamentale dell’essere umano: la ricerca della verità.
Il grande io
Naturalmente un’incessante riaffermazione delle proprie idee può degenerare in fanatismo e pregiudizio, come la storia dimostra in maniera così tragica ed eloquente. Com’è possibile risolvere questo annoso dilemma?
Credo che la risposta risieda nello sviluppo di un io più grande, come insegna il Buddismo mahayana. Le scritture buddiste ci dicono che l’io non deve avere altri padroni che se stesso. Ci esortano a non confonderci con gli altri ma a vivere con integrità, rimanendo fedeli a noi stessi. Tuttavia non si riferiscono all’io inferiore o ego ma al grande io che è fuso con la vita cosmica in una rete di relazioni causali che travalicano ogni limite di spazio e tempo. Quest’io più grande è un altro nome per indicare la condizione di apertura mentale di chi s’identifica con le sofferenze di tutti gli esseri senzienti. Quando si pone in relazione con gli altri membri della società, chi ha sviluppato il grande io è in grado “di togliere sofferenza e dare gioia”. Proprio per dare un esempio di questo modo di vivere, Nichiren Daishonin rischiò la propria vita e questo fu anche il modello a cui aderì rigorosamente Josei Toda.
Il grande io è la chiave, a mio avviso, per realizzare la tolleranza che rende possibile il dialogo autentico. La tolleranza può contribuire a creare una nuova epoca di coesistenza, e a rischiarare di speranza l’oscura cortina del pessimismo.
Il dialogo in politica
Se diamo uno sguardo spassionato al mondo attuale possiamo scoprire una nuova tendenza già all’opera sotto le violente onde del cambiamento. A mio avviso siamo alle soglie di una nuova epoca di dialogo. Per anni ho chiesto un dialogo concreto fra i vertici delle potenze mondiali. È necessario che questi leader si incontrino per uno scambio di opinioni franco e costruttivo, e che superino le differenze ideologiche e sociali liberandosi dai preconcetti. Solo allora si potranno porre le fondamenta per la pace nel XXI secolo.
Sono trascorsi più di trent’anni da quando Daniel Bell coniò l’espressione “fine dell’ideologia”, e finalmente stiamo assistendo al sorgere di un nuovo modo di pensare che, travalicando differenze politiche e ideologiche, considera la terra come un tutto unico e interconnesso. Si dice che il presidente Franklin D. Roosvelt, partecipando alla conferenza di Yalta, fosse deciso a seguire l’ammonimento di Ralph Valdo Emerson: «L’unico modo per farsi degli amici è esserlo». Da parte mia credo che quando il mondo politico perde di vista l’idealismo di Emerson è destinato a generare il mondo di bestie prefigurato da Platone.
La Soka Gakkai Internazionale continua a impegnarsi nel dialogo per il progresso della pace, dell’educazione e della cultura. Attualmente stiamo stringendo legami di solidarietà con i cittadini di 181 paesi del mondo.
In termini pratici, abbiamo cercato di promuovere dialoghi fra le civiltà incontrandoci con persone di ogni continente della terra. Ho discusso con i leader intellettuali delle varie confessioni religiose – Cristianesimo, Islamismo, Induismo ed Ebraismo – e spesso queste conversazioni sono state pubblicate. In base ad anni di esperienze di questo genere sono fermamente convinto della possibilità di un dialogo aperto e dell’importanza delle sue implicazioni per la società.
La Legge mistica (myoho), su cui si basa la fede della SGI, è scritta con il carattere cinese myo che ha tre significati: “aprire”, “essere dotato” e “rivitalizzare”. Come suggerisce il primo significato, la SGI è impegnata in un movimento buddista per aprire i cuori e le menti chiuse, che sono la causa della decadenza della civiltà.
La SGI non mira a curare semplicemente i sintomi superficiali di questa malattia ma vuole sradicarne le cause. Il trattamento sintomatico ovviamente è indispensabile in situazioni di emergenza come i frequenti dissidi etnici. Ma se dimentichiamo che l’attenzione deve essere rivolta soprattutto alle cause sottostanti, le nostre azioni non saranno che un susseguirsi di frenetici tentativi di gestire crisi momentanee, simili a chi cerca di spegnere un fuoco mentre già ne sta scoppiando un altro.
In un’epoca in cui si stavano intensificando le tensioni della guerra fredda, Josei Toda sosteneva l’idea della famiglia globale e pochi gli prestavano attenzione. Al massimo le sue idee venivano liquidate come fantasie irrealistiche. Ma oggi quest’idea è finalmente penetrata nella coscienza pubblica e il “transnazionalismo” è diventato un concetto fondamentale per spiegare e predire la futura direzione delle questioni globali. Di fonte a questa tendenza non possiamo che apprezzare ancor di più la notevole lungimiranza del signor Toda.
Anche se non abbiamo ancora fatto nemmeno il primo passo verso la creazione di un sistema adeguato alla nuova era, esiste un generale accordo sul fatto che le Nazioni Unite dovrebbero svolgere un ruolo centrale nella costruzione di un nuovo ordine globale pacifico. Sembra che – come disse l’ex-segretario dell’ONU Boutros Boutros-Ghali– «abbiamo nuovamente un’opportunità di raggiungere gli obiettivi della Carta, cioè ottenere un’ONU in grado di mantenere pace e sicurezza internazionale, di garantire giustizia e diritti umani e di promuovere, come la Carta stessa afferma, “progresso sociale e migliori condizioni di vita in un ambito di maggiore libertà”».16
Le organizzazioni che compongono la SGI svolgono in tutto il mondo attività mirate a creare la pace nelle rispettive zone, in accordo con il loro Statuto che afferma: «La SGI, basandosi sullo spirito buddista di tolleranza, rispetterà le altre religioni e si impegnerà a dialogare e collaborare con esse per la risoluzione dei problemi fondamentali dell’umanità». Infatti la SGI si è fatta promotrice del dialogo interreligioso patrocinando convegni e altre occasioni di scambio con istituzioni come l’Accademia europea di Scienze e Arti.
Negli ultimi anni, i nostri rappresentanti hanno partecipato al Parlamento delle religioni mondiali a Cape Town, in Sud Africa nel 1999, e al Vertice del Millennio per la pace mondiale dei capi religiosi e spirituali, tenutosi nel 2000 presso la sede delle Nazioni Unite a New York.
Per il bene della pace. Sette sentieri verso l'armonia globale. Una prospettiva buddista - di Daisaku Ikeda
Capitolo 4° - La via della comunità - AUDIO generato con un sintetizzatore vocale

Le persone che si dedicano ad acquisire padronanza di sé e a sviluppare il dialogo possono esercitare un grande influsso sui valori che stanno alla base degli attuali sistemi economici, politici, educativi, culturali e religiosi delle rispettive comunità. In questo articolo, che corrisponde al quarto capitolo del volume For the Sake of Peace, Daisaku Ikeda sostiene che all’efficienza economica e alla ricerca del profitto si devono sostituire scambi educativi e culturali che trascendano religione, razza e nazionalità
Economia globale e identità culturale
Ciò che mi preme, da buddista, è come affrontare il problema dell’identità, in quanto sono convinto che l’identità corretta di un vero cittadino del mondo si dovrebbe basare su una coscienza globale se non addirittura cosmica. È inevitabile che un’economia senza confini produca una cultura consumistica omogenea e standardizzata. Ma l’incapacità dello spirito umano di accontentarsi dell’identità impersonale di consumatore genera inevitabilmente attriti che a loro volta alimentano il particolarismo.
Ne parla Benjamin R. Barber della Rutgers University nel suo libro dal titolo provocatorio Jihad vs McWorld. Secondo Barber il mondo attuale si divide in McWorld, un parco a tema globale e omogeneo la cui forza trainante è «l’universalismo della motivazione del profitto (con la politica commerciale che l’accompagna)» e il «campanilismo dell’identità etnica (con la politica del rancore che l’accompagna)»1.
Dubito seriamente che sia consigliabile usare il termine islamico jihad come sinonimo generale di particolarismo e tuttavia nel ragionamento seguente adotterò il linguaggio del professor Barber perché evidenzia in maniera concisa le due tendenze contraddittorie del nostro mondo.
Fra McWorld e jihad non può esistere una demarcazione netta. Fintanto che ricercheranno il significato della loro vita gli esseri umani non potranno accontentarsi di vivere in una sterile società dei consumi e d’altro canto il campanilismo non potrà evitare la distruzione dell’ambiente globale né arrestare la marea dell’economia globale. Perciò siamo fatalmente destinati ad affrontare una crisi di identità che deriva dall’abitare in una miscela di questi due mondi.
In termini più profondi, il mondo attuale è dominato da quelli che il Buddismo chiama i “tre veleni”: avidità, collera e stupidità e, finché continueremo a vagare nelle tenebre dell’ignoranza, non troveremo mai la luce che ci conduca fuori dalla crisi.
Per la formazione di una democrazia globale sono indispensabili cittadini con una visione mondiale. Barber ripone grandi speranze nei cittadini che non rimangono chiusi nel proprio spazio privato ma cercano in maniera attiva e indipendente di partecipare agli affari pubblici. Egli definisce questo spazio di partecipazione “pubblico” e scrive: «La creazione di uno spazio pubblico è il compito di una società civile. Solo in esso potranno emergere tendenze che favoriscano la democrazia e contrastino il canto delle sirene del McWorld. Solo in uno spazio pubblico potranno svilupparsi comunità in grado di rispondere al bisogno umano di interazione su base locale ed etnica in modi che rimangano aperti all’inclusione e a sentimenti civici cosmopoliti».2
Lo spazio pubblico, il campo d’azione dei cittadini, è una zona intermedia fra il governo e il settore privato. Ma nell’atmosfera sterile della società urbana contemporanea sviluppare questo tipo di ambiente vitale è estremamente difficile. Barber non offre soluzioni chiare anche se trova uno spunto nelle vivaci discussioni che caratterizzavano le riunioni cittadine agli albori del New England e che rappresentano l’ideale della democrazia americana.
Alle origini dello spirito americano c’è una nazione sperimentale popolata da persone provenienti da tutto il mondo. Gli Stati Uniti sono una società globale in miniatura e prefigurano, nel bene e nel male, l’umanità di domani. Come società multirazziale, gli Stati Uniti stanno affrontando gravi problemi. Ma sono molto meno preoccupato degli aspetti negativi della situazione di quanto sia interessato invece alla vitalità, all’energia e alla creatività generata dalla cooperazione e dalla competizione di tanti popoli diversi. Nonostante le difficoltà, il fatto stesso che continui a esistere un paese come l’America, terra di giovani energie, libertà, democrazia ed eguaglianza, ci fa ben sperare nella possibilità di trovare una via per la pace globale.
Lo stato umanistico
Parlare di economia umanistica conduce inevitabilmente a chiedersi quale dovrebbe essere la struttura politica di uno stato umanistico. Nel 1974, mentre stavo preparando la mia prima visita in Unione Sovietica, molti in Giappone criticarono la mia decisione: «Perché mai un educatore buddista deve andare a visitare una nazione la cui ideologia stessa rifiuta la religione?» chiedevano. La mia risposta fu che sarei andato «perché là c’erano persone». Adesso, quasi tre decenni dopo, in una nuova realtà mondiale post-ideologica, è ancora più importante concentrarsi anzitutto sugli esseri umani e sulla maniera corretta di vivere. Lo spiega molto bene Aleksandr Solzhenitsyn: «La struttura dello stato è secondaria rispetto all’atteggiamento nelle relazioni umane. Se c’è integrità umana, qualsiasi sistema onesto è accettabile, ma se alla base c’è il rancore e l’egoismo umano, anche la democrazia più totale risulterà intollerabile. La mancanza di senso di giustizia e di onestà da parte delle persone verrà a galla sotto qualsiasi sistema».3
Un sistema politico di per sé non garantisce niente. I paesi dell’Europa orientale avranno anche spodestato governi oppressivi per conquistarsi libertà e (almeno così sperano) prosperità, eppure niente fa presagire quale sarà la direzione futura. Le rivolte servono a dimostrare il grande potere popolare e a ispirare altri popoli oppressi in ogni parte del mondo, ma non sono necessariamente garanzia di quel prospero futuro che in teoria promettono le società liberali del mondo occidentale, peraltro invece afflitte da numerosi problemi.
La realtà dei paesi capitalisti avanzati occidentali raramente permette eccessi di entusiasmo. Come indica la battaglia contro le droghe negli Stati Uniti, le malattie che devastano le nostre anime sono in stato assai avanzato. La minaccia nucleare può essere in parte diminuita ma non c’è neanche un momento da perdere per trovare soluzioni alla devastazione dell’ambiente, al depauperamento di preziose risorse naturali, alla crisi energetica e all’esplosione demografica. Laddove libertà e ricchezza dovrebbero essere usate per promuovere l’aspetto migliore dell’umanità, sembra che invece funzionino in maniera contraria. E va tenuto a mente che libertà e ricchezza possono a loro volta esigere un pesante tributo.
Anche con la fine della guerra fredda il senso di sicurezza a livello mondiale non è aumentato. Negli ultimi anni sempre più governi militari hanno ceduto il passo a forme più democratiche, una tendenza che alimenta nuove speranze per molte persone. Ma il rischio della guerra non è diminuito perché non esiste attualmente una tendenza dominante a livello mondiale verso il disarmo e nessun progresso è stato fatto verso l’abolizione della guerra come istituzione. Dove la guerra esiste, anche solo come remota possibilità, non vi sarà mai una comunità veramente umanistica.
Per questo il passo più importante per costruire una simile comunità è l’educazione.
Educazione per una comunità mondiale
Affinché il XXI sia un secolo di speranza, gli sforzi per costruire una comunità mondiale senza guerra devono essere affiancati ovunque dall’incentivo allo sviluppo delle risorse e delle potenzialità umane. Apprezzo i risultati conseguiti dall’UNESCO ma penso che ormai sia tempo che le Nazioni Unite nel loro complesso si impegnino in una vasta gamma di iniziative educative su scala globale. L’enormità dei problemi che dobbiamo risolvere su scala globale, fra cui povertà, fame, esplosione demografica e condizione ambientale richiede di essere affrontata dal punto di vista dell’umanità nel suo complesso. I dati indicano che circa novecento milioni di persone, pari al trenta per cento della popolazione mondiale di età superiore ai quindici anni, è analfabeta. La maggioranza di esse abita nei paesi del terzo mondo. Sebbene dopo la seconda guerra mondiale le spese militari in tutto il mondo avessero continuato a crescere, il disgelo nelle relazioni Est-Ovest ha invertito tale tendenza contribuendo a ridurle ai livelli più bassi riscontrati dal dopoguerra a oggi. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite basterebbe circa il cinque per cento dell’investimento annuale mondiale a scopo difensivo per garantire abbastanza cibo, acqua, assistenza medica e istruzione a tutti gli abitanti del pianeta per lo stesso periodo. Se questo è tutto ciò che occorre, non dovrebbe essere impossibile ridurre armamenti e spese difensive del cinque per cento.
Il problema dell’educazione va ben oltre lo scopo di base di imparare a leggere e a scrivere. Dobbiamo escogitare metodi per far emergere il potenziale latente di popoli che non dispongono nemmeno delle più elementari tecniche per la sopravvivenza e indirizzare quel potenziale verso la costruzione di una comunità globale.
I problemi inerenti all’educazione naturalmente sono complessi e per trovare rimedi occorre un’immensa pazienza e perseveranza. Spesso i programmi per l’ampliamento dell’educazione calati dall’alto sono falliti perché mancavano dell’impulso necessario. Per elevare il livello dell’educazione globale bisognerà dare grande sostegno a quelle iniziative che nascono dall’interno, dal basso in alto.
Credo fermamente nel potenziale latente della gente. E per risvegliare le persone al loro stesso potere occorre l’educazione. Le persone hanno bisogno di maestri. Oggi si sente il bisogno di una forma globale di educazione, un corso di studi che comprenda la conoscenza di questioni che al momento sono d’importanza vitale come l’ambiente, lo sviluppo, la pace e i diritti umani.
L’educazione alla pace dovrebbe rivelare la crudeltà della guerra, evidenziare il pericolo degli armamenti nucleari e insistere sull’importanza della riduzione degli armamenti. L’educazione allo sviluppo dovrebbe trattare dell’eliminazione della fame e della povertà e studiare l’istituzione di una struttura assistenziale per i circa cinquecento milioni di persone che attualmente soffrono di malnutrizione e per i due terzi delle nazioni mondiali impoverite. Il tema dell’educazione ambientale dovrebbe essere l’armonia fra umanità e natura. Per esempio, è importante sviluppare precise conoscenze dei danni che le esplosioni nucleari arrecano all’ecosistema. Infine il pilastro dell’educazione ai diritti umani dovrebbe essere di imparare a rispettare la dignità dell’individuo. In queste quattro categorie fondamentali l’educazione deve trascendere i confini nazionali e ricercare valori applicabili a tutta l’umanità.
Educazione ed esclusivismo etnico
L’esclusivismo etnico è un grande ostacolo per la creazione di una comunità globale. All’inizio del terzo millennio ci troviamo ancora faccia a faccia con la pulizia etnica, un abominevole fantasma che risorge dalla tomba cinquant’anni dopo. Gli atti di barbarie compiuti durante la guerra in Kosovo evocano gli incubi dell’olocausto e, quando ci soffermiamo a considerare che tali atrocità hanno radici in rivalità etniche vecchie di centinaia d’anni, siamo costretti a mettere in discussione l’idea stessa di progresso. A volte l’animale umano sembra davvero incurabile e non sono l’unico ad avere questa sensazione.
Nell’ultimo capitolo di Delitto e castigo, Dostoevsky descrive il giovane e sensibile Raskolnikov, confinato in Siberia per aver ucciso una vecchia usuraia. Nei suoi sogni immagina il violento scoppio di una strana malattia contagiosa:
«Era apparso un nuovo tipo di trichine, sostanze microscopiche che abitano nel corpo degli uomini… Gli infetti venivano immediatamente colpiti dal morbo e impazzivano. Mai nessuno si era considerato tanto intelligente e nel giusto al di là di qualsiasi dubbio, quanto gli infetti consideravano se stessi».4
Così la gente, assolutamente certa delle proprie convinzioni comincia a cercare i nemici fuori di sé e a tessere una serie di alleanze poi infrante avviandosi così sulla strada in un’interminabile e reciproca carneficina. Alla fine gli unici a salvarsi saranno «i puri, gli eletti, i predestinati a dare inizio a una nuova razza di uomini e a una nuova vita, a rinnovare e purificare la terra…».5
Questo è l’incubo che tormenta costantemente il sofferente Raskolnikov.
Oggi vediamo gente che, ubriaca di slogan come la “pulizia etnica”, versa impunemente sangue umano. Di sicuro sono stati infettati dalle “trichine” di Dostoevsky. Anch’essi continueranno a uccidersi a vicenda senza accennare a fermarsi finché l’umanità non sarà sterminata (e una “nuova razza” verrà creata!). La loro è una malattia mortale, nel senso più letterale del termine, un ineluttabile divorante male dell’ego.
Ed è preoccupante che l’umanità non sia ancora sufficientemente immune nei confronti di questo male.
La ragione principale per cui le relazioni fra persone e culture diverse degenerano nel tipo di atrocità simboleggiato dalla pulizia etnica risiede in una mentalità chiusa e ristretta. Persone di diversi gruppi etnici, che solo fino a pochi giorni prima erano riuscite a vivere fianco a fianco senza particolari problemi evidenti, improvvisamente si saltano alla gola come se l’odio fosse la loro unica motivazione. È difficile credere che i conflitti e le dispute sanguinose a cui assistiamo oggi siano esplosi unicamente perché sono state rimosse le strutture frenanti dell’ideologia e dell’autoritarismo. Nemmeno le difficoltà economiche possono spiegarli, anche se forse possono aver innescato la miccia, perché se fossero state l’unica causa non sarebbe stato necessario giungere all’omicidio. Possiamo soltanto concludere che la vera causa è più profonda, risiede in una morbosa chiusura mentale le cui radici affondano nella storia della civiltà.
Ne parlerò più dettagliatamente in seguito, ma ritengo che l’essenza del bene sia l’aspirazione all’unità mentre il male va verso la divisione e la separazione. La funzione del male è sempre quella di causare divisioni, provocare lacerazioni nel cuore umano, rescindere i legami tra familiari, colleghi, amici e conoscenti, distruggere il senso di unione dell’umanità con la natura e l’universo. Dove regna la divisione gli esseri umani si isolano per divenire vittime dell’infelicità e della disperazione.
Una persona dal cuore chiuso vive incapsulata nel guscio di egoismo e autocompiacimento che si è costruita. Questa azione triste e insensata di separare l’io e l’altro è il marchio di fabbrica del male così come l’ho definito qui e questa profonda tendenza, che accompagna tutta la storia umana, nella nostra epoca si è manifestata in maniera singolare, come una sorta di tratto fatidico della nostra civiltà.
Senza dubbio nazionalismo, identità etnica e altri slogan dei quali attualmente si fa grande uso e abuso sono oggetti ideali per il fanatismo e la facile credulità. Questo perché concetti come “razza” ed “etnia” sono in gran parte fittizi e le identificazioni etniche sono state specificamente costruite in maniera artificiale con un mezzo o con l’altro. Può sembrare un’affermazione estremista ma ritengo che le circostanze richiedano di parlar chiaro: in un mondo in cui l’identità nazionale ed etnica è diventata fonte di brutale violenza occorre una revisione radicale della definizione stessa di questi concetti.
I sentimenti nazionalisti sono stati coltivati intenzionalmente come parte integrante del processo di costruzione dei moderni stati nazionali; sono mezzi per forgiare l’unità della cittadinanza e alimentare i legami spirituali. Nella maggior parte dei casi la loro autenticità è fortemente sospetta. Paesi come l’Inghilterra e la Francia, considerati il modello degli stati nazionali moderni, sono più diversi dal punto di vista etnico e razziale di quanto non lo sia – per esempio – il Giappone. Non molti secoli fa erano ancora federazioni di piccoli gruppi tribali con ben pochi legami fra loro.
Eppure anche le nazioni più rigide possono invertire i propri impulsi esclusivisti.
Per esempio il Sud Africa è un esempio di successo di una comunità umanistica. Ho potuto incontrare due volte l’ex-presidente del Sud Africa Nelson Mandela e una volta l’allora vice-presidente Frederik de Klerk. Nei miei dialoghi con entrambi ebbi la forte impressione che dietro il tentativo di abolire l’apartheid ci fosse il desiderio di superare odio e sfiducia e di impegnarsi in un dialogo autentico. Un energico dialogo in cui ogni parte esercita il massimo sforzo per capire la posizione dell’altra è il fattore principale per non cadere nella violenza e nel caos e far risplendere invece la bellezza della tolleranza umana.
Nel giugno 1992 de Klerk osservò a proposito dell’apartheid: «Noi desideriamo creare una società in cui tutti siano vincitori, al posto di una divisa fra vincitori e vinti che si contrappongono e si attaccano a vicenda per perseguire i propri interessi egoistici».6
La decisione di non creare perdenti è fondamentale per risolvere la diffusa piaga dei conflitti civili che affligge il mondo attuale. Finché vi sarà anche solo qualche perdente, qualcuno che ha assaggiato l’amaro gusto della sconfitta, non si potrà mai sperare in una società veramente stabile in cui siano stati completamente eliminati i semi di un futuro conflitto.
Credo che l’educazione sia l’unico strumento che abbiamo per guarire le ferite del passato e costruire società rivolte al futuro in cui ognuno sia vincitore. A prima vista l’educazione può apparire una maniera indiretta di affrontare questi problemi, ma io sono convinto che in realtà sia il mezzo più efficace per inculcare lo spirito della tolleranza. Solo imparando possiamo aprire le finestre spirituali dell’umanità, liberando la gente dai confini della propria visione del mondo etnica o di gruppo. L’identità etnica è profondamente radicata nell’inconscio umano ed è cruciale che sia mitigata da incessanti sforzi educativi che incoraggino un senso dell’umanità più vasto e universale.
Gli sforzi del Sud Africa per creare una “nazione arcobaleno” indubbiamente daranno speranza anche ad altre nazioni africane e per estensione a tutti coloro che soffrono a causa delle divisioni etniche. L’incessante battaglia del Sud Africa a favore della tolleranza è espressione di quella filosofia di coesistenza che i nostri tempi richiedono. La comunità internazionale non dovrebbe lesinare il proprio sostegno a quest’impresa senza precedenti.
Via via che osservo gli sviluppi in Sud Africa, mi viene in mente che la vera fonte della felicità umana sta nella riconciliazione e nell’armonizzazione di gruppi diversi, non nella loro divisione o nel conflitto. È naturale che le persone tendano a unirsi fortemente in gruppi per alleviare il disagio che deriva da un vuoto di identità, tuttavia sospetto che la coscienza nazionale sia in larga misura una finzione creata in maniera semi intenzionale nel corso della storia moderna.
Le forme esteriori e la rivoluzione interiore
Accanto a una delicata sensibilità che gli permetteva di cogliere l’eterno, il poeta bengali Rabindranath Tagore aveva una profonda comprensione della natura umana. Nella Religione dell’uomo egli riflette sulla natura dei conflitti etnici, quella che potremmo chiamare l’aporia della storia umana: «In ogni epoca i nostri più grandi profeti hanno conseguito un’autentica libertà dell’anima prendendo coscienza dell’affinità spirituale universale dell’uomo. E tuttavia le razze umane, a causa delle condizioni geografiche esterne, hanno sviluppato nel loro isolamento individuale una mentalità disgustosamente egoista».7
Tagore mette all’indice con forza la brutalità e la disumanità che può esplodere in qualsiasi momento, date le condizioni appropriate. E ci lascia il seguente monito: «La vastità del problema razziale che abbiamo oggi di fronte o ci obbligherà a un allenamento per mantenere una buona salute morale senza accontentarci della mera efficienza esterna, oppure genererà complicazioni tali da impedirci ogni movimento e condurci alla morte».8
Sono passati molti decenni da quel grido spirituale del grande poeta: più i fenomeni storici regressivi divengono manifesti, più illuminanti ci appaiono le sue parole. Gruppi contrastanti possono anche accordarsi per quanto riguarda l’“efficienza esterna” nella sfera politica o economica. E sicuramente comprendersi in questi campi è importante. Ma se non si affronta il problema della “buona salute morale” posto da Tagore, inevitabilmente alla minima provocazione le ostilità riesploderanno.
Nel dicembre 1970 scrissi un lungo poema dedicato ai giovani. Ancora non si erano spenti gli echi delle violente manifestazioni studentesche scoppiate in Giappone e in altri paesi nel 1968 e nel 1969 e solo un mese prima il suicidio secondo il rituale tradizionale del notoromanziere Yukio Mishima aveva sconvolto il paese. Insomma era un periodo caratterizzato da intensi turbamenti e diffusi tumulti. La mia poesia era un accorato appello ai giovani in cui esprimevo la mia visione del secolo XX e del XXI.
Ciò che le persone sognano
di portare con sé nel XXI secolo
non è una riorganizzazione
delle forme esteriori.
Esse desiderano
una vera rivoluzione
da realizzare dentro di sé,
a piccoli passi e
in un’atmosfera di pace,
basata sulla filosofia e
sulle convinzioni
di ogni individuo.
Per questo ci vogliono
giudizi lungimiranti
e un sistema profondo di princìpi.
La definirei una rivoluzione totale.
È ciò che noi chiamiamo
kosen-rufu.9
Il XX secolo è stato caratterizzato dalla ricerca ossessiva e incessante di soluzioni attraverso riforme sociali, ovvero in un rimodellamento delle “forme esteriori”. Ma il compito primario che nel XXI secolo non possiamo più evitare di intraprendere è la rivoluzione dentro di noi, la «vera rivoluzione da realizzare dentro di sé a piccoli passi e in un’atmosfera di pace». In questo poema ho espresso la mia ferma convinzione che il punto di partenza per qualsiasi cosa si faccia d’ora in avanti deve essere anzitutto reindirizzare il nostro obiettivo primario.
Mi appello ai giovani affinché guidino diversamente le loro energie, e che invece di cominciare a cambiare l’esterno, credendo che di conseguenza avverrà un cambiamento anche all’interno, operino una coraggiosa inversione di rotta – di cui si sente sempre di più l’esigenza negli ultimi trent’anni – che faccia del cambiamento interiore la chiave per trasformare il mondo circostante.
Nel 1970 i movimenti di estrema sinistra di cui faceva parte il movimento studentesco cominciavano a dare segni di sfaldamento e declino, dopo la delusione causata dall’invasione della Cecoslovacchia nel 1968 da parte delle truppe del Patto di Varsavia. Nondimeno l’esortazione a riformare il mondo con la rivoluzione sociale resisteva tenacemente entro le mura accademiche. La ben nota tesi marxista, ora un po’ in declino, secondo la quale «non è la coscienza che determina l’esistenza, bensì è l’esistenza che determina la coscienza» a quell’epoca faceva furore fra gli opinion leader di sinistra.
Nel tumulto di allora non potevo fare a meno di percepire nel momentaneo fervore anarchico un vago e strisciante sentore di nichilismo e decadenza. Sentivo che dovevo appellarmi ai giovani perché scegliessero una nuova coraggiosa direzione per i propri pensieri e azioni.
I decenni successivi videro immense tragedie. Il secolo che aveva riconosciuto unicamente la validità della rivoluzione delle “forme esteriori” è stato essenzialmente un secolo di guerre e di rivolte il cui crudele tributo è davanti agli occhi di tutti. È particolarmente triste osservare i postumi del crollo dell’Unione Sovietica e dei suoi paesi satellite in parte perché, a differenza del puro vandalismo nazista, il socialismo cercava di legittimare il sovvertimento delle “forme esteriori” con complicati ragionamenti teorici e in parte perché aveva attratto molti giovani coscienziosi e idealisti indignati dalle contraddizioni interne al capitalismo.
Le parole di Chingiz Aitmatov, lo scrittore kyrgyzo con cui ho dialogato in molte occasioni, sono indimenticabili:
«Un consiglio paterno: rivoluzione significa sommossa. Giovani non fidatevi delle rivoluzioni sociali! Per le nazioni, il popolo e la società non sono che follia di massa, violenza di massa e catastrofe totale. Noi russi l’abbiamo compreso a fondo. Cercate invece le riforme democratiche che portino a una evoluzione priva di spargimenti di sangue e alla graduale ricostruzione della società. L’evoluzione richiede più tempo, pazienza e compromessi della rivoluzione. Richiede l’edificazione e la promozione della felicità, non la sua istituzione forzata. Prego Dio che le giovani generazioni imparino dai nostri errori!».10
Ma anche le società liberali non possono riposare sugli allori liquidando le tragedie del socialismo come «fuochi sull’altra sponda». Il crollo del socialismo potrebbe essere interpretato come una dimostrazione della relativa superiorità del liberalismo e del capitalismo e tuttavia le condizioni in cui versano le cosiddette società libere non permettono certo di cantare vittoria. Il liberalismo forse non è giunto agli estremi ideologici del socialismo, ma è stato egualmente ossessionato dalla rivoluzione delle forme esteriori.
In realtà, come ci mostra chiaramente la situazione delle democrazie liberali negli ultimi anni, non otterremo mai il nostro scopo solo con la ricerca della sicurezza secolare e delle riforme esterne.
Finiremo col trascurare la spiritualità e la coltivazione del proprio carattere e, quando ciò accadrà, il movimento per difendere la dignità umana degenererà in un movimento per opprimerla e danneggiarla.
Qual è il ruolo di una religione viva nella società attuale? Quali sono le condizioni necessarie per una religione mondiale? Ogni religione è chiamata a riflettere attentamente su queste domande e a formulare risposte.
Possiamo dire che il ruolo intrinseco della religione sia unire i cuori umani che sono divisi, attraverso la spiritualità universale. Era questo l’obiettivo che aveva in mente Toynbee quando scriveva: «In un’epoca in cui sono venute improvvisamente in stretto contatto persone con tradizioni, credenze e ideali radicalmente diversi, la sopravvivenza dell’umanità richiede la disponibilità a vivere insieme e ad accettare che esista più di una via che conduce alla verità e alla salvezza».11
Questa disponibilità a vivere e a lasciar vivere si rafforza maggiormente quando adottiamo la posizione attiva di cui parlava Makiguchi, secondo la quale facendo del bene agli altri lo facciamo a noi stessi. Questo è il punto di partenza per la formazione del globalismo nel XXI secolo. Ed è anche la seria e difficile sfida che nessuna religione mondiale può ignorare se vuole essere degna del proprio nome e adempiere a quello che ritengo sia il vero ruolo della fede: una fonte di profonda energia spirituale in grado di alimentare e sostenere un globalismo che rechi benefici reciproci a tutti.
Toynbee sottolineava l’importanza di accettare che esista più di una via per la verità e la salvezza. È stato ormai ampiamente assodato che l’ostinato attaccamento ai dogmi religiosi non fa che esacerbare lo scontro e la rivalità fra i popoli, perpetuando una lunga e sanguinosa storia di dissidi e persecuzioni religiose.
Ovviamente Toynbee non intendeva dire che le persone non dovrebbero esprimere le proprie opinioni sul mondo, l’universo e la fede religiosa. Siamo liberi di affermare le nostre idee ma solo nella misura in cui ciò sia compatibile con lo spirito di vivere e lasciar vivere, lo spirito di tolleranza e nonviolenza che noi della SGI consideriamo il cuore dell’umanesimo. Anche se Toynbee ha contemplato la possibilità che un giorno l’umanità sia unita dalla stessa fede, ha comunque dato severe indicazioni per la propagazione religiosa, dichiarando che l’accettazione di una nuova fede può essere solo il risultato della libera scelta di innumerevoli individui».12
Quest’idea coincide con quella di Makiguchi di collaborazione “spontanea e senza riserve”.
È lo spirito religioso che sostiene e ispira le persone a ricercare il bene e il valore nella propria vita; inoltre il sentimento religioso offre loro un mezzo per accedere alle risorse interiori che consentono di trascendere se stessi. Era esattamente quello che Tagore stava cercando ed è anche una delle condizioni che una religione deve soddisfare se intende contribuire a un futuro più pieno di speranza.
«La vita è una lotta» scriveva Johan Huizinger, una lotta incessante fra bene e male o, in termini buddisti, fra il Budda e il demone. Libertà e indulgenza, democrazia e demagogia, pace e sottomissione, diritti umani e fanatismo sono termini opposti e a un tempo prossimi l’uno all’altro come le due facce di una moneta. Abbassare anche di poco la guardia in questa lotta equivale a rischiare di cadere sul versante opposto.
Per questo, adesso come trent’anni fa, continuo ad appellarmi ai giovani esortandoli a praticare l’autodisciplina e a coltivare il proprio io interiore. Il signor Toda soleva dirci: «Da giovani dovreste sperimentare ogni tipo di difficoltà, costi quel che costi» e, se ripenso alla mia giovinezza, vedo che quello è stato anche il mio motto. È la rivoluzione interna che getterà un ponte di speranza nel XXI secolo per superare tutte le numerose tragedie del XX causate da un univoco e ostinato attaccamento alle riforme esterne.
Per raggiungere l’unità globale ci sarà sempre più bisogno di scambi educativi e culturali che trascendano religione, razza e nazionalità. Poiché la competizione, nel suo senso costruttivo, sprona al progresso, la maniera migliore per realizzare l’unità mondiale e la pace è che le nazioni competano fra loro in attività veramente utili al miglioramento e alla formazione del carattere.
Invece di competere per ottenere la superiorità militare potrebbero per esempio fare a gara nel formare validi cittadini globali.
Il nostro scopo dovrebbe essere instillare un’etica di cittadinanza mondiale. Come nel caso di Socrate, definendoci cittadini del mondo possiamo ridare vita, nella comunità globale, alle virtù ormai un po’ sbiadite del coraggio, dell’autocontrollo, della devozione, della giustizia, dell’amore e dell’amicizia e farle palpitare nuovamente nel cuore di tutte le persone.
NOTE
1) Benjamin R. Barber, Jihad vs. McWorld, New York, Ballantine Books, 1996, pp. 219-20.
2) ibid., p. 277.
3) Aleksandr Solzhenitsyn, Rebuilding Russia: Reflections and Tentative Proposals, trad. Alexis Klimoff, New York, Farra, Straus and Giroux, 1991, p. 49.
4) Fyodor Dostoevsky, Crime and Punishment, New York, Penguin Books USA, 1968, p. 524.
5) ibid., p. 525.
6) Frederik de Klerk and SGI President Meet, Seikyo Shimbun, % giugno 1992, p. 2.
7) Rabindranath Tagore, The Religion of Man, New York, The MacMillan Company, 1931, p. 154.
8) ibid., p. 156.
9) Daisaku Ikeda, Song of Youth, Songs from My Heart, New York, Weatherhill, 1997, p. 21.
10) Daisaku Ikeda and Chingiz Aitmatov, Oinaru tamashii no uta (Poemi del grande spirito), vol. 1, trad. Richard L. Gage, Tokyo Ushio Shuppansha, 1995, p. 81.
11) Arnold J.Toynbee, Hiseiyo Bunmei no Shorai (Il futuro delle civiltà non-occidentali), Asahi Shimbun, 1957.
12) ibid.
Per il bene della pace. Sette sentieri verso l'armonia globale. Una prospettiva buddista - di Daisaku Ikeda
Capitolo 5.1° - La via della cultura - AUDIO generato con un sintetizzatore vocale
 Nell’ambito del tentativo a livello globale di trasformare la tragica eredità del XX secolo, le Nazioni Unite hanno intitolato il 2000 “Anno internazionale per la cultura di pace” e la prima decade del nuovo secolo (2001-10) “Decennio internazionale per una cultura di pace e nonviolenza per i bambini del mondo”. Si tratta di un’occasione unica per fare appello alla volontà della comunità internazionale con iniziative che trasformino la vecchia cultura della guerra in una nuova cultura di pace.
Nell’ambito del tentativo a livello globale di trasformare la tragica eredità del XX secolo, le Nazioni Unite hanno intitolato il 2000 “Anno internazionale per la cultura di pace” e la prima decade del nuovo secolo (2001-10) “Decennio internazionale per una cultura di pace e nonviolenza per i bambini del mondo”. Si tratta di un’occasione unica per fare appello alla volontà della comunità internazionale con iniziative che trasformino la vecchia cultura della guerra in una nuova cultura di pace.Cos’è una cultura di pace? E come si fa a crearla? Proporrei di discutere anzitutto le differenze fra cultura di guerra e cultura di pace e tentare di tracciare un cammino che conduca dall’una all’altra.
Nell’annosa dicotomia fra l’arte della spada e quella della penna, quest’ultima viene naturalmente associata alla cultura e tipicamente evoca un’immagine di pace. Ma è davvero così semplice? Quando consideriamo come certi valori culturali siano stati diffusi e quale sia stato l’incontro fra culture differenti ci rendiamo conto che non si è trattato sempre di un processo pacifico. Sosteneva Arnold Toynbee che «accogliere una cultura straniera è un compito doloroso quanto rischioso».1
Come la storia insegna questi incontri sono spesso accompagnati da lotte per il potere e, quando una cultura cerca di soggiogarne un’altra, scatenano forze generatrici di violenza e spargimenti di sangue. In un certo senso, la lotta incessante che vediamo nel mondo intorno a noi è una prova che l’umanità non ha ancora superato le modalità distruttive dell’incontro interculturale.
Non cercherò qui di affrontare la difficile questione se una simile violenza sia intrinseca alla natura della cultura oppure sia il risultato di una sua deliberata distorsione e manipolazione. Basti dire che la cultura manifesta due aspetti contrastanti. Uno in armonia con il significato originale della parola, e cioè “coltivare”, e riguarda il nutrimento della vita interiore degli esseri umani e la loro elevazione spirituale. L’altro è un’imposizione aggressiva e invadente dei costumi del proprio popolo su un altro che, quando viene esercitata, provoca risentimento e getta i semi del conflitto. In questo caso la cultura non è al servizio della pace ma della guerra.
Un esempio classico di questo aspetto aggressivo e invadente è l’imperialismo culturale che ha affiancato la politica coloniale europea con l’intento di ingentilirla e giustificarla. Quando gli europei – con l’uso della forza – invasero e colonizzarono le nazioni dell’Asia nel XIX secolo, queste vivevano in una condizione relativamente pacifica e nel rispetto delle altre culture. L’Asia aveva dato all’Europa ricchezza, arte e cultura mentre l’Europa, sin dall’epoca dei grandi navigatori, aveva usato la forza per sfruttare l’Asia. Oggi che i limiti delle risorse naturali mondiali sono evidenti e la coesistenza pacifica è diventata indispensabile, gli intellettuali occidentali sono sempre più consapevoli che questa coesistenza pacifica dovrebbe sostituire la logica della forza e della dominazione.
Imperialismo culturale
L’espressione imperialismo culturale emerse negli anni Sessanta, sullo sfondo del processo globale di decolonizzazione, attraverso i movimenti di etno-cultura e controcultura occidentali che mettevano in discussione la legittimità delle tradizioni e dei valori che avevano ereditato. Ma il fenomeno descritto da questo termine risale agli albori dell’esplorazione e dell’espansione europea e accompagna il moderno colonialismo per tutti i cinquecento anni della sua storia. Si tratta dell’ideologia che giustifica la sottomissione e lo sfruttamento di altri popoli definendo unilateralmente questi e la loro cultura come primitivi e barbarici.
È questo un esempio del potenziale di violenza di cui la cultura è dotata, sia nelle intenzioni che nell’applicazione concreta. La cultura svolge qui la funzione di apripista, di base ideologica per la guerra e la violenza della dominazione coloniale; serve a coprire e a nascondere forme più semplici e grezze di egoismo collettivo. Ora, in un’epoca in cui quasi tutte le colonie si sono conquistate l’indipendenza, potrebbe sembrare che questo velo sia stato finalmente squarciato e che la cultura non venga più utilizzata per simili scopi politici. Ma le fratture e i conflitti che affliggono varie aree geografiche suggeriscono che purtroppo le cose non stanno affatto così.
Qualche tempo fa ho intrapreso un dialogo su José Martí, il grande saggista, poeta e leader della lotta per l’indipendenza cubana, con Cintio Vitier, presidente del Centro per gli studi su José Martí dell’Avana. Queste discussioni mi hanno fatto tornare in mente quanto la forte sfiducia nei confronti degli Stati Uniti, che Martì aveva constatato già più di un secolo fa, sia ancora ben radicata nella mente del popolo cubano. E credo che non si possano liquidare queste paure affermando che sono ingiustificate.
Il critico di origine palestinese Edward Said scrive, nel suo libro Culture and Imperialism considerato da molti come un’opera fondamentale nell’analisi del periodo postcoloniale: «Il significato del passato imperialista non è totalmente contenuto in esso, ma è penetrato nella realtà di centinaia di milioni di persone ove la sua esistenza – in quanto memoria condivisa in cui s’intersecano, con un alto potenziale conflittuale, cultura, ideologia e politica – esercita ancora una tremenda forza»2.
Seguendo l’argomentazione di Said, attentamente sviluppata e ricca di esempi, si scopre quanto profondamente radicata sia l’ideologia dell’imperialismo culturale nella mente e nel cuore «delle persone per bene», cioè delle classi colte delle potenze imperialiste. Il nucleo dell’argomentazione di Said si basa sull’analisi di opere letterarie come Cuore di tenebra di Joseph Conrad o Mansfield Park di Jane Austen o Kim di Rudyard Kipling. Allo stesso tempo egli prende in considerazione l’atteggiamento e il modo di pensare di quelle grandi figure intellettuali, fra cui de Tocqueville, J.S. Mill, Hegel e Marx, che hanno plasmato il pensiero moderno, lasciando la loro impronta anche sulla vita intellettuale del Giappone in via di modernizzazione, a sua volta un tardo colonizzatore che inflisse grandi sofferenze ai popoli dell’Asia. Egli ci rivela come questi grandi pensatori, più o meno consciamente e con un’impressionante libertà da qualsiasi senso di colpa, appoggiassero gli obiettivi dell’imperialismo culturale. Per esempio il filosofo francese Ernest Renan da una parte era capace di scrivere un’opera come La vita di Gesù e dall’altra proponeva teorie razziali che rivaleggiavano con quelle dei nazisti.
Come esempio finale di questo atteggiamento abbiamo un’affermazione di Albert Schweitzer, famoso per l’ospedale che gestì per molti decenni nell’Africa equatoriale: «Il negro è un bambino e con i bambini non si può far niente se non si usa l’autorità. Perciò dobbiamo organizzare le circostanze della vita quotidiana in modo che in esse trovi espressione la mia naturale autorità. Per questo, riguardo ai negri ho coniato la frase: “Io sono tuo fratello, è vero, però tuo fratello maggiore.”»3.
Non è affatto sorprendente che la reputazione di Schweitzer sia calata rapidamente con l’ascesa dei movimenti indipendentisti fra i popoli soggiogati dal colonialismo. E il fatto che queste parole fossero scritte con apparente benevolenza nei confronti dei loro referenti non fa che accrescere la nostra repulsione di fronte alla sensibilità elitaria e discriminatoria che rivelano.
Relativismo culturale e globalizzazione
Il relativismo culturale è un’eredità intellettuale importante dell’ultima metà del XX secolo. Ha origine dall’opera pionieristica degli antropologi culturali che cercarono di equilibrare e correggere quelle assunzioni arroganti dell’imperialismo che si erano insinuate nella visione del mondo della cultura occidentale. Si basa sull’idea che determinate pratiche vadano comprese e valutate nell’ambito del contesto culturale complessivo a cui appartengono e nega la possibilità di giudicare una cultura facendo uso dei valori di un’altra o di ordinare le culture secondo un qualsivoglia schema gerarchico.
L’onesto tentativo di relativizzare la propria cultura e di attribuire valore a quei costumi o tradizioni che erano stati disprezzati come selvaggi o primitivi è degno di rispetto e questi sforzi hanno fatto molto per mitigare gli effetti nocivi dell’imperialismo culturale.
Mi chiedo però se tale filosofia sia una risposta adeguata alle sfide della globalizzazione – cioè l’unificazione economica e tecnologica del mondo. In altre parole, temo che un atteggiamento di mero riconoscimento passivo o di accettazione a denti stretti delle altre culture non basti ad affrontare il problema degli aspetti distruttivi della cultura che perpetuano una logica di esclusione e di conflitto. Se non verranno trasformati, questi aspetti renderanno la cultura, come afferma Said, «un campo di battaglia sul quale gli ideali si rivelano alla luce del giorno e si combattono l’un l’altro» invece di «un placido regno di apollinea raffinatezza»4.
Nelle nostre discussioni Johan Galtung, pioniere degli studi per la pace, si lamentava della fragilità del relativismo culturale per la sua «tendenza ad assumere la forma di una tolleranza passiva e non di uno sforzo attivo di imparare da altre culture»5.
Dietro alle dispute sull’universalità dei diritti umani fra i paesi occidentali (in particolare gli Stati Uniti) e i paesi in via di sviluppo, c’è il tentativo di relativizzare la politica culturale occidentale, dalla quale deriva la moderna tradizione dei diritti umani. Le critiche occidentali alle usanze o ai sistemi politici dei paesi in via di sviluppo si scontrano inevitabilmente con le controaccuse di interferenza negli affari interni di una nazione sovrana. E i tentativi occidentali di affermare l’universalità dei diritti umani pur continuando a ignorare le differenze di politica culturale e la storia della dominazione coloniale con le conseguenti disparità di sviluppo economico, vengono liquidati nella migliore delle ipotesi come ipocriti e nella peggiore come una continuazione nel presente dell’arroganza delle “grandi potenze”.
Per appianare differenze e dispute di questa complessità occorre una base ben più solida dell’accettazione passiva o della tolleranza. Questi atteggiamenti non sono in grado di fornire le basi per una cultura di pace o per una nuova civiltà globale che possa arricchire durevolmente la vita delle persone nel terzo millennio.
Il relativismo culturale passivo non offre un’alternativa valida alla prepotenza dell’imperialismo culturale. Un requisito necessario per una cultura di pace è che deve fornire una base sulla quale diverse tradizioni culturali possano interagire creativamente apprendendo e prendendo l’una dall’altra per realizzare il sogno di una civiltà globale autenticamente omnicomprensiva. Senza questo scopo più alto rischiamo di non avere strumenti sufficienti per affrontare le sfide della globalizzazione o, ancor peggio, di cadere in una paralisi cinica.
La promessa dell’internazionalismo culturale
A questo riguardo esaminiamo adesso quell’abbondante miniera di possibilità che è la tradizione dell’internazionalismo culturale e cerchiamo di ampliare e approfondire questo concetto.
L’internazionalismo culturale, emerso nel XIX secolo, è stato studiato da Akira Iriye, professore di storia americana all’Università di Harvard. Questo movimento considerava la cultura come un veicolo per costruire relazioni di cooperazione al di là dei confini nazionali e sdrammatizzare gli scontri sotterranei che spingevano il mondo verso una corsa suicida agli armamenti. Partendo da tentativi come quello di promuovere lo scambio d’informazioni fra scienziati e medici o di standardizzare i sistemi di misura, i suoi sostenitori cercavano di gettare le basi per la pace attraverso scambi educativi e culturali. Queste reti di scambio sono sopravvissute a due conflitti mondiali e di fatto hanno svolto un ruolo determinante nelle iniziative del dopoguerra che portarono alla Carta dell’UNESCO e alla Dichiarazione universale dei diritti umani, due documenti fondamentali che esprimono la coscienza e le aspirazioni comuni dell’umanità6.
Negli ultimi anni, le attività globali delle ONG e di quella che viene chiamata società civile globale si sono mosse sullo stesso filone. Credo che siano i primi segni di una tendenza emergente verso quello che potremmo chiamare interpopulismo culturale, un movimento per l’interazione culturale dove i protagonisti siano i cittadini comuni. Sono convinto che questo approccio svolgerà un ruolo chiave nell’opera di costruzione di una nuova cultura di pace.
Ryosuke Ohashi, professore di filosofia al Kyoto Institute of Technology, ha messo in evidenza che ultimamente, nella cerchia degli intellettuali europei, si tende a sostituire la parola “internazionale” con “interculturale”. Ohashi descrive il nostro mondo attuale come l’intersezione «dell’asse verticale della molteplicità delle culture locali con l’asse orizzontale della tecnologia che ricerca l’universalità e la standardizzazione».
C’è un crescente anche se tacito accordo sul fatto che un simile mondo si possa capire meglio concentrandosi sulle tematiche più profonde dell’identità culturale piuttosto che rimanendo al livello più superficiale delle definizioni e degli interessi politici.
In effetti, se ci si occupa troppo della dimensione nazionale, è facile perdere di vista il fatto che le identità nazionali spesso sono costrutti deliberatamente creati per fini politici.
Il maggior pericolo naturalmente sta nel cadere nella trappola di considerarle entità o essenze immutabili con uno status ontologico assoluto.
Allo stesso tempo dobbiamo riconoscere che la struttura statale, il livello nazionale, almeno a breve termine non è destinata a sparire e gli stati continueranno a mantenere quantomeno una necessità funzionale. Dobbiamo però affrontare anche la realtà di un approfondimento della crisi di identità che ovunque affligge le persone e il cui motore è da ricercarsi in quelli che Toynbee definiva «i movimenti più lenti e profondi della storia»7 sui quali non si può influire con mezzi puramente politici. È a questo livello più profondo che s’impone la necessità di un cambiamento di paradigma nella direzione di una prospettiva interculturale.
Non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che, per quanto possa progredire la tecnologia della comunicazione e il processo di globalizzazione, le persone contano ancora qualcosa. L’individuo – il carattere di ciascun individuo – rimane sempre l’artefice e il protagonista della cultura.
Così la possibilità di successo dei movimenti popolari a cui assistiamo oggi nel generare una cultura di pace dipende da numerosi fattori. Anzitutto dobbiamo riuscire a trascendere l’eccessivo attaccamento alle differenze, profondamente radicato nella psicologia degli individui, e condurre un dialogo basato sulla nostra comune umanità. Credo che solo affrontando questa sfida estremamente difficile potremo trasformare noi stessi e la società.
Guardando indietro vediamo che il XX secolo è stata un’epoca in cui ideologie differenti e visioni discordanti della giustizia hanno lottato violentemente per la supremazia. In particolare abbiamo visto ideologie ossessionate dalle distinzioni e dalle differenze esteriori quali razza, classe, nazionalità, cultura, usi e costumi. Queste ideologie asserivano che tali fattori erano determinanti per la felicità umana e che l’annullamento delle differenze fosse il cammino più sicuro per l’eliminazione dei mali e la risoluzione delle contraddizioni sociali. La storia del XX secolo è scritta con il sangue delle vittime di queste ideesbagliate.
Riforma politica e sociale vs. riforma individuale
Nel giugno 1945, subito dopo la sconfitta della Germania nazista da parte degli Alleati, lo psicologo svizzero C.G. Jung rivolse queste parole «a quella parte del popolo tedesco che era rimasta sana»:
«Dove il peccato è grande, la grazia “abbonda molto di più”. Un’esperienza così profonda porta a una trasformazione interiore e questa è infinitamente più importante delle riforme politiche e sociali che non hanno nessun valore in mano a persone che non sono unite fra loro. Questa è una verità che ci dimentichiamo sempre…»8.
A quell’epoca il commento di Jung suscitò scarsa attenzione. Ma dal punto di vista attuale è impossibile non essere colpiti dalla profondità e dalla precisione storica con cui quell’uomo saggio dissezionò la patologia della nostra epoca.
Può sembrare eccessivo da parte di Jung liquidare come “prive di valore” le riforme politiche e sociali. Ma basterebbe ricordare l’incubo infernale provocato dai potenti che hanno intrapreso riforme politiche e sociali senza alcuna consapevolezza né della necessità di riformare se stessi né dell’umanità delle proprie vittime. Viene in mente Stalin. Per contro, quando ci sono leader che hanno il coraggio di confrontarsi e guardarsi dentro – per esempio Zhou En-lai nel contesto cinese o José Martí a Cuba – anche l’orrore dello spargimento di sangue e la violenza della rivoluzione possono essere in qualche misura mitigati e il processo delle riforme sociali può ottenere il sostegno a lungo termine del popolo.
Gli aspetti positivi della Rivoluzione cinese, per esempio, possono essere quasi tutti ricondotti alle straordinarie qualità di Zhou En-lai. Allo steso modo, come accennavo poc’anzi, discutendo con Cintio Vitier ho potuto apprezzare maggiormente il ruolo svolto dall’eredità di Jose Martí come fonte d’ispirazione spirituale nella rivoluzione cubana.
Riconsiderando il XX secolo è facile concentrarsi esclusivamente sul suo lascito negativo. Ma dobbiamo riconoscergli anche alcuni grandi risultati verso il superamento dei mali della società. Fra questi emerge in particolare il movimento dei diritti civili negli Stati Uniti che ha portato a riforme di grande portata come la storica legge per i diritti civili del 1964 e il coraggioso esperimento di assistenza e tutela alle vittime dei pregiudizi razziali che ne seguì.
Per avere la massima efficacia, le riforme strutturali e legislative devono essere sostenute da una corrispondente rivoluzione della coscienza, dallo sviluppo di quel tipo di umanità universale che trascende interiormente le differenze. Solo quando negli individui che compongono la società nel suo complesso si radicherà la rinnovata consapevolezza della nostra comune umanità si potrà realizzare il sogno della vera uguaglianza. In altre parole dev’esserci una sinergia creativa fra le riforme interne, spirituali e introspettive, che hanno luogo negli individui, e le riforme esterne, legali e istituzionali, che occorrono nella società. Questa è l’unica lezione che possiamo ricavare da questa drammatica epoca di trasformazione e dalla mancanza di progresso in qualche modo frustrante che gli ha fatto seguito.
Umanità universale
Forse non c’è miglior modo per spiegare il concetto di “umanità universale” dell’esempio di Martin Luther King Jr. che, un anno prima dell’adozione della legislazione per i diritti civili del 1964, disse: «Ho un sogno, che i miei quattro figli un giorno possano vivere in una nazione in cui non saranno giudicati per il colore della pelle ma per i contenuti della loro personalità»9.
Queste toccanti parole esprimono una profonda fede nel potere del carattere. In questo senso, sono in armonia con gli insegnamenti di Shakyamuni che asseriva che non si è nobili per nascita ma per le proprie azioni. Josè Martí, durante la lotta per l’indipendenza di Cuba, dichiarò che la sua vera patria era tutta l’umanità. E affermò anche che non può esistere l’odio fra le razze perché “le razze non esistono”, sono un concetto costruito artificialmente.
Credo fermamente che la chiave per risolvere tutte le forme di conflitto fra i vari gruppi etnici risieda nello scoprire e rivelare quel tipo di umanità universale così prepotentemente incarnata da King, la coscienza d’America, e da Josè Martì, la coscienza di Cuba. Temo che qualsiasi tentativo di risolvere simili questioni senza percorrere questo difficile cammino non farebbe che posporre il problema.
“Bene” e “male”
Quando in un capitolo precedente citavo la storia in cui il Budda Shakyamuni percepiva un’invisibile freccia che trafiggeva il cuore delle persone, l’ho interpretata come la “freccia” dell’eccessivo attaccamento alle differenze e ho affermato che per creare la pace è fondamentale superarlo. Stavo pensando alle specifiche difficoltà di risolvere le dispute locali ed etniche. Per ritornare a Jung, egli scrisse in The Undiscovered Self: «Se si prendesse coscienza a livello mondiale che tutte le divisioni e gli antagonismi sono dovuti alla separazione netta fra gli opposti nella psiche, allora sapremmo davvero dove attaccare»10. Jung sottolinea il fatto che non dovremmo concentrarci unicamente su ciò che è esterno a noi. Dovremmo resistere alla tentazione di assegnare il bene esclusivamente a una parte e il male all’altra. Di fatto dovremmo riesaminare il significato stesso di bene e male.
Le manifestazioni esterne del bene e del male sono relative e mutevoli. Appaiono assolute e immutabili solo quando il cuore umano è prigioniero del sortilegio del linguaggio e dei concetti astratti. Nella misura in cui riusciamo a liberarci da questo sortilegio, possiamo cominciare a vedere che il bene contiene in sé il male e viceversa. E per questo, anche quello che percepiamo come male può essere trasformato in bene dal modo in cui rispondiamo a esso11.
Secondo il Buddismo il vero aspetto della vita risiede nel suo incessante fluire, nel modo in cui le esperienze vengono generate dall’interazione fra tendenze interne e circostanze esterne. Quindi ciò che sperimentiamo come buono o cattivo non è qualcosa di fisso ma dipende dal nostro atteggiamento e dalla nostra risposta. Bene e male non sono entità immutabili. Per fare un semplice esempio, la collera può agire per il bene se viene diretta contro cose che minacciano la dignità umana mentre se è motivata dal perseguimento egoistico dei propri interessi diventa malvagia. Quindi la collera, che di solito viene considerata negativa, in realtà nella sua essenza è neutra.
Note
1) Arnold J. Toynbee, The World and the West, London, Oxford University Press, 1953, p. 81.
2) Edward W.Said, Culture and Imperialism, New York, Vintage Books, 1994, p. 12
3) Albert Schweitzer, On the Edge of the Primeval Forest: The Experiences and Observations of a Doctor in Equatorial Africa, Fontana Edition, London and Glasgow, A.& C.Black Limited, 1956, p. 96.
4) Said, Culture and Imperialism, xiii.
5) Johann Galtung e Daisaku Ikeda, Choose Peace, trad. di R. Gage, East Haven, CT, Pluto Press, 1995, p. 127.
6) Vedi Akira Irye, Cultural Internationalism and the World Order, Baltimora, John Hopkins University Press, 1997.
7) Arnold J.Toynbee, Civilization on Trial, New York, Oxford Press, 1948, p. 213.
8) Carl G. Jung, After the Catastrophe, Essays on Contemporary Events, trad. Elizabeth Welsh, London , Kegan Paul, 1947, p. 71.
9) Martin Luther King Jr., “I have a Dream”, A Testament of Hope: The Essential Writings and Speeches of Martin Luther King Jr., ed. James M.Washington, First Harper Collins Paperback Edition, San Franscisco, Harper San Francisco, 1991, p. 219.
10) Carl G. Jung, The Undiscovered Self, trad.R.F.C.Hull, Boston, Little, Brown and Company, 1958, p. 101.
11) ibid., pp. 5-15.
Per il bene della pace. Sette sentieri verso l'armonia globale. Una prospettiva buddista - di Daisaku Ikeda
Capitolo 5.2° - Il sentiero delle nazioni - AUDIO generato con un sintetizzatore vocale

Passare dalla sovranità nazionale alla sovranità dell’umanità. È il tema centrale affrontato da Ikeda in questo brano, corrispondente al sesto capitolo del volume For the Sake of Peace – di cui è uscita la versione italiana dal titolo Per il bene della pace, per la casa editrice Esperia. «Credo che le Nazioni Unite – afferma – debbano valorizzare il ruolo dei popoli all’interno della propria organizzazione e delle proprie funzioni, perché oggi il potere dei cittadini comuni sta crescendo rapidamente»
Che ne sarà delle nazioni nel nuovo millennio?
Gli ultimi anni hanno visto un importante cambiamento nella natura delle relazioni tra gli stati. Da un lato, c’è la tendenza verso la condivisione della sovranità che sta emergendo nella Comunità europea. Dall’altro, c’è una continua disgregazione di stati-nazione in conseguenza delle istanze di autonomia e di indipendenza dei popoli che li costituiscono. Sotto la pressione di entrambe le tendenze, il concetto tradizionale di sovranità nazionale sta subendo un ripensamento sostanziale.
La forza repressa delle aspirazioni nazionalistiche ed etniche si è dimostrata, tantissime volte, resistente all’ideologia e alla forza delle armi, ed è stata spesso abbastanza potente da riuscire a cacciare gli oppressori. La forza dei sentimenti nazionalisti indigeni deriva dal potere combinato delle consuetudini, della cultura e della religione tradizionali.
Se si guarda la storia, l’instaurazione di relazioni di eguaglianza e reciproco rispetto tra gruppi etnici o razze differenti è più facile a dirsi che a farsi. Sia trasversalmente ai confini nazionali sia all’interno di una singola nazione multirazziale, il controllo, la discriminazione e l’oppressione di una razza da parte di un’altra sono stati la regola, non l’eccezione. Ma sarebbe un serio errore immaginare che il risentimento delle minoranze oppresse possa essere represso indefinitamente con l’uso della forza. La disintegrazione del colonialismo europeo e di quello giapponese e, negli anni recenti, della pax russo-americana, può essere interpretata come il processo attraverso il quale le speranze e le aspirazioni dei popoli oppressi e sfruttati si sono affacciate alla ribalta della storia. Non possiamo e non dobbiamo cercare di invertire questa corrente storica. I diritti di tutti i popoli devono essere tutelati, e alla luce dei successi conseguiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel passato, dobbiamo fare in modo che essa assuma un più attivo ruolo di guida.
I pericoli dell'universalismo
Assumere un ruolo di guida non significa, ovviamente, imporre un sistema universale di governo. Gli aspetti positivi e negativi dell’universalismo di stampo americano, per esempio, sono ben noti: l’umanitarismo e l’idealismo che tradizionalmente ispiravano l’universalismo americano si trasformarono con Truman in una politica di scontro, che fu amplificata dal comportamento e dalle reazioni dei sovietici. Questa ideologia dello scontro, che come meta dichiarata aveva quella di aiutare i popoli a mantenere le proprie istituzioni e la propria integrità contro i movimenti aggressivi volti a imporre su di essi un regime totalitario, era una metamorfosi reazionaria dell’universalismo idealistico. Thomas Paine, influente ideologo della rivoluzione americana, scrisse che «la causa dell’America è in grande misura la causa di tutta l’umanità», un principio di eguaglianza che si collega a un universalismo pienamente sicuro di sé.1 Non si può dire però che questa dottrina messianica abbia contribuito a stabilire quel genere di valori universali che trascendono le razze e le nazioni. In circostanze come la guerra del Vietnam e la rivoluzione iraniana essa si è trovata in diretto conflitto con la forza impetuosa del nazionalismo.
In rapporto al divario tra internazionalismo e nazionalismo, il socialismo è ancora più irto di contraddizioni di base, a causa del fatto che il marxismo-leninismo, indicando l’internazionalismo proletario come valore e scopo supremi, si pone agli antipodi del nazionalismo.
Uno degli assunti centrali del Manifesto del partito comunista è che i lavoratori non hanno patria. Gli autori del Manifesto dichiarano semplicemente che quando il conflitto e lo sfruttamento tra le classi vengono eliminati, l’antagonismo e lo sfruttamento tra razze e nazioni scompaiono naturalmente.2 In altre parole, come motivazione alla realizzazione del valore universale del proletariato internazionale, l’aspirazione all’autoaffermazione nazionale o etnica è considerata inferiore alla coscienza e alle aspirazioni di classe.
Nei fatti, comunque, dal momento che la Rivoluzione russa a dispetto delle predizioni di Lenin e di altri non è riuscita a scatenare una rivoluzione mondiale, la fiducia che le differenze razziali e nazionali si sarebbero annullate nella lotta di classe si è indebolita col passare degli anni ed è svanita senza lasciare traccia.
Nazionalismo e identità

Vorrei esaminare qui il motivo per cui il nazionalismo è una parte integrante della struttura della società e dei meccanismi della mente umana. In sintesi, questo sentimento è intimamente connesso al bisogno di identità dell’essere umano. La questione dell’identità può sembrare un argomento ormai logoro, dopo tutti i libri e gli articoli che sono stati scritti al riguardo, ma io non credo che il problema centrale di come si acquisti la stabile consapevolezza di essere se stessi la base della propria esistenza sia stato risolto. Piuttosto, nel passaggio dalla civiltà uniforme e standardizzata dell’era industriale alla società postindustriale, la crisi di identità che sta di fronte agli individui, alle società e alle nazioni sta diventando sempre più acuta. È per questa ragione che la questione dell’identità nazionale, etnica o razziale sta venendo alla luce.
Ogni volta che rifletto sul tema dell’identità nazionale, non posso fare a meno di ricordarmi degli ultimi tragici anni dello scrittore austriaco Stefan Zweig. Come è noto, Stefan Zweig era uno scrittore di fama mondiale che fu costretto a fuggire dal suo paese a causa dell’Anschluss, l’annessione dell’Austria alla Germania nazista. In Brasile, dove aveva trovato rifugio, Zweig mise termine alla sua vita col suicidio. Le memorie di Zweig, Il mondo di ieri, descrivono con strazianti dettagli e in uno stile che trasuda dolore e pathos, l’angoscioso stato mentale in cui egli era caduto dopo essere stato costretto a lasciare la sua patria. La crudele ironia è che Zweig, insieme a Romain Rolland, era uno dei rari cosmopoliti votati all’ideale dell’unificazione spirituale dell’Europa. Il seguente brano descrive le sue reazioni emotive alla perdita del passaporto.
«Qualunque ne sia la ragione, l’emigrazione inevitabilmente turba l’equilibrio di un individuo. È qualcosa che deve essere sperimentato per essere compreso: in terra straniera il rispetto per se stessi tende a diminuire, insieme alla sicurezza e all’autostima. Non esito a confessare che dal momento in cui per poter vivere dovetti servirmi di documenti e passaporto che per me erano “stranieri”, sentii di aver cessato di appartenere a me stesso. Una parte della mia identità naturale, con il mio fondamentale e originale io, fu distrutta per sempre. […] Tutti i miei sforzi di quasi mezzo secolo per abituare il mio cuore a battere come il cuore di un citoyen du monde (cittadino del mondo, ndr) erano stati inutili. Il giorno in cui persi il mio passaporto scoprii, all’età di cinquantotto anni, che essere costretto ad abbandonare la propria terra natale è molto di più che separarsi da una determinata regione geografica».3
Leggendo questo resoconto così sincero e drammatico della crisi di identità di Zweig, si è colpiti una volta di più da quanto profondamente i concetti di nazione e di patria possano penetrare la psiche umana.
Shuichi Kato, critico letterario ed esperto di cultura comparata, ha sottolineato che, per un’analisi approfondita del fascismo, non è sufficiente studiare le opere di autori e intellettuali come Thomas Mann, che abbandonarono la Germania nazista. È altrettanto importante indagare il pensiero di persone come Gottfried Benn che, nonostante le sue successive perplessità, inizialmente fu un sostenitore entusiasta del nazismo. Kato cita un brano di Benn: «Anche se le cose non vanno bene, ciò non cambia il fatto che questo sia il mio popolo. Quanto sono gravide di significato le parole “il popolo tedesco” (das Volk). Tutto ciò che mi riguarda, la mia esistenza spirituale ed economica, il mio linguaggio, la mia vita, le mie relazioni, il mio cervello, tutto è dovuto al popolo tedesco».4
Per quanto da prospettive nettamente contrastanti, sia Zweig sia Benn parlano dell’importanza dell’identità razziale e nazionale nella vita umana. E non solo sotto il fascismo o il nazismo, ma anche sotto il militarismo giapponese la nazione acquistò un’importanza gigantesca per ogni individuo che viveva e respirava entro la sua struttura.
In un mondo sempre più internazionalizzato, tuttavia, non è più né produttivo né significativo limitarsi a sottolineare la tenacia dell’identità razziale e nazionale, o la sua unicità. Continuare a farlo significherebbe precipitare il mondo nel caos. Come ho detto prima, la pax russo-americana, benché mantenuta grazie a un enorme potere distruttivo, ha rappresentato nondimeno un tipo di ordine e la sua disintegrazione minaccia davvero di ridestare lo spettro del nazionalismo in tutto il mondo. Ciò deve essere evitato a tutti i costi. Né Zweig né Kato sono prigionieri, nelle loro argomentazioni, della ristretta struttura della nazione. La gravità del problema del nazionalismo rende ancor più pressante la necessità di superarlo. Per quanto difficile possa essere il compito, la definizione di principi e ideali che siano contemporaneamente universali nel loro orientamento e globali nella loro visione, è una necessità ineludibile se vogliamo affrontare con successo le sfide del nuovo secolo.
Il bisogno di autodeterminazione
Alla base degli sforzi collettivi per superare le attuali crisi mondiali, sembra esserci il comune riconoscimento che il moderno stato-nazione, un retaggio della storia moderna che ha dominato per tutto il XX secolo, sta cambiando. Sarebbe eccessivo parlare di “sepoltura” dello stato, ma certamente la sua presenza è meno incombente di un tempo.
Benché la sovranità degli stati sia alquanto diminuita, è irragionevole pensare che la struttura organizzativa da essi fornita crollerà facilmente. Sarebbe non solo imprudente, ma addirittura molto pericoloso, fondare frettolosamente una federazione mondiale o un governo planetario per sostituirla. In base all’esperienza del crollo dell’ex Unione Sovietica, con quel che ne è seguito, il mondo ha imparato fin troppo bene che lo smantellamento forzato di una struttura esistente anziché portare a un nuovo ordine può condurre all’anarchia e al caos.
In ogni caso, pensare che gli stati-nazione scomparirebbero semplicemente con l’adozione di una federazione mondiale vorrebbe dire sognare a occhi aperti. Norman Cousins, noto per essere un deciso sostenitore del federalismo mondiale, non credeva possibile la nascita immediata di uno stato mondiale unitario. La sua idea, piuttosto, era che «debbano esserci distinzioni ben definite tra la giurisdizione mondiale e la giurisdizione nazionale, tra la sovranità da trasferire alla federazione e la sovranità mantenuta dagli stati-nazione».5
Analogamente, non voglio negare l’importanza dell’autodeterminazione etnica o nazionale. Ma se sosteniamo che le mete della pace e della libertà non possono essere raggiunte in sua assenza, allora stiamo dicendo che la maggior parte delle nazioni e dei popoli, che non hanno mai ottenuto di organizzarsi in uno stato nel pieno senso del termine, non saranno mai capaci di realizzare queste mete. Contemporaneamente, va notato che neanche gli stati-nazione esistenti sono necessariamente riusciti a realizzarle.
Mi sembra perciò chiaro che l’autodeterminazione nazionale non possa essere vista in termini assoluti. Ciò che è necessario, invece, è uno sguardo calmo e misurato ai fattori che impediscono la realizzazione dei desiderati frutti dell’autodeterminazione nazionale, ovvero la pace e la libertà. Dobbiamo esaminare approfonditamente le circostanze che permettono alla semplicistica retorica nazionalista di prendere il sopravvento su realtà più complesse e sforzarci costantemente di rimuovere i falsi orpelli, riflettendo nel contempo ampiamente e rigorosamente su quali siano i genuini interessi della persona umana.
Dalla sovranità nazionale alla sovranità dell'umanità
A questo fine, una delle trasformazioni di pensiero che devono aver luogo nel XXI secolo è quella che io definisco il passaggio dalla sovranità nazionale alla sovranità dell’umanità.
Innegabilmente, gli stati sovrani sono stati gli attori principali della violenza e delle guerre del XX secolo. Le guerre moderne, combattute come legittimo esercizio della sovranità degli stati, hanno coinvolto volenti o nolenti intere popolazioni in tragedie e sofferenze indicibili.
La Società delle nazioni prima e l’Organizzazione delle Nazioni Unite poi, entrambe fondate nelle amare congiunture conseguenti a un conflitto mondiale, hanno rappresentato in un certo senso un tentativo di creare un sistema supernazionale che limitasse e moderasse la sovranità degli stati. Dobbiamo riconoscere però che questo coraggioso progetto è ancora ben lontano dall’avere raggiunto il suo scopo originario. Le Nazioni Unite devono fronteggiare molti difficili problemi.
Se vogliono diventare un vero parlamento dell’umanità, le Nazioni Unite, a mio parere, devono basarsi sul cosiddetto potere morbido del consenso e dell’accordo raggiunti attraverso il dialogo, e la valorizzazione delle loro funzioni deve essere accompagnata da un cambiamento del tradizionale concetto di sicurezza centrato sulla forza militare. Un suggerimento può essere quello di creare un nuovo Consiglio di sicurezza dell’ambiente e dello sviluppo. In questo modo le Nazioni Unite riuscirebbero auspicabilmente a impegnarsi con maggior precisione e rinnovata energia nelle pressanti questioni legate alla sicurezza dell’umanità.
In questo impegno è fondamentale attuare un cambio di paradigma dalla sovranità nazionale alla sovranità dell’umanità, un’idea espressa efficacemente dalle parole iniziali della Carta delle Nazioni Unite: «Noi, i popoli delle Nazioni Unite…». Concretamente, dobbiamo promuovere quel tipo di educazione di base che possa formare cittadini del mondo disposti a impegnarsi per il benessere comune dell’umanità, insegnando la solidarietà tra tutti gli esseri umani.
Dal punto di vista del Buddismo, il passaggio dalla sovranità nazionale alla sovranità dell’umanità si focalizza nella questione di come sviluppare le risorse di carattere che permettano di sfidare con coraggio e moderare con saggezza i poteri, apparentemente schiaccianti, delle autorità governative.
A metà degli anni Settanta, nel corso del nostro dialogo, lo storico britannico Arnold Toynbee definì il nazionalismo come una religione, il culto del potere collettivo delle comunità umane. Questa definizione secondo me si applica egualmente sia agli stati sovrani sia a quel genere di nazionalismo che, nelle sue manifestazioni più tribali, sta fomentando oggi in tutto il mondo i conflitti regionali e sub-nazionali. Toynbee sosteneva anche che ogni futura religione mondiale dovesse essere capace di contrastare sia il nazionalismo fanatico sia quei mali che costituiscono gravi e reali minacce alla sopravvivenza umana.6
In particolare, non posso dimenticare la profonda aspettativa espressa da Toynbee riguardo al Buddismo, da lui definito un sistema universale di leggi della vita.7
In effetti, il Buddismo ha una ricca tradizione nel trascendere e relativizzare l’autorità secolare appellandosi alla legge morale interiore come unica base sulla quale fondarsi. Per esempio, quando il bramino Sela chiese a Shakyamuni di diventare un re dei re, un condottiero di uomini, lui rispose che era già un re, il re della verità suprema.
Altrettanto interessante è il modo in cui Shakyamuni riuscì a impedire che lo stato di Magadha attuasse il suo progetto di invadere il vicino stato di Vajji, episodio cui ho già accennato brevemente nel terzo capitolo. Alla presenza di un ministro dello stato di Magadha, che era andato a trovarlo con la sfacciata intenzione di informarlo semplicemente della progettata invasione, Shakyamuni pose a uno dei suoi discepoli sette domande sullo stato di Vajji.
I cittadini di Vajji apprezzano la discussione e il dialogo?
Apprezzano la cooperazione e la solidarietà?
Apprezzano le leggi e le tradizioni?
Rispettano gli anziani?
Rispettano i bambini e le donne?
Rispettano la religione e la spiritualità?
Apprezzano gli uomini di cultura, che siano loro concittadini oppure no?
Sono aperti alle influenze culturali dei paesi stranieri?
La risposta a tutte le domande fu affermativa e Shakyamuni spiegò allora al ministro di Magadha che fin quando i cittadini di Vajji avessero continuato a osservare questi principi, il loro stato avrebbe prosperato e non avrebbe conosciuto il declino. Perciò, concluse, sarebbe stato impossibile conquistarlo.
Questi sono i famosi “sette principi per prevenire il declino”, le sette linee guida per la prosperità delle comunità esposte da Shakyamuni durante il suo ultimo viaggio.8
È interessante notare i paralleli tra questi principi e gli sforzi attuali per garantire la sicurezza non attraverso il potere militare ma attraverso la promozione della democrazia, dello sviluppo sociale e dei diritti umani.
Questo episodio è anche un vivido ritratto della statura e della dignità di Shakyamuni nel rivolgersi all’autorità secolare come re della verità suprema.
Fu con lo stesso spirito che Nichiren nel 1260 inviò il suo famoso trattato Adottare la dottrina corretta per la pace nel paese alle supreme autorità del Giappone dell’epoca, ammonendole perché restavano sorde alle grida del popolo.9
Da quel momento, la vita di Nichiren fu una serie di interminabili persecuzioni che spesso misero a repentaglio la sua stessa vita. Diversi brani dei suoi scritti esprimono il suo senso di libertà interiore, ad esempio quello in cui dice: «Poiché sono nato nel dominio del governante, devo obbedirgli nelle azioni. Ma non gli debbo obbedienza in ciò che credo nel mio cuore».10 O: «Prego prima di ogni altra cosa di poter guidare verso la verità il sovrano e gli altri che mi hanno perseguitato».11 O anche: «Le persecuzioni dovrebbero infondere un senso di pace e sicurezza».12
Affidarsi all’eterna legge interiore per elevarsi al di sopra dell’influenza dell’autorità effimera perseguendo la nonviolenza e l’umanità: è nel corso di questa grandiosa lotta che si sperimenta un’indistruttibile condizione di pace e sicurezza.
Sono fiducioso che queste nobili dichiarazioni risuoneranno con forza e in profondità nei cuori dei cittadini del mondo impegnati a creare la civiltà globale del XXI secolo.
Le Nazioni Unite e la "causa giusta”
Un requisito necessario per stabilire la pace tra le nazioni è trovare un metodo efficace per conciliare le opposte concezioni della giustizia. Come parte del movimento per la riforma e il potenziamento delle Nazioni Unite, credo sia imperativo che venga costituita una commissione di uomini e donne di provata saggezza che abbia il compito di elaborare un progetto di riforma. Questa commissione dovrebbe essere costituita su scala mondiale e i suoi membri dovrebbero discutere da una prospettiva genuinamente cosmopolita non solo specifiche questioni concrete, ma anche temi morali e filosofici come, ad esempio, il significato di giustizia.
Le crisi come quella che portò alla guerra del Golfo del 1991 implicano grandi questioni. Per esempio: cosa costituisce una causa giusta per gli arabi? Il presidente iracheno Saddam Hussein subordinò alla risoluzione della questione palestinese ilritiro dal Kuwait, nel tentativo di collegare il problema Iraq-Kuwait all’intera questione araba. Gli Stati Uniti non accettarono questo collegamento e in ultima analisi fu questo che portò allo scoppio della guerra.
Non c’è spazio qui per discutere la causa araba in dettaglio, ma vorrei commentare brevemente le implicazioni delle espressioni “giustizia” e “causa giusta”. Queste parole possiedono il potere carismatico di infiammare le persone. Anche il popolo giapponese, prima del 1945, fu esaltato da quella che era chiamata la causa eterna. I giapponesi che come me sono vissuti durante la guerra non possono sentire la parola “causa” senza chiedersi cosa ci sia dietro e ricordare quello slogan. Non è corretto, ovviamente, equiparare la causa araba al fanatico slogan del fascismo militarista giapponese, ma dobbiamo stare bene attenti a capirne correttamente la natura, perché in suo nome vengono sacrificate molte vite.
Quando rifletto sulla giustizia e sulle cause giuste, mi tornano in mente gli ammonimenti del giurista austriaco Hans Kelsen sulle trappole della giustizia assoluta. Kelsen dice: «La giustizia assoluta è un ideale irrazionale o, il che è lo stesso, un’illusione, una delle eterne illusioni dell’umanità. Dal punto di vista della conoscenza razionale esistono solo interessi umani e conflitti di interesse, e la soluzione di questi conflitti può essere trovata o soddisfacendo l’interesse di uno a spese degli altri o arrivando a un compromesso tra gli interessi in conflitto. Non è possibile dimostrare che solo una delle due soluzioni sia giusta. Supponendo che la pace sociale sia il fine ultimo, ma solo in questo caso, il compromesso può essere la soluzione giusta, ma la giustizia in funzione della pace è soltanto una giustizia relativa e non una giustizia assoluta».13
Precedentemente nello stesso saggio Kelsen scrive: «Il bisogno di una giustizia assoluta sembra essere più forte di qualunque considerazione razionale. Perciò l’uomo cerca di raggiungere la soddisfazione di questo bisogno attraverso la religione e la metafisica».14
Kelsen asserisce che l’aspirazione alla giustizia, nel bene e nel male, è una componente innata della natura umana. In effetti, si potrebbe dire che il carattere di una persona è formato dal suo concetto di giustizia.
È anche vero, tuttavia, che dobbiamo staccarci una volta per tutte dal caotico mondo in cui le differenti concezioni della giustizia si scontrano tra loro, in cui gli esseri umani vengono scaraventati nel mezzo di questo scontro e il loro sangue viene versato in nome della giustizia, proprio come evidenzia Kelsen. La storia umana è piena di guerre sanguinose combattute esattamente per questa ragione. In special modo nelle società dominate da una religione esclusivista e monoteistica come il Cristianesimo, l’Ebraismo o l’Islamismo, impedire tali conflitti è un serio problema e da sempre molti sagaci pensatori, compresi Sant’Agostino e San Tommaso d’Aquino, hanno discusso a fondo sulla natura della guerra giusta.
Ma la questione della giustizia e della pace deve davvero essere un aut aut come suggerisce Kelsen? Io non lo penso affatto. Se nell’essere umano l’anelito alla giustizia è così forte come lui dice, deve esserci sicuramente un modo per ottenere vera pace attraverso la devozione alla giustizia, deve esserci una via che conduce a un più alto ordine di pace e di giustizia. La cosa importante allora è studiare attentamente il significato e le condizioni della giustizia.
Consideriamo il concetto di pace compatibile con la giustizia da sostituire a quello di guerra per amore di giustizia, come propone Arthur Kauffmann, professore emerito dell’Università di Monaco. Il professor Kaufmann identifica sei prerequisiti per il raggiungimento di questo obiettivo.15
Il primo è il principio di eguaglianza. Basato sul riconoscimento della fondamentale sacralità della vita, esso garantisce eguale dignità a tutti gli individui. Tra le nazioni, esso assicura eguali opportunità ed eguale rispetto nelle relazioni economiche e culturali. Il secondo prerequisito è la regola aurea espressa nella Bibbia: «Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te». Il professor Kaufmann traduce questa regola in un principio etico allargandola fino a includere la sua forma negativa: «Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te». Il terzo prerequisito è l’imperativo categorico che è stato formulato da Kant: «Agisci unicamente secondo quella massima in forza della quale tu possa volere nello stesso tempo che essa divenga una legge universale». Il quarto è il principio dell’imparzialità. Come nello sport, dove giocare su un piano di parità è la regola fondamentale, nelle relazioni internazionali tutti i paesi devono avere diritto agli stessi vantaggi e subire gli stessi svantaggi. Il quinto è il principio di responsabilità. Non deve essere intrapresa nessuna azione le cui conseguenze possano distruggere, danneggiare o degradare la vita delle persone o l’ambiente nel quale esse vivono, ora o nel futuro. Il sesto è il principio della tolleranza. Anche se le idee del vostro vicino vanno contro i vostri interessi, dovete rispettarle.
Lo spazio mi impedisce di analizzare dettagliatamente ognuno dei sei prerequisiti, ma vorrei affermare che se ogni paese aderisse a questi standard di giustizia, sarebbe possibile costruire una pace compatibile con la giustizia e non semplicemente una pace come temporanea assenza di guerre o nei termini di Kelsen come soluzione di compromesso ai conflitti di interesse. Questo è il genere di questione che dovrebbe essere discussa nell’organo consultivo internazionale proposto poc’anzi.
Cosa succederà invece se questa idea di pace e giustizia viene ignorata e se specifiche religioni e ideologie continuano a insistere che solo la loro definizione di giustizia è assoluta? Il professor Kaufmann cita il premio Nobel Konrad Lorenz, etologo e zoologo: «Il tentativo stesso di mantenere le norme sociali e le formalità che sono considerate corrispondere ai più alti valori è ciò che porterà alla guerra religiosa, la più terrificante di tutte le guerre. Ed è la possibilità di questa guerra che ci minaccia oggi».
Chi segue una religione che mira alla pace e al bene dell’umanità deve tenere a mente questi avvertimenti nel compiere la propria opera.
I cinque principi di pace
Un atteggiamento moderato verso la sovranità nazionale ci viene da Kant, che credeva che lo stato sovrano non fosse necessariamente oppressivo e che gli interessi del popolo coincidessero in larga misura con quelli dello stato, e considerava lo stato come un organismo difensivo e autonomo meritevole di protezione.
Questa immagine dello stato nazionale è valida ancora oggi ed è di importanza capitale per le piccole e le medie nazioni costituitesi in Asia e in Africa con la caduta dei vincoli coloniali dopo la seconda guerra mondiale. La coscienza di tutti i popoli asiatici e africani del terzo mondo è splendidamente cristallizzata nei principi stabiliti nella prima Conferenza afro-asiatica tenutasi nel 1954 a Bandung, in Indonesia. Questi cinque principi di pace sono ben più che reliquie del passato:
1) mutuo rispetto dei diritti territoriali
2) non aggressione reciproca
3) non intervento nella politica interna
4) eguaglianza e reciprocità
5) coesistenza pacifica.
Si deve al credito delle Nazioni Unite se, nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale, il principio di autodeterminazione dei popoli (il rovescio della medaglia dei diritti di sovranità dello stato nazionale) è progredito grazie all’operato del Consiglio di amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite. Nel porre limiti ai diritti degli stati, è essenziale fare riferimento a queste esperienze passate e seguire un approccio cauto e graduale, continuando a insistere sulla volontarietà della limitazione e del trasferimento dei diritti di sovranità.
Anche l’ex presidente della Germania Occidentale, Richard von Weizsäcker, sottolineò che i cittadini del mondo non devono essere privi di radici, dal momento che proprio le radici consentono di avere una reale coscienza dell’umanità. La tolleranza fiorisce, egli disse, non dove c’è una mescolanza universale di persone senza radici, ma dove gli individui sono consapevoli delle loro radici nazionali. Le sue tesi che la consapevolezza dell’unità del mondo non è in conflitto col patriottismo e che la coscienza di essere cittadini del mondo è abbastanza comune tra gli europei, sono molto importanti.
Tuttavia, una delle questioni più urgenti da risolvere oggi è trovare una via che consenta alle persone comuni di superare i grandi ostacoli che il potere statale e politico continua a frapporre e di aprire la strada alla pace permanente.
Lo scopo delle Nazioni Unite
Fin dall’origine, le Nazioni Unite hanno contemplato i due aspetti dei governi e dei popoli, che sono i soggetti identificati nel preambolo della Carta delle Nazioni Unite: «Noi, i popoli delle Nazioni Unite» e «i nostri rispettivi governi». Ma in realtà le Nazioni Unite hanno sempre funzionato come un’organizzazione di governi e le loro decisioni sono state prese da quei governi. I popoli sono stati relegati dietro le quinte.
Credo che le Nazioni Unite debbano valorizzare il ruolo dei popoli all’interno della propria organizzazione e delle proprie funzioni, perché oggi il potere dei cittadini comuni sta crescendo rapidamente. In particolare, le organizzazioni non governative (ONG) promettono di diventare una forza efficace per la ricerca di vie d’uscita ai problemi che le Nazioni Unite hanno difficoltà a risolvere.
Attualmente, le relazioni tra le Nazioni Unite e le ONG stabilite dall’Articolo 71 della Carta delle Nazioni Unite sono limitate alle consultazioni con il Consiglio economico e sociale, ma in realtà sono già andate molto al di là. Particolarmente degna di nota è la crescente influenza delle ONG sulla diplomazia interstatale attraverso il loro dinamico coinvolgimento nelle questioni globali, che ha incluso la loro partecipazione alle conferenze promosse dalle Nazioni Unite sull’ambiente e sul disarmo. Queste attività delle ONG, mirate a impostare i problemi globali e a cercarne le soluzioni a vantaggio dell’intera specie umana piuttosto che dei singoli stati, sono indispensabili.
Un sistema democratico è finalizzato a porre un controllo sulle azioni di governo mantenendole nel giusto corso. Il tempo è maturo per ideare un sistema che faciliti la partecipazione diretta delle ONG alle discussioni delle Nazioni Unite. Spero sinceramente che la saggezza delle persone venga sfruttata con tutti i mezzi possibili nel processo di revisione e di rafforzamento delle Nazioni Unite, affinché quest’organizzazione diventi una struttura in grado di riflettere la volontà popolare.
Un altro settore in cui le ONG possono dimostrarsi utili è quello dell’allarme tempestivo, che è ora un importante aspetto delle attività delle Nazioni Unite. Negli anni recenti le Nazioni Unite hanno sviluppato un sistema destinato a raccogliere informazioni e ad allertare tempestivamente in caso di crisi pericolose come l’inquinamento ambientale, i disastri naturali, le carestie, i movimenti di popolazione, le epidemie e gli incidenti atomici. Lo scopo è quello di assicurare che le persone interessate siano informate e aiutare a trovare soluzioni per i problemi prima che essi raggiungano proporzioni critiche. Il sistema è un tassello importante dell’impegno delle Nazioni Unite nella cosiddetta diplomazia preventiva. Nel contesto di questo sistema di allarme tempestivo la capacità delle ONG di raccogliere informazioni è stata altamente lodata, e se le relazioni cooperative tra le ONG e le Nazioni Unite verranno sviluppate ulteriormente, sicuramente il sistema diventerà ancora più efficace.
Un altro importante fattore del rafforzamento delle Nazioni Unite è la creazione di un meccanismo tramite il quale il Consiglio di sicurezza, l’Assemblea generale e il segretario generale possano mobilitare tutte le risorse delle varie agenzie delle Nazioni Unite verso la soluzione di un dato problema. La mancanza di un meccanismo di questo genere, organicamente strutturato e con collegamenti orizzontali, è un ostacolo alla piena operatività delle Nazioni Unite. Come già detto, una chiave per aumentare l’efficacia delle Nazioni Unite sta in un abile utilizzo delle forze delle ONG. Per questa ragione propongo che, come misura provvisoria, sia stabilito una sorta di forum per regolari consultazioni tra il segretario generale delle Nazioni Unite e i rappresentanti delle ONG.
La pace e la volontà popolare
Per quanto sia mia opinione che le funzioni delle Nazioni Unite debbano essere ampliate e rafforzate nella loro opera per la pace e la sicurezza, sta alle persone stesse costruire un mondo libero dalla guerra. Il destino del XXI secolo dipende dalla nostra capacità di continuare a impegnarci nel difficile compito di raggiungere una vera pace e non cedere all’idea che sia un compito impossibile. Secondo gli archeologi, l’umanità pratica la guerra organizzata, intendendo con questo termine lo scontro tra gruppi, solo da diecimila anni mentre la specie umana esiste sulla terra da quattro milioni di anni. Questo fatto dovrebbe convincerci che non è impossibile realizzare una società umana in cui la guerra non esista.
Il corso della storia è costellato di molti eventi devianti, ma non dovremmo farci fuorviare da questi fenomeni passeggeri. Osserviamo invece attentamente la forte e profonda corrente che determina realmente la storia umana. Questa corrente non è nient’altro che la volontà popolare, e i popoli del mondo ovviamente non vedono l’ora di arrivare a un mondo senza guerre, un mondo di pace eterna.
NOTE
1) Thomas Paine, dall’introduzione a Common Sense in Thomas Paine’s Collected Writings (New York: The Library of America, 1976), p. 5.
2) Cfr. Karl Marx e Frederick Engels, A Communist Manifesto (New York: W.W. Norton and Company, 1988).
3) Stefan Zweig, Die Welt von Gestern (Lincoln, NB: University of Nebraska Press, 1964), p. 412.
4) Gottfried Benn citato in Shuichi Kato, Kato Shuichi chosakushu (Tokyo: Heibonsha, 1979), p. 203.
5) Norman Cousins, Sekai Shimin no Taiwa (Tokyo: Mainichi Press, 1991), p. 241.
6) Arnold Toynbee e Daisaku Ikeda, Choose Life: A Dialogue, trad. di Richard L. Gage (New York: Oxford University Press, 1976), p. 318.
7) Ibidem, p. 326.
8) Cfr. “Sela Sutta”, Sutta-Nipata, trad di H. Saddhatissa (London: Curzon Press, 1987), p. 65.
9) Gli scritti di Nichiren Daishonin, vol. 2, p. 96.
10) Ibidem, p. 97.
11) Ibidem, vol. 4, p. 30.
12) Nichiren Daishonin, Gosho zenshu, p. 750.
13) Hans Kelsen, What is Justice: Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science, Collected Essays of Hans Kelsen (Berkeley: University of California Press, 1957), pp. 21-22.
14) Hans Kelsen, op.cit., p. 10.
15) Cfr. Arthur Kaufmann, Gerechtigkeit, der vergessene Weg zum Frieden: Gedanken eines Rechtsphilosophen zu einem politischen Thema (München: Piper, 1986).
Per il bene della pace. Sette sentieri verso l'armonia globale. Una prospettiva buddista - di Daisaku Ikeda
Capitolo 6° - Il sentiero della consapevolezza - AUDIO generato con un sintetizzatore vocale

Cittadini del pianeta, consapevoli e responsabili, che agiscono qui e ora, coscienti che la «profondità della determinazione interiore è il fattore decisivo che dà vita al futuro e crea la storia». Così Daisaku Ikeda, in questa settima puntata del libro For the Sake of Peace – di cui è uscita la versione italiana dal titolo Per il bene della pace per la casa editrice Esperia – descrive le persone in grado di affrontare le sfide e risolvere i pressanti problemi che assillano l’umanità
Qualche tempo fa, l’astronauta Gerald Carr, che è stato comandante dello Skylab III, ha condiviso con me i suoi pensieri sulla religione. «Come cristiano – ha detto – quand’ero giovane concepivo Dio come un padre che ci sorveglia dall’alto. Pensavo che tirasse qualche filo per far accadere le cose e guidasse in un certo qual modo le nostre vite. Dopo essere stato nello spazio, sono rimasto colpito dal grande ordine universale delle cose, e oggi penso che questo ordine sia ciò che noi cristiani chiamiamo Dio e che le altre religioni chiamano in qualche altro modo. Dio è la comprensione che nell’universo esiste un ordine di tutte le cose, e credo che sia da questo sentimento religioso che derivi la comune universalità di tutti gli esseri umani. Credo che esso sia la base per comprendere la comunità mondiale».1
Pochi di noi potranno mai vedere il nostro pianeta dallo spazio. Ciò nondimeno, i problemi planetari impongono un riorientamento della nostra prospettiva. Dobbiamo arrivare a capire che è finito il tempo in cui ci possiamo permettere di preoccuparci solo degli interessi nazionali fondati su motivazioni ristrette e arbitrarie. La globalizzazione ha portato in superficie problemi che oltrepassano i confini nazionali, come la distruzione ambientale, la povertà e l’increscioso aumento del numero dei rifugiati e degli sfollati. Inoltre, a causa dell’incremento dei viaggi e degli spostamenti da un paese all’altro, le malattie infettive si diffondono con nuove e preoccupanti modalità. Abbiamo urgente bisogno di trovare misure adeguate per affrontare questi problemi. Nel quadro del sistema degli stati sovrani le crisi sono state per lungo tempo considerate questioni territoriali e molti paesi hanno perciò concentrato i propri sforzi sul potenziamento militare. Ma le questioni globali che abbiamo ora di fronte non possono essere trattate con approcci convenzionali. Di fatto, sono proprio questi problemi che, se lasciati covare, causano in molte regioni della terra conflitti interni e guerre. Allo stesso tempo, la povertà e l’esplosione demografica hanno un impatto negativo diretto sull’ambiente in quanto le persone, nella lotta per la sopravvivenza, distruggono le foreste con metodi agricoli irresponsabili e la scriteriata ricerca di combustibile.
Sfide planetarie
I tre colossali problemi che stanno davanti all’umanità – la distruzione dell’ambiente planetario, l’esplosione demografica e la povertà – sono inestricabilmente connessi tra loro, e noi abbiamo perciò il difficilissimo compito di trovare un approccio esaustivo che li risolva simultaneamente. Inutile dire che se vogliamo che i paesi in via di sviluppo sfuggano alla povertà, è necessaria un’efficace assistenza dei paesi industrializzati. In definitiva, però, il successo dipende dalle capacità di sviluppo dei paesi poveri, e la chiave di queste capacità sta nell’educazione.
Educare le persone al controllo delle nascite è uno dei fattori indispensabili per contenere la crescita demografica. La cosa importante è trovare il modo di incrementare le opportunità educative generali per tutte le persone nei paesi in via di sviluppo. In particolare, è stato dimostrato statisticamente che la creazione di opportunità educative per le donne accelera l’avanzamento della società e riduce il numero di nuovi nati.
Un altro problema capitale del nostro tempo è la situazione critica dei profughi, il cui numero è già salito a più di diciassette milioni di persone. In aggiunta ai profughi ordinari, che abbandonano la loro patria e si riversano nei paesi vicini per sfuggire alle devastazioni della guerra, stiamo anche vedendo un netto aumento del numero di persone che emigrano nei paesi industrializzati per sfuggire alla povertà e delle vittime dei conflitti etnici che vagano senza dimora entro i confini dei loro stessi stati. Come ONG delle Nazioni Unite, la SGI riconosce la gravità di questo problema internazionale e ha spontaneamente intrapreso attività di assistenza ai rifugiati.
Squilibrio Nord-Sud e sviluppo sostenibile
Sembrerebbe che stiamo vivendo in un’era di sfide pressanti che richiedono la nostra immediata risposta. Le scelte che facciamo ora potrebbero determinare la sopravvivenza della razza umana. Per loro stessa natura, i problemi globali che abbiamo di fronte richiedono lo sforzo combinato di tutti gli abitanti della Terra, senza distinzione tra Nord e Sud. Ma in realtà è diventata evidente un’enorme spaccatura tra i paesi industrializzati e i paesi in via di sviluppo, che costituisce una fonte di grande ansietà. Lo scopo primario di iniziative come il Summit della Terra del 1992 è la concreta attuazione del concetto di sviluppo sostenibile, che integra lo sviluppo con la protezione dell’ambiente. Sviluppo in questo caso non significa, come nel passato, lo sperpero irresponsabile delle risorse naturali, con la concomitante devastazione ambientale. Piuttosto, siamo alla ricerca di uno sviluppo equilibrato che assicuri la salvaguardia ambientale. L’obiettivo è uno sviluppo che guardi direttamente al futuro, che difenda gli interessi delle future generazioni e soddisfi tuttavia i bisogni fondamentali del presente. Ma il disaccordo tra Nord e Sud, relativo proprio alla definizione di sviluppo sostenibile, è ben lontano dall’essere risolto. Specificamente, sembra che tra i paesi in via di sviluppo stia crescendo la protesta contro il consumismo sfrenato dei paesi industrializzati, che viene considerato la ragione principale del degrado ambientale.
È pura fantasia pensare di poter sostenere a lungo l’enorme sfruttamento delle risorse dovuto alla produzione e al consumo di massa del Nord. Il nostro pianeta non potrà sopportarlo ancora a lungo. Povertà, sovrappopolazione e distruzione ambientale costituiscono un circolo vizioso per le nazioni del Sud, con le quali condividiamo un unico pianeta. Il cosiddetto problema PPE (poverty, population growth, environment: povertà, crescita demografica, ambiente) è una gravissima realtà che moltissimi osservatori imputano direttamente alla disparità tra Nord e Sud derivante dalla struttura dell’economia internazionale.
Per quanto riguarda la polarizzazione degli emisferi, il rapporto del 1996 sullo sviluppo umano stilato dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite avverte che «se le attuali tendenze continueranno, le disparità economiche tra le nazioni industrializzate e i paesi in via di sviluppo da inique diventeranno inumane». Il rapporto riassume in cinque punti le distorsioni della crescita economica:
– crescita della disoccupazione (crescita senza un aumento delle opportunità di lavoro);
– crescita spietata (crescita che non fa nulla per correggere le disparità tra i ricchi e i poveri);
– crescita senza voce (crescita non accompagnata dalla democratizzazione e dal progresso degli individui nella società);
– crescita senza radici (crescita che lede l’identità etnica degli individui);
– crescita senza futuro (crescita basata sullo spreco delle risorse necessarie alle future generazioni).
«In sintesi – afferma il rapporto – uno sviluppo che perpetua le attuali disuguaglianze non è né sostenibile né degno di essere sostenuto».2
Al Summit mondiale sull’alimentazione del 1996, l’attenzione si è concentrata sulla grave situazione dei più di ottocento milioni di individui malnutriti o affamati ed è stata adottata la Dichiarazione di Roma con un piano d’azione collegato mirante a dimezzare questo numero entro il 2015.
La necessità di una nuova cosmologia
Data la scala e la portata dei problemi globali appena discussi, è facile cedere alla tentazione di concepire delle soluzioni anch’esse su grande scala che vengano imposte da un potere mondiale transnazionale. Io invece suggerisco, al fine di superare la crisi di identità che mina la salute dell’umanità contemporanea, di sforzarci di elaborare una nuova cosmologia, per quanto possa sembrare un metodo indiretto.
Nel medioevo la vita degli europei si svolgeva all’interno del quadro di una cosmologia chiaramente definita e largamente accettata. La descrizione più eloquente di quella cosmologia si trova nella Divina Commedia. Dante immaginò il mondo costituito dai gironi dell’inferno che discendono fino al centro della Terra, dall’isola montagnosa del purgatorio e infine dal paradiso celeste dove dimora Dio.
A prescindere dalla sua validità, che non ha retto alle verifiche della scienza, la cosmologia tratteggiata nel capolavoro dantesco seppe comunque dare risposta alle domande fondamentali: «Chi siamo? Qual è l’origine del mondo? Perché siamo qui?». In questo modo fornì una struttura all’identità dell’essere umano e coltivando il senso della volontà divina all’opera nei momenti di felicità e di infelicità, di dolore e di piacere, di prosperità e di declino, riuscì a creare una gerarchia spirituale significativa e ordinata che permise alle persone di regolare la propria vita.
È stato detto che il passaggio dal medioevo all’epoca moderna ha rappresentato non la sostituzione della vecchia cosmologia con una nuova, ma l’abbandono di qualunque cosmologia. La moderna visione del mondo scientifica e meccanicistica è stata costruita sul rifiuto di affrontare questi temi fondamentali per l’essere umano, rinunciando perciò a qualunque pretesa di diventare una cosmologia. Inconsapevoli di questo fatto e decisi a mantenere tale inconsapevolezza, gli esseri umani di oggi scambiano la conoscenza per saggezza e il piacere per felicità. Ci siamo buttati a capofitto lungo la strada della modernizzazione e oggi ci ritroviamo a essere nient’altro che dei consumatori schiavi della produzione. Non è per nulla sorprendente, quindi, che la nostra crisi d’identità continui ad aggravarsi.
In Apocalisse, lo scrittore inglese D.H. Lawrence esortava al rinnovamento della cosmologia con un’urgenza tale da far pensare che prevedesse le condizioni della nostra epoca.
«Ciò che vogliamo – scrive Lawrence – è distruggere i rapporti falsi e inorganici, specialmente quelli connessi al denaro, e ristabilire i legami organici e vitali con il cosmo, con il sole e la terra, con l’umanità, la nazione e la famiglia. Cominciamo con il sole e il resto gradualmente verrà».3
La cosmologia buddista
Al cuore del movimento della SGI c’è lo sforzo di sviluppare una nuova cosmologia e di affrontare apertamente la crisi di identità. Il punto di partenza di quest’impresa è il risveglio sperimentato da Josei Toda nel 1944, durante la prigionia conseguente alla sua opposizione alla guerra. Avendo deciso, il 1 gennaio di quell’anno, di leggere il Sutra del Loto con il suo intero essere, Toda, grazie alle sue intense preghiere, ebbe due profonde illuminazioni, una in marzo e una in novembre.
La prima volta si illuminò alla verità che ciò che i sutra chiamano Budda non è altro che la vita. La seconda volta si risvegliò alla comprensione di essere uno dei Bodhisattva della Terra descritti nel Sutra del Loto, che simbolizzano la capacità innata di agire in modo illuminato e compassionevole, capacità che esiste in tutti gli esseri umani indipendentemente dalla loro cultura o dalla posizione sociale. Nel corso della solenne assemblea sul Picco dell’Aquila durante la quale Shakyamuni espose il Sutra del Loto, ai Bodhisattva della Terra viene affidato il compito di trasmettere nel futuro l’eredità della compassione senza curarsi degli ostacoli che avrebbero incontrato. In definitiva, Toda comprese che l’assemblea sul Picco dell’Aquila non era un semplice mito bensì una realtà attuale.
Il Sutra del Loto contiene molte scene allegoriche che sono spesso state scartate come pura fantasia. Le due illuminazioni di Toda, specialmente la seconda, corrispondono perfettamente con l’interpretazione del Sutra del Loto data da Nichiren e restituiscono al testo il suo pieno valore di visione cosmologica viva e vibrante. In questa prospettiva, le illuminazioni di Toda sono quindi un fatto di grande rilievo nella storia spirituale dell’umanità. Benché stiano su un piano indiscutibilmente differente da quello dei fatti indagabili dalla scienza empirica, esse rappresentano nondimeno degli eventi psichici esperienziali e, cosa ancor più importante, una verità religiosa universale. La rivelazione cosmologica che si è dispiegata nel cuore di Josei Toda è per noi della SGI il punto di partenza e la base dell’eterna immutabile identità del nostro movimento.
L’essenza dell’illuminazione di Toda può forse essere espressa come una profonda fede nel valore e nel potenziale infinito della vita umana, unita a una forte determinazione di risvegliare gli esseri umani a questa verità.
Questa cosmologia fornisce delle risposte alle domande fondamentali connaturate alla nostra stessa umanità e offre inoltre un quadro di riferimento, accessibile a tutti, per risolvere la crisi di identità e trasformare il caos in un mondo in cui tutti gli esseri umani possano trovare un significato nella loro esistenza.
Universalismo interiore in alternativa al messianismo sociale
A questo punto, vorrei proporre un concetto metodologico che può aiutarci nella ricerca di un nuovo globalismo: il concetto di universalismo interiore.
Vediamo per prima cosa come questo concetto possa applicarsi ai singoli esseri umani. Nei suoi scritti, Nichiren disse che la dignità intrinseca di un individuo serve da esempio per tutti, intendendo dire che tutti gli esseri umani devono essere considerati eguali. Quest’idea dell’assoluta eguaglianza e della santità di tutti gli esseri umani è il prodotto di una incessante esplorazione interiore della propria vita individuale. Poiché questa visione dell’essere umano è generata dall’interno, non lascia spazio a distinzioni basate su fattori esterni come la nazionalità e la razza.
Al contrario, quel genere di universalismo che ha caratterizzato l’ideologia dello scontro tra Stati Uniti e Unione Sovietica è esterno e trascendente rispetto agli individui. Sia la democrazia liberale sia il comunismo sono in linea di massima concetti istituzionali, in quanto cercano di controllare gli esseri umani dall’esterno e/o dall’alto. Perciò, benché entrambe le ideologie vadano al di là della struttura della nazione o dello stato, lo fanno in base a criteri esterni all’individuo.
Quali sono, allora, i difetti basilari di questo tipo di universalismo? L’inconveniente più serio è che, a causa delle sue sfumature eccessivamente ideologiche e della mancanza di considerazione del comune denominatore dell’umanità, esso è pronto a dividere il mondo in buoni e cattivi. Quando poi è promosso da superpotenze ansiose di aiutare a civilizzare e a illuminare popoli considerati arretrati e ignoranti, questo particolare genere di universalismo assume facilmente un carattere messianico. Benché lo spirito missionario possa agire da forza motrice della creatività e dello sviluppo, esso si trasforma facilmente in presunzione.
Come hanno sottolineato molti storici, il messianismo è stato una caratteristica di rilievo del pensiero americano sin dai tempi della guerra d’Indipendenza. Questa tradizione è una qualità quando è ispirata dall’idealismo umanitario di un Wilson o di un Roosevelt, ma quando va a braccetto con l’ideologia dello scontro della dottrina Truman diventa un difetto.
Nel caso dell’Unione Sovietica il messianismo assume una forma ancora più evidente. In Il mondo di ieri, Zweig descrive ciò che poté osservare in quel paese nel 1928, quando fu invitato a partecipare alle celebrazioni del centenario della nascita di Tolstoj.4 Zweig si trovò di fronte l’immagine di un popolo russo traboccante di buona volontà e ingenuamente colmo di un ardente senso di missione, che deriva dalla convinzione di prendere parte a un’impresa storica a beneficio di tutta l’umanità. Lo spettro dello stalinismo non aveva ancora drizzato il suo mostruoso capo e i russi erano desiderosi di dedicarsi alla loro missione nazionale. Le considerazioni di Zweig mi ricordano la descrizione di Dostoevskij della reazione a un discorso da lui fatto nel corso di una celebrazione in memoria di Puskin: «Quando alla fine parlai dell’unità universale di tutti gli esseri umani, il pubblico in sala fu colto da una sorta di isteria. Non so come descrivere il trambusto e le esclamazioni di giubilo che seguirono la fine del mio discorso. Perfetti estranei si abbracciavano piangendo tra i singhiozzi, si giuravano reciprocamente di diventare migliori, di non odiare più gli altri ma di amarli».5
Situandolo nel contesto delle aspirazioni nazionali del popolo russo, Nikolaj Berdjaev definì il comunismo come una specie di identificazione dei due messianismi, il messianismo del popolo russo e il messianismo del proletariato.6 Questa definizione si applica appropriatamente alla prima fase del comunismo sovietico.
Durante la fase postbellica dello stalinismo, questo messianismo universalistico degenerò in quello che potrebbe essere definito lo sciovinismo della Grande Russia, giustificato in nome dell’internazionalismo proletario. Benché Mosca definisse i partiti comunisti degli altri paesi, compresi quelli dell’Europa orientale, “partiti fratelli”, in realtà li rese succubi, come un fratello maggiore che domina sui fratelli più piccoli che lo attorniano.
Come concetto metodologico, l’universalismo interiore ha un grado di praticità che a sua volta detta un certo modello di comportamento umano. Esso presume che il valore universale sia inerente a ogni singolo individuo, che deve perciò svilupparlo all’interno della propria vita. Questo valore, per sua stessa natura, non può quindi essere imposto con la forza.
La strategia che logicamente deriva da questo concetto di universalismo interiore è caratterizzata dal gradualismo in opposizione al radicalismo. Mentre il radicalismo è guidato dalla forza, il gradualismo è alimentato dal dialogo. L’uso della forza è invariabilmente un prodotto della sfiducia; il dialogo, al contrario, è basato sulla fiducia e il rispetto reciproci.
Che si tratti del Dio del medioevo o del proletariato dell’era moderna, fin quando il valore universale è esterno e trascendente ne consegue che il più grande bene sta nel raggiungere il più velocemente possibile le mete stabilite in funzione di quel valore. Coloro che si rifiutano ostinatamente di condividere quelle mete dovranno essere forzati a diventarne fedeli sostenitori con mezzi di coercizione fisici o di altro genere, mentre coloro che ne ostacolano la realizzazione devono essere eliminati con la forza. Ciò che ne risulta è una tipica forma di radicalismo. In questa prospettiva si può capire perché la storia della chiesa cristiana medievale così come quella dei moderni movimenti comunisti è costellata dal ricorso alla forza e alla violenza.
La visione buddista del tempo
Per aiutare a stabilire una coscienza planetaria o addirittura cosmica, suggerisco di riesaminare la storia dell’umanità su una più ampia scala spaziale e temporale.
Il Buddismo parla di tre periodi successivi alla morte del Budda Shakyamuni, che gli studiosi moderni situano intorno al 500 a.C. Questi periodi sono il Primo giorno della Legge, quando le persone possono ottenere l’Illuminazione abbracciando l’insegnamento di Shakyamuni, il Medio giorno della Legge, quando il Buddismo diviene formale e meno efficace, e l’Ultimo giorno della Legge, quando gli insegnamenti di Shakyamuni perdono il potere di condurre le persone all’Illuminazione. Si credeva che ognuno dei primi due periodi durasse tra i cinquecento e i mille anni, mentre l’ultimo si sarebbe protratto per diecimila anni.
Nichiren scrive che Nam-myoho-renge-kyo (che lui identificò come la Legge fondamentale della vita) «si diffonderà per diecimila anni e più, per tutta l’eternità».7 Da questa prospettiva a lungo termine egli indica che i suoi insegnamenti avranno il potere di risvegliare le persone e contrastare la sofferenza anche in questo corrotto Ultimo giorno della Legge, contribuendo al benessere della società umana nel lontano futuro, per diecimila anni e più a partire da allora. Si tratta di un orizzonte temporale amplissimo, di una grandiosa visione del futuro che deriva da una convinzione straordinariamente profonda.
Si può dire che l’approccio di Nichiren rappresenti l’essenza della visione buddista della storia. La suddivisione in tre periodi non deve essere vista in termini formali o categorici, né interpretata come un progresso lineare e consecutivo della storia spirituale dell’umanità. A me sembra chiaro che il brano citato rifletta l’energica e ininterrotta battaglia di Nichiren contro le continue persecuzioni del governo ed esprima la sua lucida comprensione delle correnti più profonde della storia umana.
Per coloro che praticano il Buddismo di Nichiren, i suoi insegnamenti dovrebbero perciò essere letti con uno sguardo attento al loro significato più profondo e con lo sforzo di percepire le correnti sotterranee che fluiscono dal passato al futuro. Con questa prospettiva è possibile identificarsi con la profonda compassione che Nichiren sentiva per tutta l’umanità e vivere al servizio degli altri proprio come quelli che il Buddismo chiama Bodhisattva della Terra.
È per questo motivo che dobbiamo riconsiderare la nostra concezione del tempo. Nel linguaggio quotidiano ci riferiamo casualmente a questo concetto senza considerarne attentamente le implicazioni né essere consapevoli della sua profondità. Il tempo è stato oggetto di grande interesse per filosofi come Martin Heidegger o Henri Bergson. Per facilitare la mia personale esposizione vorrei riprendere la classificazione del tempo del filosofo russo Nikolaj Berdjaev.
Categorie di tempo
Nel suo saggio Storia ed escatologia, Berdjaev individua tre categorie di tempo: il tempo cosmico, il tempostorico e il tempo esistenziale. Il tempo cosmico, che si può considerare come tempo fisico, è quello misurabile con il calendario o con l’orologio: un giorno ha ventiquattro ore, un anno trecentosessantacinque giorni e così via. È il tempo misurato in base ai movimenti regolari del sistema solare. Il tempo storico invece è quello a cui ci riferiamo quando usiamo espressioni come “il XX secolo”, “il 100 a.C.” o “il secondo millennio”, indicando periodi definiti nell’arco del tempo fisico. Esempi più familiari sono “oggi”, vagamente considerato come un’estensione dello ieri, e “domani”, inteso come un’estensione dell’oggi.
Secondo Berdjaev sia il tempo cosmico sia il tempo storico sono “tempi separati”. Possiamo accettare facilmente questo giudizio per quanto riguarda il tempo fisico, essendo un’entità puramente teorica, isolata e indipendente dal nostro coinvolgimento soggettivo. Ma perché definisce allo stesso modo il tempo storico?
In riferimento al tempo storico Berdjaev allude a un futuro che divora il presente trasformandolo in passato. Questa sua intuizione merita un’attenta analisi. Nel corso della nostra esistenza quotidiana, tendiamo a lasciare che il tempo scorra via, che il domani arrivi come una mera estensione dell’oggi senza alcuno sforzo da parte nostra. I giorni diventano così intervalli di inerzia e noi perdiamo di vista il fatto cruciale che un domani fecondo viene solo dopo un oggi ben vissuto.
Quello che Berdjaev chiama tempo esistenziale può essere sperimentato solo quando ci liberiamo dal tempo separato dell’inerzia quotidiana. Allora proviamo la gioia e il senso di pienezza che deriva dalla capacità di sfruttare l’attimo e di compiere la nostra innata missione di esseri umani.
Secondo Berdjaev, il tempo esistenziale è talmente profondo che non può essere espresso da nessun calcolo matematico. È un tempo extratemporale, un tempo eternamente presente. Un singolo istante di tempo esistenziale può avere più significato, più compiutezza e addirittura una maggiore durata soggettiva di periodi anche lunghi delle altre due categorie di tempo, in quanto si misura in base all’intensità della gioia o dell’angoscia sperimentate nei momenti in cui il tempo sembra essersi fermato. Si può percepire la realtà del tempo esistenziale nell’estasi della creazione o nel momento della propria morte.
Questo lampo abbagliante di illuminazione e rivelazione nel passaggio dal tempo cosmico o storico al tempo esistenziale extratemporale, riporta alla mente il romanzo di Tolstoj La morte di Ivan Ilic. Il protagonista del romanzo è un comune impiegato statale che conduce una vita ordinaria senza alcun vizio particolare, la cui autostima è alimentata dall’adempimento dei suoi doveri di impiegato e la cui vanità è gratificata dal frequentare la buona società. In seguito a un incidente contrae una malattia incurabile e nel corso di una strenua lotta contro la paura della morte scopre dentro di sé la luce dell’eternità e la vera felicità.8
Con consumata abilità Tolstoj descrive il salto drammatico dal tempo separato al tempo extratemporale. Ivan Ilic intravede la profondità del tempo esistenziale nell’istante della morte, esattamente come ipotizzato da Berdjaev.
Anche se le idee di Berdjaev e di Tolstoj si sono sviluppate in un contesto culturale di matrice cristiana, possono tuttavia gettare una luce importante sulla visione buddista del tempo e della storia. Nel suo trattato L’apertura degli occhi Nichiren cita un brano dal sutra Shinjikan (Sutra sulla contemplazione della mente): «Se vuoi conoscere le cause del passato, guarda gli effetti del presente; se vuoi conoscere gli effetti del futuro, guarda le cause del presente».9
Questo brano non si riferisce alla causalità del tempo cosmico, come quella che soggiace alla formazione dell’acqua dalla combinazione di idrogeno e ossigeno, e neppure alla causalità del tempo storico, esemplificata dalla supposta ineluttabilità del passaggio dal capitalismo al socialismo. Il Buddismo definisce simili progressioni lineari di causalità come non-simultaneità di causa ed effetto.
Di maggiore interesse per noi esseri umani sono invece gli effetti che si manifesteranno nel futuro. Questi sono determinati, più che da ogni altro fattore, dalle cause interiori che esistono nel momento presente, cioè dall’intensità della nostra convinzione a livello di quella che Berdjaev chiama la profondità del tempo esistenziale. Questo è un punto centrale nella visione buddista del tempo secondo la quale il momento presente è il fulcro e in un certo senso l’unica cosa che esiste, e si contrappone alla concezione storica del tempo secondo la quale il futuro divora il presente. Se si toglie il momento presente, il passato e il futuro diventano vuoti e illusori. La nostra attenzione deve essere concentrata su noi stessi nel momento presente. Le nostre azioni devono essere compiute con intensità, con la consapevolezza che la profondità della determinazione interiore è il fattore decisivo che dà vita al futuro e crea la storia. Questa visione del tempo e della causalità viene chiamata nel Buddismo simultaneità di causa ed effetto.
Ciò che Berdjaev descrive come tempo eternamente presente o tempo extratemporale riecheggia il concetto buddista del tempo che altrove ho descritto col termine “tempo vitale”.
Storicismo contro eternità
Il XIX e il XX secolo sono stati caratterizzati dallo storicismo dominante e la gente si è allontanata, in nome della scienza, dal tempo eternamente presente o tempo vitale. Nella ricerca ossessiva di una formula per l’utopia, lo storicismo degli ultimi due secoli si è consacrato al futuro che divora il presente, con tragici risultati. L’ex Unione Sovietica è stata il banco di prova per il pugno di ferro del bolscevismo, la manifestazione più raccapricciante dello storicismo. Sia l’ex presidente sovietico Michail Gorbaciov che lo scrittore kirghiso Chingiz Aitmatov mi hanno parlato di quei tempi con profonda angoscia.
Né la prospettiva del tempo fisico né quella del tempo storico sono adeguate per comprendere pienamente la fiducia di Nichiren che una condizione interiore di grande compassione sia la chiave per aiutare le persone a manifestare il loro autentico e meraviglioso potenziale nei prossimi diecimila anni e per tutta l’eternità.
Spesso sono le esperienze più amare che ci risvegliano alle verità spirituali più profonde. Anche il risveglio di Josei Toda mentre era in carcere deve essere compreso dal punto di vista del tempo esistenziale. Egli capì di avere partecipato, in un tempo eternamente presente, alla cerimonia in cui l’essenza degli insegnamenti del Budda, la Legge mistica contenuta nel Sutra del Loto, venne affidata alle persone comuni che, in quanto Bodhisattva della Terra, l’avrebbero condivisa con gli altri nell’Ultimo giorno della Legge. E capì che quella cerimonia allegorica continua eternamente.
Universalismo interiore e azione sociale
Non c’è contraddizione tra l’universalismo interiore e le azioni riformiste esterne di un cittadino del mondo. È di urgente necessità educare il maggior numero possibile di persone a diventare cittadini del mondo allo scopo di raggiungere una pace duratura. Il curriculum educativo deve includere le più importanti questioni con cui l’umanità è oggi alle prese: l’ambiente, lo sviluppo, la pace e i diritti umani. Ognuna di queste problematiche richiede il nuovo punto di vista di un cittadino del mondo, un punto di vista che oltrepassa i confini delle entità nazionali. I campi di studio citati devono essere strettamente collegati tra loro e orientati al raggiungimento della pace per l’umanità.
Suggerisco inoltre che venga stilata una Carta dei cittadini del mondo a fondamento dell’educazione alla pace dei cittadini del mondo. Benché la consapevolezza individuale di appartenere al mondo nella sua interezza stia cominciando a diffondersi, in tutto il pianeta imperversano ancora molti conflitti derivanti dai pregiudizi razziali o religiosi. Il preambolo della Carta dei cittadini del mondo dovrebbe affermare che le differenze tra i popoli di cultura, di religione e di lingua sono come le diversità delle specie vegetali tutte radicate nel suolo comune della Terra, che tutte le persone sulla Terra sono cittadine del mondo e che la pace e la felicità dell’umanità verranno perseguite secondo questa prospettiva universale.
Inutile dire che l’esistenza dei cittadini del mondo e l’indipendenza nazionale non si escludono reciprocamente. Nel mondo attuale è del tutto possibile approfondire la propria identità nazionale e culturale e contemporaneamente abbracciare con uno sguardo più ampio l’intero pianeta impegnandosi per il bene di tutta l’umanità.
Il Buddismo esige la partecipazione alla storia spirituale profonda del genere umano, cosa possibile solo attraverso grandi sofferenze e dure lotte, come suggerisce anche Berdjaev quando fa riferimento all’intensità della gioia o dell’angoscia sperimentate. È anche un messaggio inviato dalle profondità della storia a tutta la vita cosmica, la “convocazione degli eroi” che secondo Bergson si trova in una completa e perfetta moralità.10
Precedentemente ho sottolineato la necessità di cogliere il significato della storia analizzandola su una più ampia scala spaziale e temporale. Il motivo è che ci troviamo oggi a un punto di svolta senza precedenti nella storia dell’umanità. Per superare le numerose crisi che abbiamo davanti a noi, non solo dobbiamo affrontare i problemi più urgenti ma dobbiamo anche esplorare le profondità del tempo e della storia per attingere una visione del futuro più lungimirante che si estenda ai prossimi secoli, se non addirittura ai prossimi millenni.
Senza questa visione potremmo essere sopraffatti dalle numerose scoraggianti sfide del nostro tempo. Il coraggio e la speranza sono essenziali: non dobbiamo mai perdere queste vitali qualità umane. Ognuno di noi deve risvegliarsi alla propria missione individuale di protagonista della trasformazione della storia, e tutti dobbiamo unirci in una lotta comune dell’umanità per affrontare e risolvere i pressanti problemi che assillano il nostro pianeta.
NOTE
1) Conversazione personale con Gerald P. Carr.
2) U.N. Development Programme, Human Development Report, 1996;
http://www.undp.org/hdro/e96over.htm.
3) D.H. Lawrence, Apocalypse (London: William Heinemann Ltd., 1931), p. 104.
4) Cfr. Stefan Zweig, Die Welt von Gestern (Lincoln, NB: University of Nebraska Press, 1964), p. 329.
5) Cfr. Fëdor Dostoevskij, Complete Letters, vol. 5, 1878-1881, trad. a cura di David A. Lowe (Ann Arbor: Ardis Publishers, 1991).
6) Cfr. Nikolaj Berdjaev, The Russian Idea (New York: MacMillan Company, 1948), p. 249.
7) Gli scritti di Nichiren Daishonin, vol. 2, p. 216.
8) Cfr. Lev Tolstoj, The Death of Ivan Ilyich (New York: George Munro, 1888), p. 39.
9) Gli scritti di Nichiren Daishonin, vol. 2, p. 192.
10) Cfr. Henri Louis Bergson, Les Deux Sources de la Morale et de la Religion (Paris: Librairie Felix Alcan, 1932), p. 30.
Per il bene della pace. Sette sentieri verso l'armonia globale. Una prospettiva buddista - di Daisaku Ikeda
Capitolo 7° - Il sentiero del disarmo - AUDIO generato con un sintetizzatore vocale

Il disarmo nucleare, totale e incondizionato, non è un’utopia: la storia degli ultimi decenni dimostra che ci sono stati seri tentativi di raggiungere tale risultato da parte delle potenze mondiali. In quest’ultima puntata, che chiude la serie ripresa dal libro For the Sake of Peace – in italiano con il titolo Per il bene della pace, Esperia edizioni – Daisaku Ikeda afferma chiaramente che il disarmo totale dovrebbe essere l’obiettivo più importante di tutte le nazioni del mondo e di ogni persona consapevole, per evitare che il mondo si avvii verso la distruzione. Il tema del disarmo completo, fondamentale nella prospettiva della nonviolenza, è al centro della Proposta di pace 2004, di prossima pubblicazione
L’8 settembre 1957 Josei Toda, ripresosi momentaneamente dalla grave malattia che lo avrebbe portato alla morte, raccolse le forze rimastegli per appellarsi ai giovani, lanciando un eroico grido in difesa del diritto alla vita di tutti gli esseri umani: «Noi, i cittadini del mondo, abbiamo l’inviolabile diritto di vivere. Chiunque minacci tale diritto è un demone, un mostro. […] Anche se una nazione utilizzando le armi nucleari conquistasse il mondo, i conquistatori dovrebbero essere considerati diavoli, l’incarnazione del male. Credo che tutti i giovani giapponesi abbiano la missione di diffondere questa consapevolezza in tutto il pianeta».1
Come le sue parole rendono chiaro, Toda pensava che l’uso delle armi nucleari dovesse essere bandito incondizionatamente. Per realizzare la sua volontà ho sottolineato l’urgenza di compiere dei passi specifici verso l’adozione di un trattato che proibisca lo sviluppo, il possesso e l’uso delle armi nucleari. La dichiarazione di Toda è estranea a qualunque interesse ideologico o nazionale ed è superiore a qualunque tesi fondata su politiche di potere, come quelle della deterrenza nucleare o della guerra atomica limitata. Per questo motivo brillerà eternamente. Essa manifesta il suo ardente desiderio di garantire a ogni essere umano il fondamentale diritto di vivere in pace. Toda desiderava sinceramente che nessuno dovesse mai soffrire di nuovo a causa di una guerra e il suo sguardo lungimirante anticipava il concetto di sicurezza dell’umanità che sempre più persone invocano oggi. Ciò che voglio mettere in risalto è che la sua dichiarazione intendeva esortare le giovani generazioni a condurre una lotta senza compromessi contro il male contenuto nella vita umana, il nemico invisibile responsabile dell’esistenza delle armi nucleari.
Nel gennaio del 1956, l’anno prima della dichiarazione di Toda, John Foster Dulles, allora segretario di stato degli Stati Uniti, annunciò la “politica del rischio calcolato” che si basava sull’uso limitato delle armi. Nel maggio dello stesso anno, il Regno Unito effettuò esperimenti nucleari. Gli Stati Uniti sganciarono la loro prima bomba all’idrogeno sull’atollo di Bikini. Il disaccordo tra Stati Uniti e Unione Sovietica divenne sempre più palese quando, nell’ottobre del 1956, il presidente Dwight Eisenhower rispose all’appello del premier sovietico Nikolai Bulganin per un blocco degli esperimenti nucleari dichiarandolo un tentativo di interferire negli affari interni degli Stati Uniti. Nel maggio del 1957 l’Unione Sovietica effettuò a sua volta un esperimento nucleare. Il Regno Unito sperimentò la sua prima bomba all’idrogeno nell’isola di Christmas. Durante questo periodo gli Stati Uniti condussero una serie di analoghi esperimenti nel Nevada. Allo stesso tempo, tuttavia, il movimento antinucleare stava guadagnando forza. Il chimico e pacifista americano Linus Pauling raccolse le firme di duemila scienziati americani per un appello in favore della cessazione degli esperimenti nucleari. La Conferenza mondiale per la pace emanò l’Appello di Colombo, chiedendo l’immediata e incondizionata cessazione degli esperimenti nucleari. In agosto, l’Unione Sovietica annunciò la riuscita sperimentazione di un missile balistico intercontinentale (ICBM). In dicembre, gli Stati Uniti lanciarono con successo l’ICBM Titan. Con questi sviluppi, la corsa agli armamenti tra le due nazioni acquistò ulteriore impeto.
Su questo sfondo di crescenti tensioni tra il blocco orientale e quello occidentale, Josei Toda intuì che le armi nucleari minacciavano diabolicamente il diritto dell’umanità di continuare a esistere, e insistette sull’importanza di far giungere questo messaggio al mondo intero. Percepisco una profonda riflessione e una grande saggezza dietro la sua decisione di fare della sua dichiarazione contro le armi nucleari la sua più importante direttiva e il suo mandato finale ai giovani. Le armi nucleari sono il male assoluto, la loro distruttività è apocalittica, e perciò esse richiedono reazioni e modi di pensare diversi da quelli applicati alle armi convenzionali, alle quali esse non possono – non devono – essere equiparate.
È sorprendente che a quel tempo i poteri letali e distruttivi delle armi nucleari fossero considerati invece qualitativamente simili, per quanto quantitativamente superiori, a quelli delle armi convenzionali. A causa di ciò furono pochi quelli che prestarono ascolto al grido di Toda. Persino in Giappone, l’unica nazione al mondo ad aver subito un bombardamento atomico, i commenti sulla bomba all’idrogeno come bomba “pulita” e sull’importanza per la pace degli esperimenti nucleari erano correnti. Le persone come Albert Einstein, che disse che «il lancio della bomba atomica ha cambiato tutto tranne il nostro modo di pensare», erano in minoranza. La filosofia di Josei Toda aveva l’intrinseco potere di capovolgere tutti gli altri modi di pensare. Questo è il motivo per cui, benché altre teorie della pace basate su ideologie di destra o di sinistra non siano sopravvissute alla naturale selezione del tempo, la sua dichiarazione contro le armi nucleari si erge ancora luminosa e attuale.
Sulla natura della minaccia di estinzione posta in essere dalle armi nucleari, il giornalista americano Jonathan Schell arriva a dire: «L’estinzione è più terribile – è il nulla più radicale – perché l’estinzione mette fine alla morte proprio come indubitabilmente mette fine alla nascita e alla vita. La morte è solo morte; l’estinzione è la morte della morte».2
La micidiale e apocalittica natura delle armi nucleari fa nascere l’impressionante concetto di “morte della morte”. La terra desolata che un conflitto atomico globale lascerebbe dietro di sé sarebbe un luogo totalmente privo di significato, dove non esiste né la morte né nessun’altra cosa. Per impedire che accada una simile atrocità, dobbiamo perseverare nei nostri sforzi fin quando la filosofia di Toda non sia diventata lo spirito prevalente della nostra epoca.
Anche Bertrand Russell definì le armi nucleari il male assoluto, e io concordo pienamente con lui. Il male non sta solo nel loro enorme potere di causare distruzione e morte ma anche nella profonda sfiducia che emana dal loro possesso. Questa sfiducia ha creato il cosiddetto culto della deterrenza, la convinzione che le armi nucleari siano necessarie per proteggersi contro le armi nucleari. Ma più le persone hanno fiducia nelle armi, e meno si fidano l’una dell’altra. Cessare di riporre fiducia nelle armi è il solo modo per coltivare la reciproca fiducia tra i popoli.
La rinuncia alle armi nucleari
Alcuni potrebbero pensare che la rinuncia mondiale alla guerra sia un sogno impossibile, ma bisogna ricordare che appena un quarto di secolo fa i rappresentanti degli Stati Uniti e dell’Unione Sovietica parlarono seriamente alle Nazioni Unite della possibilità dell’eliminazione di tutte le armi. Nel 1959, nel suo discorso alla quattordicesima Assemblea generale delle Nazioni Unite, il premier sovietico Nikita Chrusciov propose l’eliminazione di tutte le armi. La proposta includeva un programma dettagliato per il disarmo generale e completo.
Nello stesso anno, la bozza congiunta di risoluzione delle ottantadue nazioni sul “disarmo generale e completo”, invocante il disarmo totale, fu adottata all’unanimità dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Nel 1961, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica raggiunsero un accordo sugli otto principi dei negoziati sul disarmo, ed entrambi i paesi riferirono all’Assemblea generale delle Nazioni Unite sui risultati dell’accordo. In settembre, il presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy tenne il suo primo discorso alle Nazioni Unite, presentando un nuovo piano per l’eliminazione delle armi, noto come il Programma per il disarmo generale e completo in un mondo pacifico.
Nel 1962 i due paesi sottoposero la bozza del trattato sul disarmo generale e completo alla Conferenza del comitato dei diciotto sul disarmo, di recente istituzione, i cui lavori furono centrati principalmente sulla discussione della bozza.
Ciò che di fatto seguì, tuttavia, fu l’intensificarsi della corsa agli armamenti tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Se il mondo vuole entrare in una nuova era di riduzione delle armi, dovrebbe esserci una nuova partenza basata sul ritorno allo spirito originale del disarmo.
Il disarmo è la volontà popolare
Un fattore incoraggiante è che la maggioranza dei cittadini è a favore dell’abolizione delle armi nucleari, persino all’interno degli stati nucleari come gli Stati Uniti o il Regno Unito e i loro alleati. Questo fatto è stato rilevato da un sondaggio d’opinione condotto dalle ONG tramite agenzie demoscopiche nei paesi partecipanti alla campagna Abolition 2000. Gli stati nucleari giustificano in parte il possesso di armamenti nucleari col sostegno della cittadinanza, ma i risultati di questa indagine smentiscono le loro asserzioni.
È stato messo in evidenza che sia gli stati nucleari sia quelli che aspirano a diventarlo cercano nelle armi nucleari non solo la sicurezza nazionale ma anche la conferma del proprio prestigio internazionale. Perciò, un punto di partenza per arrivare a un cambiamento è mettere in discussione questi punti di vista e la mentalità di potenza dalla quale questa definizione di prestigio deriva.
In questo senso, gli sforzi per cambiare alla base il modo di pensare degli individui vanno incontro esattamente alle richieste dei nostri tempi. Via via che queste campagne guadagneranno un sostegno sempre maggiore tra la gente comune, nascerà una nuova superpotenza fondata sulla fiducia e sulla solidarietà, che sostituirà le superpotenze dipendenti dagli arsenali nucleari e guidate dal culto della deterrenza.
L’obiettivo comune dell’attuazione di un trattato per la proibizione delle armi nucleari può essere raggiunto solamente tramite il rafforzamento della solidarietà dei cittadini.
Gli ostacoli a un tale trattato si fondano su illusioni sempre più evidenti. Se gli Stati Uniti e la Russia non sono più nemici, l’idea della deterrenza nucleare, che finora è stata la giustificazione dominante del dispiegamento delle armi nucleari, perde completamente di significato. Perciò, non c’è motivo di mantenere una riserva di migliaia di testate nucleari. Noi invitiamo questi due paesi a eliminare completamente i loro arsenali nucleari, perché questa azione avrebbe una grande importanza simbolica per la causa del disarmo mondiale. Se gli Stati Uniti e la Russia imboccassero questa direzione, cosa fino ad ora ritenuta impossibile, fornirebbero sicuramente un grande impulso al processo del disarmo mondiale e spianerebbero il sentiero per la convocazione di conferenze internazionali, con la partecipazione delle altre potenze nucleari, mirate alla totale eliminazione degli armamenti nucleari in tutto il pianeta.
Per di più, il problema degli armamenti nucleari non è confinato agli Stati Uniti e alla Russia. Ci troviamo di fronte anche al serio problema di come prevenire la proliferazione nucleare mondiale. È mia convinzione che sia necessaria una nuova organizzazione internazionale per affrontare integralmente il problema sempre più complesso delle armi nucleari.
Una giustificazione del mantenimento degli arsenali nucleari è la tensione tra le due Coree. La pace nel Nordest asiatico è sempre stata una mia sincera speranza alla luce del potenziale che la regione possiede. Sono motivato anche dal profondo rammarico per le grandi sofferenze che la guerra di aggressione giapponese ha causato in tutta la regione. Negli ultimi anni, le relazioni sono costantemente migliorate in direzione del superamento di cinquant’anni di contrasti e della creazione della pace. Per arrivare a queste mete è essenziale coltivare la fiducia in tutta la regione. In questa prospettiva, nella mia proposta alle Nazioni Unite del 1997 ho invocato la creazione di una zona denuclearizzata nel Nordest asiatico, e in quella del 1999 ho proposto l’istituzione di una Comunità per la pace del Nordest asiatico che includa le due Coree e i paesi confinanti.
Il programma di sviluppo nucleare della Corea del Nord è stato lo scoglio maggiore al miglioramento delle relazioni. Sebbene sulla questione sia stato raggiunto un accordo tra Washington e Pyöngyang, nel Congresso degli Stati Uniti è emersa una forte opposizione a quell’accordo, e il cammino della distensione incontrerà ancora molti ostacoli.
Ciononostante, l’importanza degli accordi raggiunti attraverso il dialogo tra le due Coree e tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti non deve essere sottovalutata.
È importante non farsi influenzare emotivamente dall’andamento del processo del dialogo e non cadere nel pessimismo quando l’attuazione degli accordi va a rilento. Un futuro pacifico può essere creato solo gradualmente, grazie ai risultati conseguiti l’uno dopo l’altro nel corso di molti colloqui e alla lenta ma continua attuazione di ogni accordo.
“L’abbandono delle armi da fuoco”

Un altro falso presupposto molto diffuso è che l’umanità non ha mai rinunciato alle armi tecnologicamente “superiori” e che perciò il disarmo nucleare è impossibile. Ma nel suo L’abbandono delle armi da fuoco: il ritorno del Giappone alla spada, 1543-1879, il professor Noel Perrin, del Dartmouth College, fa delle osservazioni molto stimolanti a questo proposito.
Durante i cinquant’anni tra la fine del XVI secolo e l’inizio del XVII, dopo la vittoria del famoso signore della guerra Oda Nobunaga nella battaglia di Nagashino del 1575, l’uso delle armi da fuoco in Giappone era al suo apice, sia dal punto di vista della qualità tecnologica sia da quello della quantità. In quell’epoca le armi da fuoco erano certamente più comuni in Giappone che in qualunque altra parte del mondo. Tuttavia, nei secoli successivi, nel corso dell’intero periodo Tokugawa (1603-1867), la classe guerriera «scelse di abbandonare le armi moderne e di ritornare a quelle più primitive», a dispetto della maggiore efficacia delle prime.3 Vale a dire che i guerrieri giapponesi rifiutarono il fucile e tornarono alla spada. Da quel momento in poi, la quantità e la qualità delle armi da fuoco usate in Giappone si ridussero notevolmente.
Il professor Perrin propone un certo numero di spiegazioni di questa inversione. Una di quelle che colpiscono di più è la natura della spada come simbolo dello spirito umano e della moralità. In altre parole, i giapponesi basarono la loro scelta delle armi su ciò che potrebbe essere definita una pura consapevolezza estetica interiore. Come conseguenza, Edo (l’attuale Tokyo), che all’epoca era la città più popolata del mondo, gradualmente e pacificamente sviluppò un alto livello tecnologico nei sistemi idrici, fognari e di viabilità, mentre le fabbriche di armi da fuoco passavano da una produzione controllata a un’attività talmente ridotta che nella metà del XIX secolo la maggior parte delle persone avevano totalmente dimenticato l’uso delle armi da fuoco.
Dicendo che «i giapponesi praticarono un controllo selettivo»4, Perrin sviluppa due insegnamenti impliciti nell’esperienza giapponese: «Primo, un’economia a crescita zero è perfettamente compatibile con una vita prospera e civile. Secondo, gli esseri umani non sono necessariamente vittime passive della loro conoscenza e tecnologia come la maggior parte degli occidentali sembra supporre».5
Il secondo punto in particolar modo incoraggia la promozione degli attuali negoziati sul disarmo. Ovviamente, non si può certo tracciare una precisa corrispondenza tra la questione delle armi nucleari che il mondo ha oggi di fronte e le condizioni geopolitiche che permisero allo shogunato Tokugawa di adottare una politica di isolamento e di mantenere un controllo relativamente pacifico sul Giappone dal XVII al XIX secolo. Nondimeno, scegliendo sulla base di motivazioni interiori e spontanee generate da considerazioni morali ed estetiche, anziché per mero calcolo dell’efficienza delle diverse armi, il popolo giapponese di quell’epoca fu in grado di abolire virtualmente le armi da fuoco. Questo fatto sferra un duro colpo alla moderna opinione, passiva e pessimistica, che quel che è fatto è fatto e non si può tornare indietro.
Il disarmo in corso
Nella nostra era il disarmo è già cominciato. Alla fine del 1995 ho avuto occasione di incontrare per la seconda volta Oscar Arias Sanchez, ex presidente del Costa Rica e premio Nobel per la pace. Durante uno scambio di opinioni sui temi della guerra e della pace, Arias Sanchez ha sottolineato che le spese militari dovrebbero essere tagliate e i fondi così risparmiati spesi invece per promuovere l’educazione e la cultura. In realtà, il suo ideale è l’eliminazione delle armi in tutto il mondo.
Dopo la seconda guerra mondiale, per ricostruire l’Europa fu promosso il Piano Marshall. Arias Sanchez sostiene che un nuovo Piano Marshall mondiale sia ora necessario affinché quelle risorse possano essere investite nello sviluppo umano anziché negli armamenti. Benché un simile discorso potrebbe essere facilmente scartato come mero idealismo, le asserzioni di Arias Sanchez sono convincenti in quanto la Costituzione del Costa Rica, adottata nel 1949, è di fatto riuscita ad abolire le forze armate di quella nazione.
Alcuni potrebbero dire che questo risultato è stato possibile solo perché il Costa Rica è un paese piccolo. Nondimeno, l’eliminazione degli armamenti su una scala più ampia non è del tutto impossibile, come è dimostrato dall’abolizione della schiavitù, dell’apartheid e di altre istituzioni inumane quando le persone sono finalmente arrivate a riconoscerne l’inutilità e la dannosità.
Seguendo le esortazioni di Arias Sanchez, un paese limitrofo del Costa Rica, il Panama, nell’ottobre del 1994 ha modificato la propria costituzione per eliminare il fondamento legislativo dell’esistenza delle sue forze armate. Anche Haiti, benché debba superare ancora molti problemi, ha cominciato a smantellare l’esercito e a muoversi in direzione dell’abolizione delle forze armate.
A livello mondiale, però, finora ci sono stati pochi progressi verso l’attuazione del disarmo nucleare. Più di dieci anni sono passati dalla fine della guerra fredda, ma sul nostro pianeta esistono ancora più di trentamila testate nucleari. Non è stato fatto alcun passo avanti né verso la ratifica del Trattato di riduzione delle armi strategiche russo-americano né verso la riduzione di altri tipi di armi nucleari. Dopo la proroga indefinita del Trattato di non proliferazione nucleare del 1995, l’unico progresso è stato la decisione della Conferenza sul disarmo di Ginevra dell’agosto del 1998 di iniziare a negoziare un trattato per il blocco della produzione di materiali fissili destinati alla produzione di armi nucleari.
Nel maggio del 1998, l’India e il Pakistan hanno sconvolto la comunità internazionale effettuando test nucleari che hanno evidenziato la loro decisione di sviluppare il proprio arsenale nucleare. In questo modo hanno minato le fondamenta del sistema basato sul Trattato per il bando totale dei test nucleari e sul Trattato di non proliferazione nucleare. Il fallimento della comunità internazionale nel convincere India e Pakistan a rinunciare ai test nucleari ha messo in luce i limiti della dottrina della deterrenza unilaterale che può essere applicata solo dagli stati nucleari. Esiste ora l’evidente pericolo che altri paesi si affrettino a dotarsi di armi nucleari.
Recentemente gli Stati Uniti hanno annunciato l’intenzione di usare una centrale atomica civile per produrre trizio a scopo militare. Il trizio è uno dei materiali usati nelle testate nucleari. Con questa mossa gli Stati Uniti hanno abbandonato la precedente linea di condotta che prevedeva una ferrea separazione fra gli usi civili e gli usi militari dell’energia atomica. Bisogna dire che ciò dimostra l’arroganza delle nazioni nucleari e rende sospetta la sincerità della retorica americana sul disarmo.
Iniziative di denuclearizzazione
In questo scenario, nel giugno del 1998 otto stati non nucleari Brasile, Egitto, Irlanda, Messico, Nuova Zelanda, Slovenia, Sud Africa e Svezia hanno stilato una dichiarazione congiunta che invita le cinque potenze nucleari e i paesi in grado di sviluppare armamenti nucleari, come India, Pakistan e Israele, ad adottare misure per il disarmo e la non proliferazione. Inoltre hanno sottoposto all’Assemblea generale delle Nazioni Unite una bozza di risoluzione intitolata Verso un mondo senza armamenti nucleari: una nuova agenda. Adottata nel 1998, questa risoluzione possiede una concretezza superiore a qualunque altra precedente risoluzione delle Nazioni Unite. Per esempio, sottolinea la responsabilità delle potenze nucleari nel disarmo e chiede di eliminare tutte le armi nucleari non strategiche, di elevare la soglia di allarme bellico e di impegnarsi ufficialmente a non ricorrere per primi alle armi nucleari.
Gli otto paesi, spesso chiamati Coalizione nuova agenda, hanno rinunciato al possesso di armi nucleari e all’ombrello difensivo delle potenze nucleari. Per questa ragione, il loro programma ha ottenuto il sostegno di molte altre nazioni non nucleari. In particolare, la Svezia, il Brasile e il Sud Africa hanno di fatto abbandonato il loro programma di sviluppo di armi nucleari. La proposta della coalizione si basa su una valutazione realistica, espressa dalle parole dell’ex presidente brasiliano Fernando Henrique Cardoso: «Non vogliamo la bomba atomica. Essa genera solo tensione e sfiducia e annullerebbe il processo di integrazione della nostra regione che stiamo permanentemente rafforzando per il benessere del nostro popolo».
Zone denuclearizzate sono state costituite nell’America Latina, nel Pacifico meridionale, in Africa e nel Sudest asiatico. Ciò dimostra che un crescente numero di aree geografiche sta rinunciando a basare la propria sicurezza sugli armamenti nucleari.
Trattato per il bando totale dei test nucleari
Come abbiamo visto, la comunità internazionale si sta muovendo, gradualmente e con molta lentezza, in direzione del disarmo. Un passo importante è stato la firma del Trattato per il bando totale dei test nucleari (CTBT). Nonostante nel settembre del 1996 il CTBT sia stato adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con una maggioranza schiacciante, non è ancora stata fissata una data precisa per la sua attuazione. Per la sua entrata in vigore è necessaria la ratifica delle quarantaquattro nazioni dotate o in grado di dotarsi di armi nucleari. Ma a tutto il 2000 solo ventisei nazioni hanno ratificato il trattato. Dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza – tutte potenze nucleari – solo il Regno Unito e la Francia lo hanno fatto. Non lo hanno ratificato invece né l’India e il Pakistan, che hanno condotto entrambi test nucleari nel 1998, né la Corea del Nord. Ma ciò che più di tutto impedisce al CTBT di entrare in vigore è la bocciatura del decreto di ratifica da parte del senato degli Stati Uniti nell’ottobre del 1999.
Nel 1999 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che raccomanda la ratifica del trattato, ma l’entrata in vigore del trattato sembra quasi impossibile, a meno che l’opinione pubblica mondiale non insorga a favore della ratifica.
In questo senso, è importante fare ulteriori passi versi il disarmo, particolarmente costruendo tra le nazioni nucleari il consenso verso un impegno consapevole al disarmo. Un obiettivo a breve termine deve essere la firma di un trattato che proibisca la produzione di materiale radioattivo utilizzabile nella fabbricazione di armi nucleari. Come premessa fondamentale al disarmo nucleare è indispensabile un accordo per prevenire l’ulteriore proliferazione delle armi nucleari.
È anche necessario creare un clima internazionale che consenta la riduzione delle armi nucleari. I negoziati tra Stati Uniti e Russia relativi al Trattato di riduzione delle armi strategiche (START) si sono arenati a causa della riluttanza della Russia a ratificare lo START II. Esorto entrambe le nazioni a superare lo stallo nei negoziati così da poter attuare il trattato. Subito dopo, devono procedere con i negoziati per lo START III per gettare le fondamenta della fase successiva del disarmo, che deve vedere coinvolte nei negoziati tutte le potenze nucleari, comprese il Regno Unito, la Francia e la Cina.
Le chiavi per il disarmo: la fiducia e il dialogo
Al punto in cui siamo dovremmo chiederci quale sia l’ostacolo che impedisce il disarmo immediato. La risposta è che l’unico vero ostacolo è la sfiducia. George Kennan, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Unione Sovietica e famoso polemista sul tema del disarmo, considera questa sfiducia un’idea fissa costituita da un certo numero di elementi. «Si tratta di una specie di idea fissa formata da molte componenti. Ci sono paure, risentimenti, orgoglio nazionale e orgoglio personale. Ci sono interpretazioni distorte delle intenzioni dell’avversario e talvolta addirittura il totale rifiuto di considerarlo. C’è la tendenza delle comunità nazionali a idealizzare se stesse e a disumanizzare gli avversari. C’è la cieca e ristretta prospettiva dei militari di professione, e la loro tendenza a rendere la guerra inevitabile presupponendone l’inevitabilità».6 Essere ossessionati da questo genere di idea fissa è una cosa orrenda.
Lo scambio di opinioni tra i leader delle varie nazioni è il modo migliore per eliminare la sfiducia profondamente radicata esistente tra esse. In una visione a lungo termine, il superamento di questa sfiducia può costituire la causa indiretta per arrivare al disarmo e diventare così la chiave della pace mondiale.
Indubbiamente la strada verso il disarmo è lunga e impervia, e gli insuccessi dei precedenti negoziati non ispirano certo un facile ottimismo. Nondimeno, la strada deve essere percorsa. Gli uomini hanno costruito le armi nucleari con le proprie mani, e con le proprie mani sono dunque in grado di ridurle ed eliminarle. Se restiamo inattivi e manchiamo di farlo, non solo deruberemo le future generazioni dei loro sogni ma, cosa ancor più terribile, data la capacità di distruzione totale delle armi attualmente esistenti, toglieremo loro la stessa possibilità di esistere.
Il potere della gente
È venuto il momento che la gente comune, martoriata dalla guerra e dalla violenza nel XX secolo, assuma il ruolo di protagonista della storia. Deve prendere l’iniziativa di costruire un nuovo ordine fondato sulla simbiosi. Unendosi in un’alleanza che travalichi i confini nazionali, la gente può costruire un mondo senza guerre e fare del terzo millennio un’epoca di brillante speranza.
In effetti, le voci a sostegno di un mondo senza armi nucleari sono ormai così forti che le nazioni nucleari devono ascoltarle, non possono permettersi ancora a lungo di agire solo in base ai propri interessi.
Come buddista, mi sento obbligato a mettere in evidenza le implicazioni più profonde delle armi nucleari e della necessità della loro eliminazione. La posta in gioco non è soltanto il disarmo, ma il superamento sostanziale dell’eredità più negativa del XX secolo: la sfiducia, l’odio e la degradazione dell’umanità, che sono il risultato finale di una barbara lotta egemonica tra le nazioni. Questo superamento richiede che venga affrontata apertamente l’illimitata capacità del cuore umano di generare sia il bene sia il male, di creare e di distruggere.
Le proposte finalizzate all’abolizione delle armi nucleari che ho presentato alla prima, alla seconda e alla terza sessione speciale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sul disarmo rappresentano le mie speranze di uomo di religione ed esprimono il mio desiderio, come leader della SGI, di proteggere e sostenere le Nazioni Unite.7
La questione dell’abolizione delle armi nucleari va al di là della loro eliminazione fisica. Anche se tutti gli arsenali nucleari fossero distrutti, resterebbe il grave fatto che l’uomo ha ormai acquisito le conoscenze necessarie alla produzione di armi nucleari. È per questo motivo che io affermo che l’unica soluzione reale al problema degli armamenti nucleari sia una lotta incessante contro il male inerente alla vita che minaccia la sopravvivenza dell’umanità. Ed è con questo in mente che Josei Toda affidò ai giovani il compito di diffondere l’idea della dignità di tutti gli esseri viventi come etica dominante del nostro tempo.
Porre fine al commercio delle armi

Congelare gli armamenti nucleari all’attuale livello è insufficiente a garantire una pace duratura. È essenziale anche raggiungere un consenso internazionale che imponga limiti massimi a tutte le spese militari, incluse quelle per le armi convenzionali. In ultima analisi, per garantire la sicurezza dell’umanità non può bastare nulla di meno della rinuncia mondiale alla guerra. A questo fine, un importante fattore necessario per la deistituzionalizzazione della guerra è la riduzione del commercio internazionale delle armi convenzionali.
Il commercio delle armi incrementa l’insorgere di conflitti e ne prolunga la durata. Ben lungi dal diminuire, questo commercio aumenta di anno in anno. Secondo il Bilancio militare 1998/99, il rapporto annuale dell’Istituto internazionale di studi strategici, nel corso del 1997 le transazioni di armi erano aumentate del 12%. Il maggior incremento riguardava il Medio Oriente e l’Asia orientale. Il giro d’affari relativo al commercio di armi nel 1997 assommava a un totale di 34,6 miliardi di dollari. Altre ricerche confermano che le zone in cui sono in corso conflitti regionali continuano a essere il principale mercato di esportazione per i trafficanti di armi. In Africa, teatro di numerosi conflitti regionali e interni, esiste addirittura un fiorente mercato di armi di seconda mano.
Nel suo rapporto dell’aprile del 1998, Le cause di conflitto e la promozione di una pace durevole e di uno sviluppo sostenibile in Africa, il segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan espresse grave preoccupazione sulla questione, chiedendo ai governi degli stati membri di adottare leggi nazionali che configurino come reato penale la violazione di un embargo di armi stabilito dal Consiglio di sicurezza. Inoltre ha chiesto al Consiglio di sicurezza di fare luce sulle operazioni occulte dei trafficanti internazionali di armi: «Ricavare profitto dalla guerra e dalle carneficine in altri paesi, usarle per accrescere il proprio prestigio e l’influenza del proprio paese, sacrificare spietatamente vite umane per il proprio utile personale … Il commerciò di armi è un male. È un attacco omicida e moralmente imperdonabile all’umanità e alla sua sicurezza. Rappresenta il peggio di cui l’essere umano è capace.
Quando uno stato rafforza la propria potenza militare all’interno di una determinata regione attraverso l’importazione di armi, le tensioni regionali e l’instabilità si acuiscono, perché i paesi confinanti sono a loro volta spinti ad acquistare nuovi armamenti. Allo stesso modo, l’aumento della fornitura di armi alle fazioni coinvolte in un conflitto interno non fa che prolungare e inasprire quel conflitto.» 8
Per rompere questo circolo vizioso occorre agire su due fronti. Il primo passo è quello di ridurre la domanda tramite gli sforzi per disinnescare il sospetto e costruire la fiducia reciproca, il secondo è il blocco dell’offerta di armi nelle aree di conflitto.
Attualmente circa la metà degli stati membri delle Nazioni Unite annota le transazioni di armi nel registro delle armi convenzionali istituito dalle Nazioni Unite nel 1992. È significativo che, sebbene non sia obbligatorio, i principali esportatori di armi, cioè i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza più la Germania, presentino regolari rapporti. Dato che questi sei paesi coprono più dell’85% del totale del commercio di armi, le informazioni da loro fornite offrono un quadro adeguato della situazione generale. Per aumentare la trasparenza, propongo di negoziare un trattato che allarghi questo sistema includendo altri tipi di armi e renda obbligatorio per tutti gli stati membri un rapporto sulle transazioni effettuate. Se applicato, un simile trattato potrebbe promuovere la stabilità mondiale generando fiducia tra gli stati membri e fornendo un sistema di allarme preventivo in caso di improvvise concentrazioni di armamenti.
Ho altre due proposte per frenare il commercio delle armi. Dobbiamo in primo luogo limitare le transazioni illegali. Come si legge nel rapporto del segretario generale Kofi Annan, chiunque fornisca armi o aiuti segreti a una parte in conflitto, specialmente se viola un embargo del Consiglio di sicurezza, dovrebbe essere severamente punito dalle leggi del suo paese. È necessario anche ottenere il consenso della comunità internazionale per includere il reato di traffico illegale di armi tra le competenze del Tribunale penale internazionale.
In secondo luogo, le principali nazioni esportatrici di armi dovrebbero decidere di regolamentarne e limitarne il commercio.
Molte armi, che di fatto sono servite a esacerbare i conflitti regionali, sono state vendute da nazioni con un seggio permanente nel Consiglio di sicurezza. È ormai necessario imporre restrizioni al commercio internazionale di armi e fare uno sforzo maggiore verso il disarmo. Dopo la Guerra del Golfo del 1991, i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza avevano avviato delle trattative in questa direzione, che in seguito si sono interrotte. Per riaprire la questione propongo di indire una riunione del G9 (i paesi del G8 più la Cina) su questi temi. Il G9 sarebbe a mio parere la sede adeguata perché includerebbe la Germania, uno dei principali esportatori di armi, e perché darebbe al Giappone e al Canada la possibilità di svolgere un ruolo di mediazione.
La comunità internazionale ha già adottato trattati e convenzioni che mettono al bando sia le armi di distruzione di massa, come le armi chimiche e quelle batteriologiche, sia le mine antiuomo. A tutt’oggi però non esiste alcun programma internazionale di disarmo che limiti da una parte le armi leggere, come i fucili automatici e l’artiglieria di piccolo calibro, e dall’altra gli armamenti nucleari. In questo campo sono stati fatti solo pochi progressi. Nel dicembre del 1998 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che indica entro il 2001 una conferenza internazionale per limitare la disponibilità delle armi leggere. La Convenzione sulle armi chimiche, che era stata firmata nel 1993, è finalmente entrata in vigore nell’aprile del 1997. Questa convenzione può essere considerata come un vero trattato di disarmo in quanto non solo sancisce la distruzione di tutte le armi chimiche esistenti, comprese quelle obsolete o abbandonate nei territori di altri paesi, ma impone anche la demolizione degli impianti per la loro produzione al fine di impedirne anche in futuro la fabbricazione.
L’aspetto importante di questo trattato è che esso impone gli stessi vincoli a tutte le nazioni firmatarie, a differenza del Trattato di non proliferazione nucleare che introduceva delle disparità. Inoltre, al fine di prevenire violazioni, il trattato contempla anche un sistema di ispezioni delle installazioni industriali e prevede anche la possibilità di ispezioni senza preavviso qualora ne venga fatta richiesta. Queste caratteristiche lo rendono un modello ottimale per i futuri trattati di disarmo.
L’efficacia del trattato dipenderà tuttavia dall’atteggiamento dei venti paesi che possiedono o sono ritenuti in possesso di armi chimiche. In modo particolare, la comunità internazionale deve unirsi per convincere quei paesi che, pur possedendo la maggior parte delle armi chimiche esistenti, non hanno ancora ratificato il trattato a firmarlo il più presto possibile.
Credo che il successo di questo trattato, con il suo sistema di verifica altamente attendibile e a largo raggio, sia un’importantissima pietra miliare nel cammino verso il disarmo. Se ogni nazione firmataria osserverà scrupolosamente i termini del trattato e se, grazie alla trasparenza ottenuta tramite le procedure di verifica, verrà restaurata la fiducia, il numero delle nazioni firmatarie aumenterà e il trattato diventerà una efficace istituzione internazionale. Credo che un pieno successo anche solo nell’ambito delle armi chimiche avrà grandi ripercussioni anche su altri settori in cui esiste il consenso ma la ricaduta concreta è ancora minima, come nel caso della Convenzione sulle armi batteriologiche che è entrata in vigore nel 1975 ma la cui efficacia è stata drasticamente ridotta per la mancanza di clausole relative alle ispezioni e alle verifiche.
Un esempio analogo è il proposto trattato per la limitazione dell’uso delle mine antiuomo che ha fatto qualche passo avanti nel 1996. Secondo gli studi della Croce Rossa internazionale, in seguito allo scoppio delle mine antiuomo muoiono ogni mese ottocento persone e innumerevoli altre restano ferite gravemente. La maggioranza delle vittime sono civili, soprattutto bambini. Si calcola che nelle varie parti del mondo siano disseminate attualmente cento milioni di mine inesplose, la cui minaccia resta ancora a lungo dopo la fine degli orrori di una guerra. Chiedo con forza che la comunità internazionale si adoperi con la massima urgenza per l’abolizione totale delle mine antiuomo, che ogni giorno mettono a repentaglio l’integrità fisica e la vita stessa di persone innocenti.
Porre fine alla povertà: i dividendi della pace
Il taglio alle spese sulle armi convenzionali permetterebbe anche di fare dei passi avanti verso il raggiungimento di un altro obiettivo necessario per realizzare un mondo senza guerre: lo sradicamento della povertà. La povertà è una delle principali cause di conflitto, in quanto destabilizza la società. La povertà dà origine al conflitto, che a sua volta aggrava ulteriormente la povertà. Spezzare questo circolo vizioso porterebbe simultaneamente all’eliminazione di una delle cause di guerra e alla soluzione di un’ingiustizia globale. La rimozione delle cause di guerra e di povertà che minacciano la dignità umana incrementerà il godimento dei diritti umani.
Come ho affermato prima, è mia convinzione che sia necessario un cambiamento verso un nuovo concetto di sicurezza dell’umanità, che sia centrato non sulla sicurezza degli stati ma sul benessere della gente. Arnold Toynbee una volta osservò che il modo per determinare se l’assistenza è diretta verso corretti obiettivi a lungo termine è accertare se essa sia progettata per collegare l’assistenza materiale all’assistenza spirituale. Come suggerisce Toynbee, l’assistenza fino ad ora ha avuto la tendenza a focalizzarsi solo sullo sviluppo macroeconomico del paese beneficiario.
Il termine sviluppo ha connotazioni fortemente utilitaristiche. In contrasto, l’espressione sviluppo umano abbraccia una struttura concettuale più ampia che include l’elemento dell’impegno individuale e mira a far emergere le capacità illimitate dei cittadini. Con al centro le Nazioni Unite, dobbiamo sforzarci di creare un ambiente che incoraggi e nutra le potenzialità interiori di ogni individuo, dal momento che esse costituiscono una risorsa che è contemporaneamente “rinnovabile e accrescibile”.
Così facendo, renderemo possibile bloccare i conflitti armati prima che comincino e prevenire la micidiale spirale della violenza che porta al degrado dell’umanità. Sono convinto che il problema insolubile dello sradicamento della povertà vada affrontato direttamente, come primo passo verso la correzione delle distorsioni e dello squilibrio che attualmente affliggono la società mondiale.
L’aumento della spesa militare fu usato come strategia per ridurre la disoccupazione e stimolare l’economia durante la tragedia della grande depressione degli anni Trenta. Si pensa che l’espansione della spesa militare nel corso della seconda guerra mondiale sia stata uno dei fattori che hanno permesso agli Stati Uniti di superare quel periodo di crisi. Ma l’incremento della militarizzazione di una nazione genera sempre una reazione a catena che spinge le altre nazioni a fare altrettanto e questo a sua volta, come sappiamo fin troppo bene, può portare a conflitti territoriali e persino alla guerra mondiale.
Il mito che l’aumento della spesa militare abbia l’effetto positivo di stimolare l’economia persiste tuttora. Com’è noto, la guerra del Vietnam ebbe una grande escalation in un periodo in cui l’economia interna degli Stati Uniti attraversava una fase di recessione. Ma, secondo gli esperti, la conseguente spesa militare non fece che deprimere ulteriormente l’economia americana e fu la causa di un deficit fiscale. Autorevoli organizzazioni di ricerca hanno dimostrato che l’aumento della spesa militare ostacola una crescita sana dell’economia mondiale.
Giustizia mondiale
Un ulteriore prerequisito per il disarmo universale è un sistema internazionale di giustizia. Nonostante da lungo tempo si invochi la creazione di una corte permanente abilitata a processare coloro che hanno violato le leggi internazionali contro il genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità, nessun organo di questo genere è ancora stato stabilito. In seguito alla diffusa sensazione che la risposta della comunità internazionale agli eccidi nell’ex Yugoslavia, nel Ruanda e in altre regioni fosse vergognosamente inadeguata, nel giugno del 1998 fu tenuta a Roma una conferenza internazionale per proporre la creazione di un tribunale penale internazionale.
Questo tribunale è stato pensato come un organo giudiziario che non solo dovrebbe giudicare gli individui responsabili di crimini contro le leggi umanitarie internazionali e di gravi violazioni dei diritti umani, ma avrebbe anche il potere di garantire un risarcimento legale alle vittime di tali crimini. Non vedo l’ora che questo organismo diventi operativo e divenga il fulcro di un programma di elaborazione e di miglioramento del diritto internazionale.
Le questioni umanitarie non possono essere circoscritte nei confini di un unico paese. Finalmente sta emergendo la consapevolezza che esse devono essere affrontate con uno sforzo internazionale coordinato. I tentativi di creare un nuovo sistema capace di rispondere efficacemente a questo bisogno sono stati visti dagli stati come tentativi di limitare e ridimensionare le prerogative della sovranità nazionale cosa che in qualche misura inevitabilmente sono e ciò ha suscitato una forte resistenza all’idea di un tribunale penale internazionale.
Il ruolo delle ONG
La saggezza e l’energia dei cittadini comuni sono assolutamente necessarie per la creazione di un futuro migliore. Le ONG svolgono un ruolo inestimabile a questo riguardo, in quanto offrono ai cittadini la possibilità di esprimere la propria opinione e di concentrare il proprio impegno su obiettivi concreti.
Negli ultimi anni le ONG hanno allargato il loro raggio d’azione riuscendo a mobilitare le energie dei cittadini non solo in quei settori che tradizionalmente sono di loro pertinenza, come quello dei diritti umani o delle emergenze umanitarie, ma anche in ambiti collegati ai temi della sicurezza dell’umanità, come il disarmo, che finora erano rimasti di esclusiva competenza degli stati.
Tra i risultati ottenuti va annoverato il Progetto per il tribunale mondiale, che nel giugno del 1997 ha ottenuto dalla Corte internazionale di giustizia la revisione della legittimità dell’uso delle armi nucleari. Anche la Campagna internazionale per il bando delle mine antiuomo ha avuto una notevole influenza nel processo che ha portato alla stesura e all’adozione, nel settembre del 1997, della Convenzione sulle mine antiuomo. Queste iniziative danno fiducia e speranza a tutti coloro che amano la pace.
La responsabilità di abolire le armi nucleari e di costruire un mondo senza guerre sta nelle mani di ogni individuo. Dobbiamo esserne convinti e dare il nostro contributo a questo fine. Bisogna incoraggiare la concertazione degli sforzi popolari. Sono i cittadini di tutto il mondo a dover formulare e attuare progetti concreti per costruire un mondo migliore, individuando alternative verso la pace sulla base degli interessi dell’umanità. Espandere la solidarietà popolare in tutto il mondo è il solo sentiero percorribile verso la costruzione di un mondo libero dalle armi nucleari e non più minacciato dalla spada di Damocle di una guerra atomica.
La profondità e la complessità dei problemi che l’umanità deve affrontare sono sicuramente scoraggianti, ma per quanto possa essere arduo capire da dove cominciare o cosa fare, non dobbiamo mai cadere nel cinismo o nella paralisi. Ognuno di noi deve prendere l’iniziativa e agire nella direzione che ritiene giusta. Dobbiamo resistere alla tentazione di adattarci passivamente alle attuali circostanze e intraprendere invece la sfida di creare una nuova realtà. Oltre agli sforzi nella sfera pubblica, è altrettanto vitale creare in modi concreti e tangibili una cultura di pace nella vita quotidiana. La pace non è qualcosa che possiamo lasciare ad altri in luoghi distanti, ma è qualcosa che dobbiamo creare giorno per giorno coltivando l’impegno e la considerazione per gli altri e forgiando legami di amicizia e fiducia nelle nostre rispettive comunità attraverso le nostre azioni e il nostro esempio.
Accrescendo il rispetto per la santità della vita e la dignità umana per mezzo del nostro comportamento quotidiano e di un costante impegno nel dialogo, le fondamenta di una cultura della pace si approfondiranno e si rafforzeranno, permettendo a una nuova civiltà mondiale di fiorire. Se ogni singolo individuo si impegnerà con consapevolezza in questa impresa, saremo in grado di impedire che la società ricada in una cultura della guerra e di sviluppare energia incanalandola verso la creazione di un secolo di pace.
Lo spirito umano è dotato della capacità di trasformare anche le situazioni più difficili, creando valore e producendo significati sempre più ricchi. Quando ogni persona porterà a piena fioritura la propria illimitata potenzialità spirituale, e quando i cittadini comuni si uniranno nell’impegno di generare un cambiamento positivo, nascerà una cultura della pace, un secolo della vita.
NOTE
1) Josei Toda, Toda Josei Zenshu, vol. 4 (Tokyo: Seikyo Shimbunsha, 1984), pp. 564-66.
2) Jonathan Schell, The Fate of the Earth (New York: Alfred A. Knopf, 1982), p. 119.
3) Cfr. Noel Perrin, Giving Up the Gun: Japan’s Reversion to the Sword, 1543-1879 (Boston: G.K. Hall and Company, 1979), vii.
4) Ibidem, p. 93.
5) Ibidem, p. 104.
6) George F. Kennan, The Nuclear Delusion: Soviet-American Relations in the Nuclear Age (New York: Pantheon Books, 1983), p. 178.
7) L’autore ha presentato all’Assemblea generale dell’ONU, alle sessioni speciali sul disarmo: Una proposta in dieci punti per il disarmo nucleare (22 maggio 1978); Proposte per il disarmo e l’abolizione delle armi nucleari (3 giugno 1982); Un movimento globale per il disarmo totale (1 giugno 1988).
8) Kofi Annan, The Causes of Conflict and the Promotion of Durable Peace and Sustainable Development in Africa, rapporto delle Nazioni Unite, aprile 1988.
Ringrazio tutti coloro che avranno avuto la voglia di leggersi per intero questo libro (o di ascoltarlo con gli mp3) e che si stanno impegnando a riformare se stessi per costruire un mondo migliore,
Francesco Galgani,
23 agosto 2016
