Il nucleare civile è antieconomico, una truffa a danno della collettività
Nella mia intervista di ieri “Un’alternativa alla IA (che non è nostra amica)”, ho sostenuto che l’energia elettrica prodotta da centrali atomiche per uso civile è antieconomica, che è una truffa a danno della collettività, e che esiste solo perché l’impresa e i profitti privati sono coperti dai soldi pubblici. Ho anche accennato che lo scopo ultimo del nucleare civile è comunque militare.
Colgo l’occasione di aver toccato ieri questo argomento per approfondirlo adesso.
La tesi secondo cui le centrali nucleari per uso civile siano fondamentalmente antieconomiche si basa su un’analisi approfondita delle voci di costo che, per diverse ragioni, vengono spesso trasferite (“esternalizzate”) dalla società proprietaria dell’impianto al settore pubblico, quindi ai contribuenti. Proviamo a suddividere la questione in alcuni punti chiave:
1. Costo di costruzione e ritardi
• Investimento iniziale elevato: La costruzione di una centrale nucleare richiede investimenti di capitale molto alti, spesso nell’ordine di diversi miliardi di euro, e tempi di realizzazione lunghi (anche oltre un decennio). Ciò si traduce in forti oneri finanziari a causa degli interessi sul capitale investito.
• Rischio di costi extra e sforamenti di budget: È frequente che i progetti di centrali nucleari subiscano ritardi e lievitazioni dei costi durante la costruzione. Esempi noti includono progetti in Francia (Flamanville) e Finlandia (Olkiluoto), dove i costi previsti sono aumentati notevolmente rispetto alle stime iniziali. Quando ciò accade, spesso intervengono i governi o i soggetti pubblici per coprire i costi eccedenti, perché la mancanza di sostegno pubblico porterebbe a blocchi o fallimenti del progetto.
2. Copertura assicurativa e responsabilità civile
• Rischio di incidenti: Un incidente in una centrale nucleare può avere conseguenze potenzialmente molto gravi e durature. I danni economici (e umani) possono essere enormi, come visto in passato con Chernobyl (1986) o Fukushima (2011).
• Garanzie statali sulla responsabilità: Le compagnie private raramente possono coprire interamente la responsabilità di un incidente nucleare attraverso assicurazioni sul mercato libero, perché i premi assicurativi sarebbero altissimi. Spesso, quindi, gli Stati stabiliscono dei limiti alla responsabilità legale o forniscono essi stessi delle forme di garanzia per coprire i potenziali danni; questo si traduce in un “sussidio implicito” alla produzione di energia nucleare.
3. Gestione delle scorie radioattive
• Alti costi di stoccaggio a lungo termine: I rifiuti nucleari, specialmente quelli ad alta radioattività, devono essere stoccati in condizioni di sicurezza per tempi che superano di gran lunga la durata della vita dell’impianto (centinaia o addirittura migliaia di anni). La ricerca di siti di stoccaggio idonei, la loro messa in sicurezza e il controllo costante richiedono ingenti risorse.
• Trasferimento dei costi ai governi: Spesso le società che gestiscono le centrali non incorporano appieno nei propri bilanci tutti i costi di stoccaggio a lunghissimo termine. In molti Paesi, esistono fondi pubblici o partecipati dallo Stato che si occupano (o si occuperanno in futuro) della fase finale di smaltimento. Questo alleggerisce la singola azienda da un onere così dilatato nel tempo e di incerta quantificazione economica, spostandolo sulla collettività.
4. Decommissioning (smantellamento a fine vita)
• Smantellamento costoso e complesso: Il decommissioning di una centrale nucleare è un processo tecnicamente impegnativo e può durare decenni. Anche qui, i costi possono superare le stime originarie e raggiungere cifre molto rilevanti.
• Sussidi diretti o indiretti: Di frequente, per coprire il decommissioning, vengono costituiti fondi alimentati dalle stesse aziende ma spesso insufficienti o basati su stime ottimistiche. Nel caso di emergano ulteriori costi, è ancora lo Stato a intervenire. Esistono anche esempi di centrali in cui la proprietà è passata a società statali proprio per gestire la fase di smantellamento, socializzandone i costi.
5. Concorrenza sul mercato dell’energia
• Costi comparati: Se si confronta il costo “tutto compreso” di un kWh di energia da fonte nucleare con quello derivante da altre fonti (rinnovabili, ma anche fossili), risulta che il nucleare è competitivo solo quando:
1. Vengono omesse o minimizzate voci come assicurazione, stoccaggio delle scorie e decommissioning.
2. Lo Stato garantisce un prezzo di vendita dell’energia (o sussidi diretti/indiretti), riducendo il rischio per l’investitore privato.
• Mercato e prezzi garantiti: In alcuni casi, i governi stipulano contratti di “price floor” o “contract for difference” (ad esempio il caso di Hinkley Point C nel Regno Unito), ossia assicurano un prezzo minimo di acquisto dell’energia prodotta dalla centrale. Se il prezzo di mercato scende al di sotto di tale soglia, la differenza viene coperta con fondi pubblici. Questo meccanismo è un ulteriore modo per rendere appetibile l’investimento privato, spostando sullo Stato parte del rischio di mercato.
6. Impatto ambientale e sanitario a lungo termine
• Danni potenziali all’ambiente: Un incidente o la gestione errata delle scorie può causare contaminazioni difficilmente quantificabili e da bonificare in modo estremamente dispendioso. Spesso questi rischi non sono interamente contabilizzati nei costi delle imprese elettriche, perché i danni all’ambiente, alla salute pubblica o all’agricoltura verrebbero coperti, in gran parte, da fondi nazionali.
• Effetto sul territorio: In termini di percezione del rischio e ricadute sulla popolazione, è difficile mettere una cifra su possibili esodi, calo dei valori immobiliari, perdita di produttività agricola in aree eventualmente colpite da fughe radioattive. Questo costo ricade in ultima istanza sulla comunità.
Riassunto dei problemi economici
1. Struttura dei costi e rischio di insolvenza: Gli altissimi costi iniziali, le incertezze sui tempi di costruzione, le coperture assicurative parziali e il problema delle scorie portano a un rischio finanziario enorme per qualsiasi operatore privato. Senza il supporto o la garanzia statale, molte società non avrebbero la forza di sostenere tali progetti.
2. Esternalizzazione dei costi: Gran parte delle spese correlate alla sicurezza, allo smaltimento delle scorie e allo smantellamento, così come i potenziali costi di un incidente grave, non vengono contabilizzati interamente nelle normali logiche di mercato ma vengono sostenuti (o si prevede che saranno sostenuti) con denaro pubblico. Questo riduce artificialmente il costo apparente dell’energia nucleare e ne fa sembrare la produzione più conveniente di quanto sarebbe se l’industria dovesse internalizzare tutte le spese.
3. Confronto con altre tecnologie: Mentre le fonti rinnovabili (come solare ed eolico) hanno beneficiato, in passato, di sussidi e incentivi, la loro curva dei costi è costantemente in diminuzione e i rischi di impatto ambientale sono notevolmente più contenuti. Per il nucleare, invece, i rischi e le complessità restano alti, e i costi (a lungo termine) non mostrano tendenze di riduzione altrettanto marcate.
4. Discussione politica ed economica: Se il costo reale del nucleare fosse interamente internalizzato — ovvero se le aziende dovessero pagare da sole per assicurarsi a livelli adeguati, finanziare completamente lo smantellamento e lo stoccaggio delle scorie, risarcire le comunità o gli Stati in caso di incidente — è probabile che gli investimenti privati si ridurrebbero drasticamente, rendendo il nucleare ancora più marginale sotto il profilo economico.
In sintesi, la redditività apparente del nucleare si basa su meccanismi di supporto pubblico e su un trasferimento parziale dei rischi e delle spese all’intera collettività. Se tali costi fossero internalizzati, l’energia nucleare difficilmente potrebbe competere, a parità di condizioni, con fonti energetiche che presentano rischi e oneri di lungo periodo molto inferiori.
Propedeuticità del nucleare civile a quello militare
Un ulteriore aspetto spesso sottovalutato, ma di grande rilevanza geopolitica, è la stretta correlazione tra il nucleare civile e quello militare. Sebbene i reattori per la produzione di energia elettrica abbiano finalità pacifiche, le conoscenze tecniche, le infrastrutture e, in alcuni casi, le materie prime utilizzate (ad esempio l’uranio arricchito) possono essere sfruttate anche per sviluppare armamenti atomici. La storia dimostra come diversi Paesi abbiano utilizzato il settore nucleare civile come “copertura” o trampolino di lancio per acquisire le competenze necessarie alla realizzazione di ordigni nucleari, dedicando poi appositi impianti (come i reattori che producono plutonio di grado militare) allo scopo di costruire la bomba atomica.
In molti programmi nucleari nazionali, quindi, il segmento “civile” è strettamente legato (o almeno complementare) al potenziamento di eventuali capacità militari. Ciò non solo accresce i costi e le implicazioni di sicurezza (perché la tecnologia sensibile deve essere protetta da possibili appropriazioni indebite), ma può anche innescare tensioni internazionali, spinte alla proliferazione e un aumento della diffidenza reciproca tra Stati. La distinzione tra un programma energetico puramente pacifico e uno con finalità belliche è quindi molto sottile.
In aggiunta, come precedentemente accennato, non si tratta esclusivamente di un trasferimento di conoscenze o di competenze tecniche: il materiale nucleare utilizzato negli impianti civili può effettivamente essere “dirottato” verso fini militari. Il combustibile usato nei reattori a scopi energetici, infatti, contiene isotopi di uranio e plutonio che, se opportunamente lavorati (ad esempio attraverso processi di arricchimento o di ritrattamento), possono essere impiegati per la fabbricazione di ordigni nucleari. Ciò rende il controllo e la messa in sicurezza di tali materiali di importanza critica, poiché un eventuale sfruttamento illecito (da parte di gruppi o governi) comporterebbe gravi rischi di proliferazione e minacce alla stabilità internazionale.
La presenza di reattori civili, quindi, non solo fornisce a un Paese competenze tecnico-scientifiche utili all’eventuale sviluppo di un programma militare, ma mette anche a disposizione materie prime (o semilavorate) dalle quali è più facile ricavare, in tempi e costi relativamente ridotti, sostanze fissili impiegabili in ordigni bellici. Questo intreccio tra nucleare civile e militare può essere quindi il vero motivo a sostegno della propaganda a favore del nucleare civile.
(26 gennaio 2025)

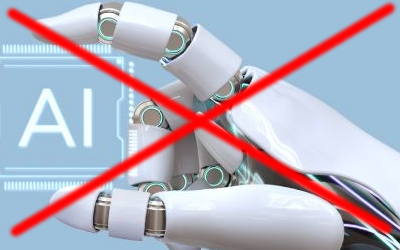 P.S: Questo testo è privo di contenuti generati dall'Intelligenza artificiale.
P.S: Questo testo è privo di contenuti generati dall'Intelligenza artificiale.