Avvertenza: per approfondire i termini sanscriti e pali, suggerisco l'ottima Encyclopedia of Buddhism
Sebbene "rinascita" e "reincarnazione" possano sembrare sinonimi, nel contesto buddista hanno significati sottilmente diversi.
"Reincarnazione" è un termine più comune nelle tradizioni induiste e in altre religioni, dove si crede che un’anima individuale e permanente passi da un corpo a un altro attraverso le vite. In altre parole, c'è un’idea di un’identità fissa e permanente che si reincarna.
La "rinascita", nel buddismo, è più complessa, perché non si fonda sull’idea di un’anima individuale e immutabile che trasmigra da un corpo all’altro. Al contrario, poggia sulla visione della vacuità e del non-sé (anatta in pali, anātman in sanscrito), secondo cui nulla esiste in maniera autonoma, indipendente e permanente. È per questo che, pur riconoscendo il fenomeno della rinascita, il buddismo afferma che non vi è un “qualcuno” che si reincarna in senso sostanziale. Tale prospettiva, elaborata e chiarita in modo decisivo da grandi maestri come Nagarjuna, sottolinea la totale interdipendenza di tutti i fenomeni e l’assenza di un’entità fissa o sostanziale che perduri di vita in vita.
Nel buddismo, la morte e la nascita sono considerate due poli di un processo continuo regolato dal principio di causa ed effetto, in cui il karma, ovvero le azioni intenzionali di un individuo, determina le sue future esperienze.
Alla morte, il complesso psicofisico di cui è costituita l’esistenza di un individuo, formato dai cosiddetti “cinque aggregati” (forma fisica, sensazioni, percezioni, formazioni mentali, coscienza), si disgrega.
I cinque aggregati (skandha) rappresentano gli elementi costitutivi dell’esistenza umana e, nel loro insieme, descrivono come sorge l’illusione di un “io” separato. Primo è l’aggregato della forma fisica (rūpa), che comprende il corpo e i suoi aspetti materiali. Secondo è quello delle sensazioni (vedanā), ossia le esperienze piacevoli, spiacevoli o neutre che emergono nel contatto con il mondo. Terzo è l’aggregato della percezione (saṃjñā), attraverso cui si riconoscono e si etichettano gli oggetti dell’esperienza. Quarto è quello delle formazioni mentali (saṃskāra), ovvero le abitudini, le spinte volitive, le intenzioni e i condizionamenti della mente. Quinto è l’aggregato della coscienza (vijñāna), che registra e conosce i fenomeni presenti. Questi cinque aspetti non sono entità statiche, ma processi in costante trasformazione, che interagiscono tra loro e con le circostanze esterne.
Non è corretto immaginare che un’anima si stacchi dal corpo e voli altrove al momento della morte. Piuttosto, si dissolve l’assetto specifico degli aggregati che costituivano l’individuo in quella particolare vita, mentre rimane un flusso di condizionamenti, tendenze e risultati karmici in attesa di manifestarsi.
Questa transizione non implica l’esistenza di un “sé” incapsulato o separato, bensì la continuità di impulsi ed energie che, una volta trovate le condizioni adatte, daranno origine a una nuova combinazione di aggregati, ossia a una nuova vita. È come la fiamma di una candela che ne accende un’altra: la seconda fiamma non è la stessa della prima, ma dipende causalmente dalla prima. Ciò che si trasmette è il fuoco, non un nucleo identico e immutabile. Ma il fuoco della rinascita ha bisogno di nutrimento, di "brama":
“Maestro Gotama, quando un essere ha deposto questo corpo ma non è ancora rinato in un altro corpo, cosa dichiara il Maestro Gotama essere il suo nutrimento in quell’occasione?”
“Quando, Vaccha, un essere ha deposto questo corpo ma non è ancora rinato in un altro corpo, io dichiaro che è alimentato dalla brama. Perché in quell’occasione la brama è il suo nutrimento.”
(tratto da: SN 44.9: Kutūhalasālā Sutta)
Nel buddismo, taṇhā (pali) o tṛṣṇā (sanscrito) è comunemente tradotta come brama, sete o desiderio smodato. È uno degli elementi fondamentali della Seconda Nobile Verità, ovvero l'origine della sofferenza (dukkha), ed è considerata il principale motore del samsara (il ciclo di nascita, morte e rinascita).
La brama è di tre tipi principali:
- Kāma-taṇhā → il desiderio di piaceri sensoriali (piacere visivo, uditivo, gustativo, tattile, mentale).
- Bhava-taṇhā → il desiderio di esistenza, di diventare qualcosa o qualcuno (attaccamento alla vita, alla personalità, al sé).
- Vibhava-taṇhā → il desiderio di annichilimento o non-esistenza (il rifiuto dell’esistenza, il desiderio di cessare di esistere come fuga dalla sofferenza).
La brama è strettamente legata al concetto di attaccamento (upādāna) e, secondo il paticca-samuppāda (origine dipendente), porta alla rinascita.
Nel Kutūhalasālā Sutta (SN 44.9) precedentemente citato, il Budda spiega a Vacchagotta che tra la morte e la rinascita di un essere, la sua "nutrizione" è la brama. Questo indica che la forza che spinge la coscienza a rinascere è il desiderio di continuare ad esistere e di ottenere nuove esperienze. In altre parole, anche dopo la morte, se non c'è stato un completo abbandono della brama, la coscienza, condizionata dal karma, cercherà una nuova forma di esistenza.
Quando un essere elimina completamente la brama, raggiunge il Nibbāna (o Nirvana), uno stato in cui non vi è più continuazione del ciclo di rinascite. Questo è il significato della "liberazione" (mokṣa) nel buddismo: non rinascere più perché non c’è più nulla che "spinga" la coscienza a cercare un nuovo corpo.
L’Arhat è colui che si concentra sulla propria liberazione personale, seguendo l'insegnamento del Budda per mettere fine al proprio soffrire e non rinascere più.
Il Mahāyāna, sviluppatosi a partire dal I secolo a.C., considera l’ideale dell’Arhat "incompleto" o "inferiore" rispetto all’ideale del Bodhisattva. Il Bodhisattva è un essere che ha rinunciato alla propria entrata nel Nibbāna definitivo per rimanere nel saṃsāra (ciclo di nascita e morte) e aiutare tutti gli esseri senzienti a liberarsi dalla sofferenza.
Nel Mahāyāna, il Bodhisattva è colui che sviluppa la Bodhichitta, il desiderio compassionevole di liberare tutti gli esseri senzienti. Egli pratica le Sei Perfezioni (Pāramitā):
- Dāna (generosità) – aiutare gli altri senza aspettarsi nulla in cambio.
- Śīla (disciplina morale) – osservare una condotta etica impeccabile.
- Kṣānti (pazienza) – accettare le difficoltà senza reagire con rabbia.
- Vīrya (energia, sforzo gioioso) – impegnarsi costantemente nel Dharma.
- Dhyāna (meditazione) – coltivare la concentrazione e la saggezza.
- Prajñā (saggezza trascendentale) – comprendere la vacuità (śūnyatā).
L'ideale del Bodhisattva nel Mahāyāna non nega la mokṣa (liberazione), ma la trasforma in un cammino altruistico. Il Bodhisattva non fugge dal mondo ponendo fine alle sue rinascite, ma si immerge in esso per aiutare tutti gli esseri a risvegliarsi. Questa è una differenza chiave rispetto al modello più individualistico dell’Arhat.
Ricapitolando, quando parliamo di “rinascita” non facciamo riferimento alla sopravvivenza di un’anima eterna, bensì a un continuum di cause e condizioni che, nel momento della morte, trasmette i suoi effetti a un nuovo insieme di aggregati, dando vita a una nuova esistenza. Da questa prospettiva, è corretto affermare che, secondo la visione di Nagarjuna, esistono la rinascita e il karma, ma non esiste un soggetto permanente che si reincarna.
L’assenza di un sé sostanziale non esclude però la responsabilità morale, poiché il flusso di azioni, intenzioni e conseguenze non va perduto: ogni atto, compiuto con una certa motivazione, getta i semi per esperienze future, che maturano quando le condizioni diventano favorevoli. Questo è il senso profondo della legge karmica: l’io che agisce oggi non è lo stesso che raccoglierà i frutti, ma neppure del tutto diverso. Vi è una continuità che non coincide con un “qualcuno”, ma con un flusso causale interdipendente.
All’interno delle narrazioni tradizionali sul Budda, troviamo numerosi racconti di vite precedenti: nel caso di Shakyamuni, si racconta ad esempio della sua esistenza come “Mai Sprezzante”, in cui coltivò la qualità della riverenza verso tutti gli esseri, anticipando quella profonda compassione che avrebbe poi perfezionato come Budda. Tali episodi non vogliono avallare la credenza in un’anima trasmigrante, bensì illustrare l’importanza di un lungo percorso di purificazione e pratica, volto a maturare la saggezza e la compassione necessarie all’illuminazione. La storia di “Mai Sprezzante” e altre simili intendono mostrare come determinati atteggiamenti, portati avanti per molte vite, gettino le basi per il risveglio.
Il processo di morte e rinascita, specialmente in alcune scuole del buddismo come il Vajrayana (buddismo tantrico) tibetano, viene descritto con grande dettaglio. Si parla di stati intermedi, comunemente chiamati “bardo”, in cui la coscienza, non più vincolata a un corpo fisico, sperimenta varie visioni e fenomeni mentali che riflettono la propria natura interiore. Anche in questo contesto, tuttavia, l’insegnamento di fondo rimane lo stesso: non vi è un sé permanente, ma un flusso di tendenze e percezioni che emergono e svaniscono a seconda delle cause e delle condizioni. La funzione principale di questi insegnamenti più analitici consiste nell’aiutare i praticanti a prepararsi al momento della morte e a orientare la mente in modo virtuoso, affinché le condizioni per la rinascita siano il più possibile favorevoli al cammino verso l’illuminazione.
Prima di concludere, vorrei riflettere sul significato della parola "coscienza" nel buddismo (in sanscrito vijñāna): non indica un’entità, ma un processo dinamico. È come un fiume che scorre: l’acqua cambia continuamente, ma il flusso mantiene una coerenza temporanea. Alla morte, l’ultimo momento di coscienza (maranāsanna-vijñāna) funge da ponte karmico verso una nuova esistenza, senza che nulla di sostanziale "passi" da un corpo all’altro.
Ricapitolando, il buddismo nega l’anima (anātman) ma ammette la rinascita (saṃsāra). C'è la rinascita, ma non c'è un "soggetto" permanente che rinasce. Non esiste un "io" fisso che rinasce, però non tutto svanisce nel nulla: c’è una continuità di cause, condizioni e risultati.
(2 febbraio 2025)

.jpg)
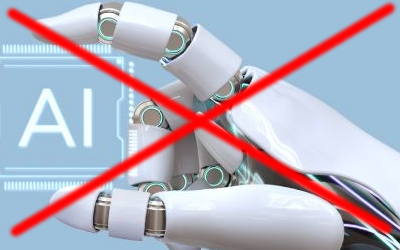 P.S: Questo testo è privo di contenuti generati dall'Intelligenza artificiale.
P.S: Questo testo è privo di contenuti generati dall'Intelligenza artificiale..jpg)